
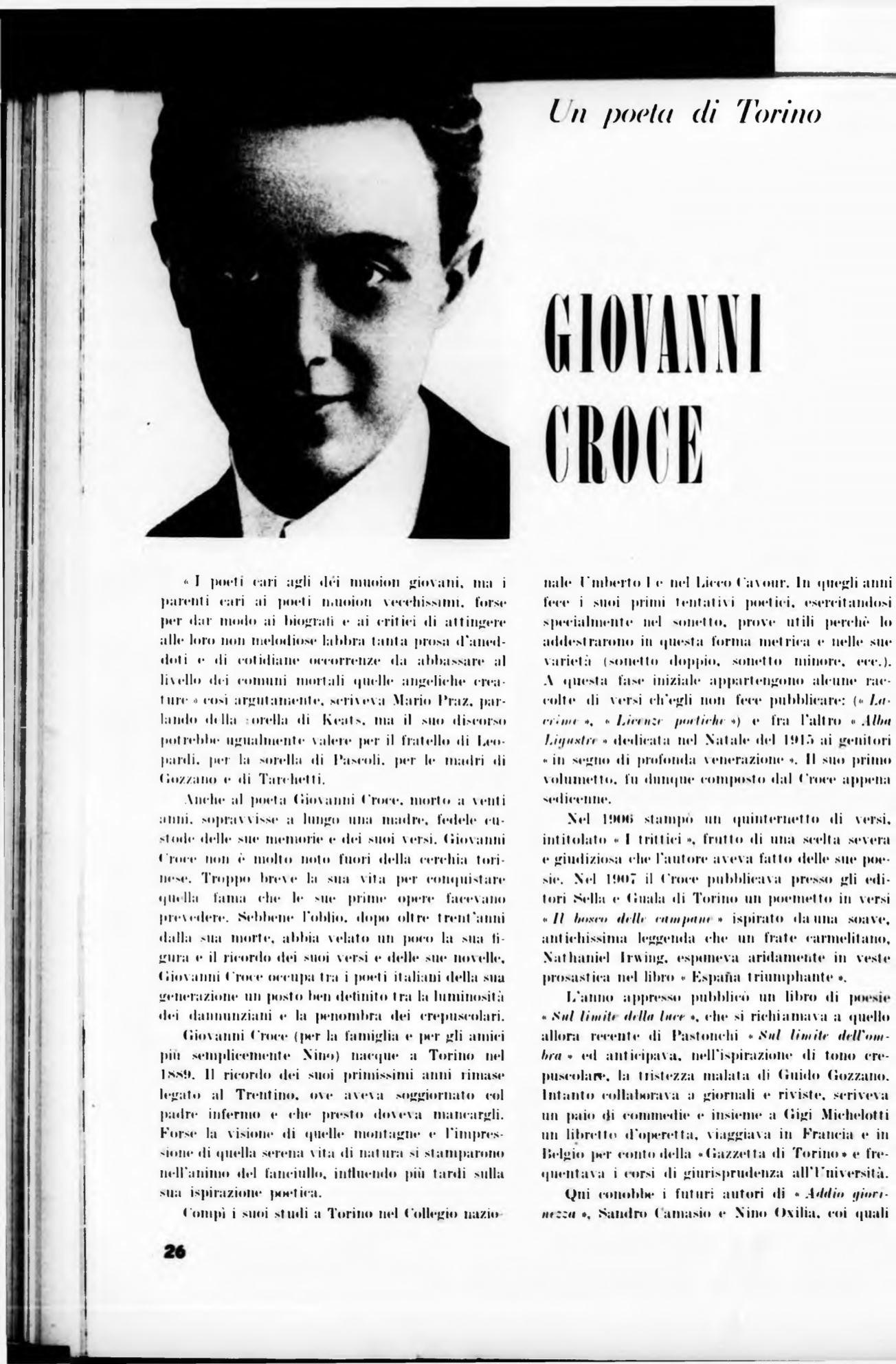
L
//
pochi di Torino
itali* Ciliberto |«* ni‘1 lijrco Cavour. In «|ii«*gli anni
f«*c«* i suoi jirimi tentativi poetiti, esercitandosi
specialmente nel sonetto, prove utili perchè lo
addestrarono in questa forma metrica e nelle sue
varietà (sonetto «loppio, sonetto niinort*. «*«*«•.).
A «|ii«*sta fax* iniziale appartengono alcuni* rac-
c«»lt«* «li v«*rsi ch'egli utili f«*c«* pubblicare: (<■/.«/-
n 'ìiiif *, < LinnZf /mftirhf •>) «* fra l'altro « Alhtl
Lii/itstr» • dedicala n«*l Natale del liti.'» ai "«-nitori
«in segno di profonda venerazione*. Il suo primo
v«>luinctt«». fu diin«|U«* composto «lai Cr«>«*«* app«*na
sedicenne.
N«*l 1 IMM» stampo un «|uiutcrn«*tto «li versi,
intitolato « I trittici ». frutto ili una scelta severa
«* giudiziosa ch«* l'autore aveva fatto «Ielle sin* poe-
si«*. Nel 1!MI7 il Croce pubblicava presso gli «-«li-
tori Sella «- (Inala «li Torino un poemetto in v«*rsi
« II boxai tifile fimi/nini » ispirato «la una soave,
antichissima leggenda ch«* un frate carmelitano,
Nat ballici 1rw ing. »*sp«m«*va aridamente in v«*st«*
prosastica n«*l libro « Kspana triuniphante *.
L'anno appressi» pubblicò un libro «li p«
«• Sul limiti tifila htff
*.
«-he si richiamava a
«|U«*II«»
all«»r.i r«*«*«*ut«• di Pastonchi * Sul lim itf tlfll'nm-
hra * «*«1 anticipava. ndl'ispirazione «li tono cre-
puscohm*. la tlistezza malata «li («nido (Sozzano,
lutanti» «-«dlalMirava a giornali e riviste, wriveva
un paio di c<»n)ni«‘<lie «* insieme a ( ligi Michelotti
un li!»r«-tlo «r<»|H-retta, viaggiava in Francia «* in
lielgio p«-r conto della «(ìazzetta «li Torino* e fr«*-
«liientava i ««irsi «li giurispnnleiiza a ll'l’uiversità.
Qu i c«»n«»bl»e i futuri autori di * Atiditt yiort-
tuzzu ». Sandro ( amasio e Nino Oxilia. coi «piali
< I poeti «ari agli «lei muoioii giovani, ma i
parenti «-ari ai poeti n•uoi«»u v«*c«*hissnni. forse
p«*r dar modo ai biograti «• ai eriti«*i «li atting«*r«*
alle loro non melodi«»sc labbra tanta prosa «l'am-d-
d«>ti «• di cotidiam* occorr«-nz«- «la abbassare al
livelli» dei comuni mortali quell** angeliche crea
ture ■>cosi argutam«‘i)tc, scriveva Mario Praz, par
lando d illa -iirella di Kcats. ma il suo discorso
potrebbi* ugualmente valere per il fratello di I m
parili. per la sorella di
P a s c o l i .
p«-r l«- madri di
(ìozzaito «* di Tarchetti.
Anche al poeta (liovanni (>«»«-«-. morto a venti
anni, sopravvisse a lungo una madre, fedele cu
s t o d e
«Ielle sue ineni«»rie «• dei suoi v«*rsi. (ìiovaillli
Croce non è molto noto fuori «Iella cerchia t«»ri-
ncs«-.
Troppo breve la sua vita per conquistare
«Iu« Ila fama che le sue prime opere facevano
prevedére. Sebbene l'oblio. d«»po oltre treUt'amii
dalla sua morte, abbia velato un poco la sua ti-
gura «• il ricordo «l«*i suoi v«*rsi «• d«-||«- su«* novelle,
(liovanni Croce occupa tra i po«-ti italiani «l«-lla sua
generazione un posto b«*n detinito tra la luminosità
dei dannunziani e la peiiombra «lei crepuscolari.
(liovanni Croce (p«*r la famiglia e per gli amici
più semplicemente Nino) nacipic a Torino nel
issi».
Il ri«*ordo dei suoi primissimi anni rimase
l«*gato al Trentino. «»v«- aveva s«»ggiornato col
padre infermo e che presto doveva mancargli.
Ktirse la visione di quelle montagne e l'impres-
si«un* di quella ser«*na vita «li natura si stamparono
neiraiiinio del fanciullo, influendo più tardi sulla
sua ispirazione |»octicu.
Compì i simi stuili a Turila» nel Collegio nazio


















