
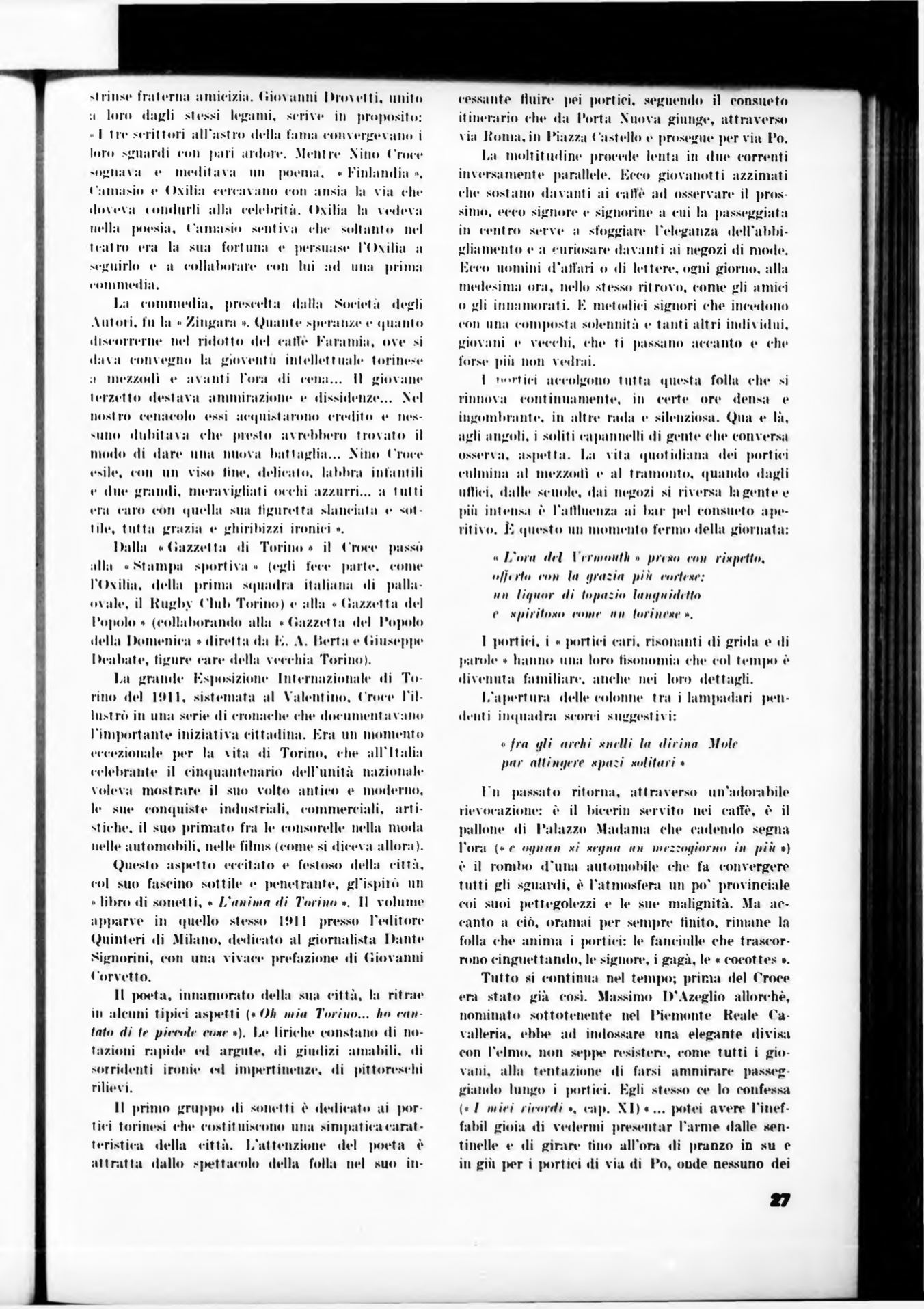
strinse fraterna am icizia, G iovanni
1
)r»»\etti, imito
a loro dagli stessi legumi, scrive in proposito:
>■ I tre scrittori a ll'astro «Iella fama convergevano i
loro sguardi con pari ardore. Mentre Nino Croce
sognava c m ed itava un poema. « Finlandia »,
('amasio <• Oxilia cercavano con ansia la via che
doveva (ondarli alla celebrità. Oxilia la vedeva
nella poesia, ('amasio sentiva clic soltanto nd
teatro era la sua fortuna e persuase l'O x ilia a
seguirlo e a collaborarc con lui ad una prima
commedia.
La comm ed ia, prescelta dalla Società degli
Autori, fu la «Zingara ». Quante speranze e (pianto
discorrerne nel ridotto del calìe Faram ia, ove si
dava convegno la gioventù intellettuale torinese
a mezzodì e avan ti l'ora «li cena... Il giovane
terzetto destava ammirazione e dissidenze... Nel
nostro cenacolo essi acquistarono credito e nes
suno dub itava che presto avrebbero tro va to il
modo di dare una nuova ba ttag lia ... Nino Croce
esile, con un viso line, delicato, labbra infantili
e due grand i, meravigliati occhi azzurri... a tutti
era caro con quella sua liguretta slanciata e sot
tile, tu tta grazia e ghiribizzi ironici ».
Dalla «G a zze tta di Torino» il Croce passò
alla «Stampa spo rtiva» (egli fece parte, come
l'Ox ilia , della prima squadra italiana di palla-
ovale, il Rugby C lub Torino) c alla « (ìazze tta del
Popolo» (collaborando alla « (ìazze tta del Popolo
della Domenica «d iretta da K. A. lierta c Giuseppe
Deabate, ligure care della vecchia Torino).
La grande Fsposizionc Internazionale di T o
rino del UH I, sistemata al Valentino, Croce l'il-
lustrò in una serie di cronache che documentavano
l'importan te in iziativa cittad ina. Fra un momento
eccezionale per la vita di Torino, che a ll'Ita lia
celebrante il einquantenurio de ll'un ità nazionale
voleva mostrare il suo vo lto antico e moderno,
le sue conqu iste industriali, commerciali, arti-
stielle, il suo primato fra le consorelle nella moda
nelle automobili, nelle films (come si diceva allora).
Questo aspe tto eccitato e festoso della città ,
col suo fascino sottile e penetrante, gl'ispirò un
« libro di sonetti, «
L 'an ima ili Torino
». Il volume
apparve in quello stesso UHI presso l'ed itore
Quinteri di Milano, dedicato al giornalista Dante
Signorini, con una vivace prefazione di G iovanni
Corvetto.
Il
poeta, innamorato della sua città , la ritrae
in alcuni tip ici asjietti
(* Oh mia Torino... ho can
tati» d i te piem ie cose
»). Le liriche constano di no
tazioni rapide ed argute, di giudizi amabili, di
sorridenti ironie ed impertinenze, di pittoreschi
rilievi.
Il
primo gruppo di sonetti è dedicato ai in s
tici torinesi che costituiscono una simpatica c a ra t
teristica della città . L 'attenzione del poeta è
a ttra tta dallo spettacolo della folla nel suo in
cessante fluire pei portici, seguendo il consueto
itinerario che da Porta Nuova giunge, attraverso
via Monta,in Piazza Castello e prosegue p e rv ia Po.
La moltitudine procede lenta in due correnti
inversamente parallele. Ecco giovanotti azzimati
che sostano davanti ai calìe ad osservare il pros
simo, ecco signor»* e signorine a cui la passeggiata
in centro serve a sfoggiare l'eleganza dell'abbi-
gliamento e a curiosare davanti ai negozi di mode.
Kcco uomini d'affari o di lettere, ogni giorno, alla
medesima ora, nello stesso ritrovo, come gli amici
o gli innamorati. K metodici signori che incedono
con una composta solennità e tan ti altri individui,
giovani e vecch i, che ti passano accanto e che
forse piii non vedrai.
I
to rtici accolgono tutta questa folla che si
rinnova continuamente, in certe ore densa e
ingombrante, in altre rada c silenziosa. Qua e là,
agli angoli, i soliti capannelli di gente che conversa
osserva, aspetta . La vita quotidiana dei portici
culmina al mezzodì c al tramonto, quando dagli
urtici, dalle scuole, dai negozi si riversa la gente e
più intensa è l'attinenza ai bar pel consueto ape
ritivo. ]•' questo un momento fermo della giornata:
«
l'o r a dei
I
ermouth
»
presto con rispetto
,
off» rio con la grazia piìi cortese:
un liquor ili topazio lauguidetto
e spiritoxo come
id i
torinese ».
1
portici, i « portici cari, risonanti di grida e di
parole » hanno una loro tisonomia che col tempo è
divenuta familiare, anche nei loro dettagli.
L 'apertura delle colonne tra i lampadari pen
denti inquadra scorci suggestivi:
«
fra i/li archi snelli la il ir ili a Mole
par attingere spazi solitari
»
l'n passato ritorna, attraverso un ’adorabile
rievocazione: è il bicerin servito nei caffè, è il
pallone di Pa lazzo Madama che cadendo segna
l'ora («
e ognun s i segna mi mezzogiorno in p iù
»)
è il rombo d 'una automobile che fa convergere
tutti gli sguardi, è l'atmosfera un po' provinciale
coi suoi pettegolezzi e le sue malignità. Ma a c
canto a ciò, oramai per sempre finito, rimane la
folla che anima i portici: le fanciulle che trascor
rono cinguettando , le signore, i gagà, le « cocottes ».
Tu tto si continua nel tempo; prima del Croce
era stato già così. Massimo D 'A zeg lio allorché,
nominato sottotenente nel Piemonte Reale C a
valleria. ebl»e ad indossare una elegante d ivisa
con l'elmo, non seppe resistere, come tu tti i g io
vani, a lla tentazione di farsi ammirare passeg
giando lungo i portici. Fgli stesso ce lo confessa
(« /
miei ricordi
», cap. X I ) « ... potei aver*1 l'inef-
fabil gioia «li vedermi presentar l'arme «lalle sen
tinelle e «li girare tino all'ora «li pranzo in su e
in giù ]>er i portici «li via di Po, oude nessuno dei
27


















