
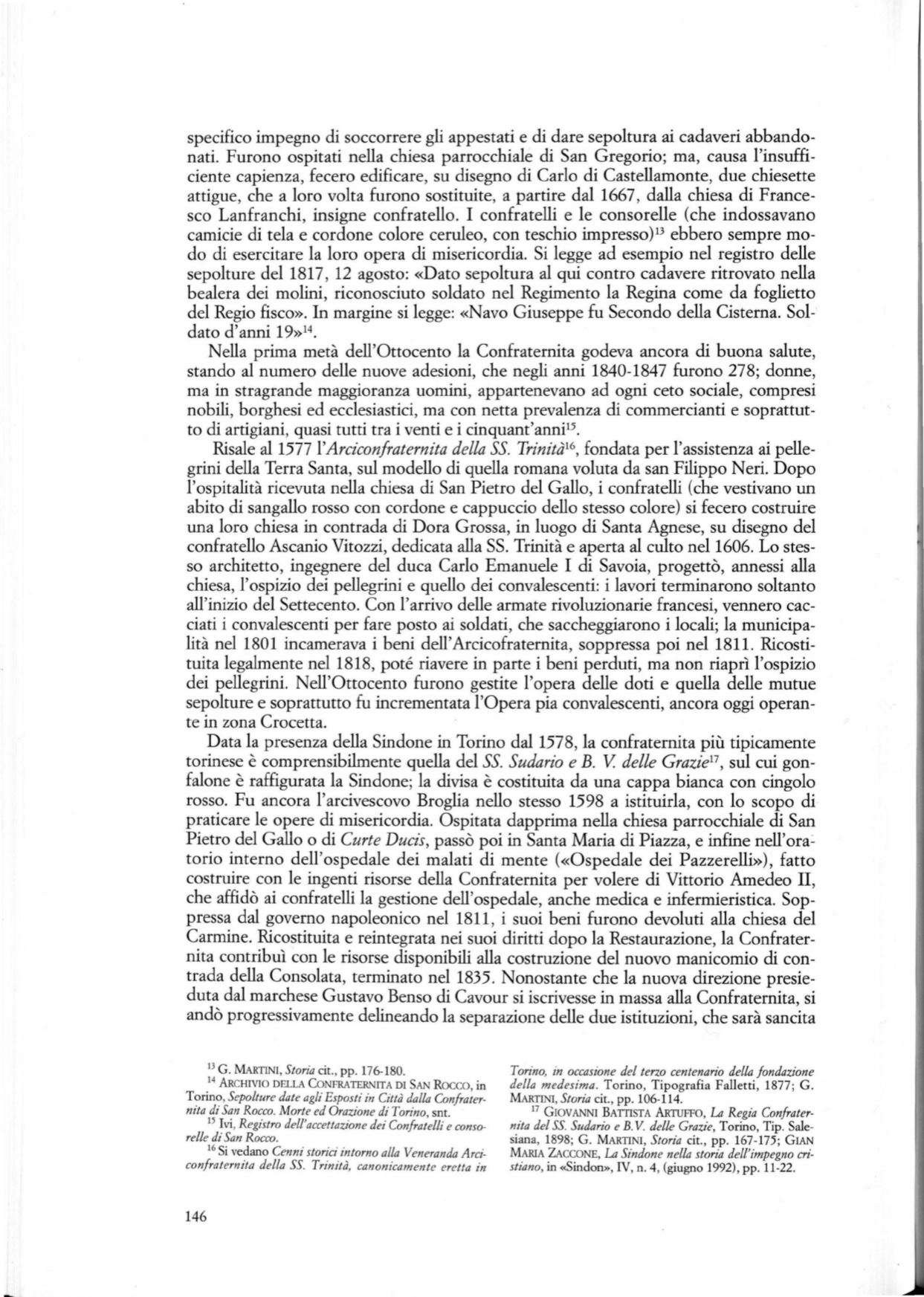
specifico impegno di soccorrere gli appestati e di dare sepoltura ai cadaveri abbando–
nati. Furono ospitati nella chiesa parrocchiale di San Gregorio; ma, causa l'insuffi–
ciente capienza, fecero edificare, su disegno di Carlo di Castellamonte, due chiesette
attigue, che a loro volta furono sostituite, a partire dal 1667, dalla chiesa di France–
sco Lanfranchi, insigne confratello. I confratelli e le consorelle (che indossavano
camicie di tela e cordone colore ceruleo, con teschio impresso) 13 ebbero sempre mo–
do di esercitare la loro opera di misericordia. Si legge ad esempio nel registro delle
sepolture del 1817 , 12 agosto: «Dato sepoltura al qui contro cadavere ritrovato nella
bealera dei molini, riconosciuto soldato nel Regimento la Regina come da foglietto
del Regio fisco». In margine si legge: «Navo Giuseppe fu Secondo della Cisterna. Sol–
dato d' anni 19»14.
Nella prima metà dell'Ottocento la Confraternita godeva ancora di buona salute,
stando al numero delle nuove adesioni, che negli anni 1840-1847 furono 278; donne,
ma in stragrande maggioranza uomini, appartenevano ad ogni ceto sociale, compresi
nobili, borghesi ed ecclesiastici, ma con netta prevalenza di commercianti e soprattut–
to di artigiani, quasi tutti tra i venti e i cinquant'anni
15 •
Risale al 1577
l'Arciconfraternita della
Ss.
Trinità
l6 ,
fondata per l'assistenza ai pelle–
grini della Terra Santa, sul modello di quella romana voluta da san Filippo Neri. Dopo
l'ospitalità ricevuta nella chiesa di San Pietro del Gallo, i confratelli (che vestivano un
abito di sangallo rosso con cordone e cappuccio dello stesso colore) si fecero costruire
una loro chiesa in contrada di Dora Grossa, in luogo di Santa Agnese, su disegno del
confratello Ascanio Vitozzi, dedicata alla SS. Trinità e aperta al culto nel 1606. Lo stes–
so architetto, ingegnere del duca Carlo Emanuele I di Savoia, progettò, annessi alla
chiesa, l'ospizio dei pellegrini e quello dei convalescenti: i lavori terminarono soltanto
all'inizio del Settecento. Con l'arrivo delle armate rivoluzionarie francesi, vennero cac–
ciati i convalescenti per fare posto ai soldati, che saccheggiarono i locali; la municipa–
lità nel 1801 incamerava i beni dell'Arcicofraternita, soppressa poi nel 1811. Ricosti–
tuita legalmente nel 1818, poté riavere in parte i beni perduti, ma non riaprì l'ospizio
dei pellegrini. Nell'Ottocento furono gestite l'opera delle doti e quella delle mutue
sepolture e soprattutto fu incrementata l'Opera pia convalescenti, ancora oggi operan–
te in zona Crocetta.
Data la presenza della Sindone in Torino dal 1578, la confraternita più tipicamente
torinese
è
comprensibilmente quella del
ss.
Sudario e B. V delle GrazieI
7 ,
sul cui gon–
falone
è
raffigurata la Sindone; la divisa
è
costituita da una cappa bianca con cingolo
rosso. Fu ancora l'arcivescovo Broglia nello stesso 1598 a istituirla, con lo scopo di
praticare le opere di misericordia. Ospitata dapprima nella chiesa parrocchiale di San
Pietro del Gallo o di
Curte Ducis,
passò poi in Santa Maria di Piazza, e infine nell'
ora~
torio interno dell 'ospedale dei malati di mente (<<Ospedale dei Pazzerelli»), fatto
costruire con le ingenti risorse della Confraternita per volere di Vittorio Amedeo II,
che affidò ai confratelli la gestione dell'ospedale, anche medica e infermieristica. Sop–
pressa dal governo napoleonico nel 1811, i suoi beni furono devoluti alla chiesa del
Carmine. Ricostituita e reintegrata nei suoi diritti dopo la Restaurazione, la Confrater–
nita contribuì con le risorse disponibili alla costruzione del nuovo manicomio di con–
trada della Consolata, terminato nel 1835. Nonostante che la nuova direzione presie–
duta dal marchese Gustavo Benso di Cavour si iscrivesse in massa alla Confraternita, si
andò progressivamente delineando la separazione delle due istituzioni, che sarà sancita
13
G. MARTINI,
Storia
cit., pp. 176-180.
14
ARCHIVIO DELLA CONFRATERNITA DI SAN
Rocco,
in
Torino,
Sepolture date agli Esposti in Città dalla Confrater–
nita di San Rocco. Morte ed Orazione di Torino,
snt.
15
Ivi,
Registro dell'accettazione dei Confratelli e conso–
relle di San Rocco.
16
Si vedano
Cenni storici intorno alla Veneranda Arci–
confraternita della 55. Trinità, canonicamente eretta in
146
Torino, in occasione del terzo centenario della f ondazione
della medesima.
Torino, Tipografia Falletti , 1877 ; G .
MARTINI,
Storia
cit., pp. 106-114.
17
GIOVANNI BATIISTA ARruFFO,
La Regia Confrater–
nita delSS. Sudario e B. V. delle Grazie,
Torino, Tip. Sale–
siana, 1898; G . MARTINI,
Storia
cit. , pp. 167-175; GIAN
MARIA ZACCONE,
La Sindone nella storia dell'impegno cri–
stiano,
in «Sindon», IV, n. 4, (giugno 1992), pp. 11 -22.


















