
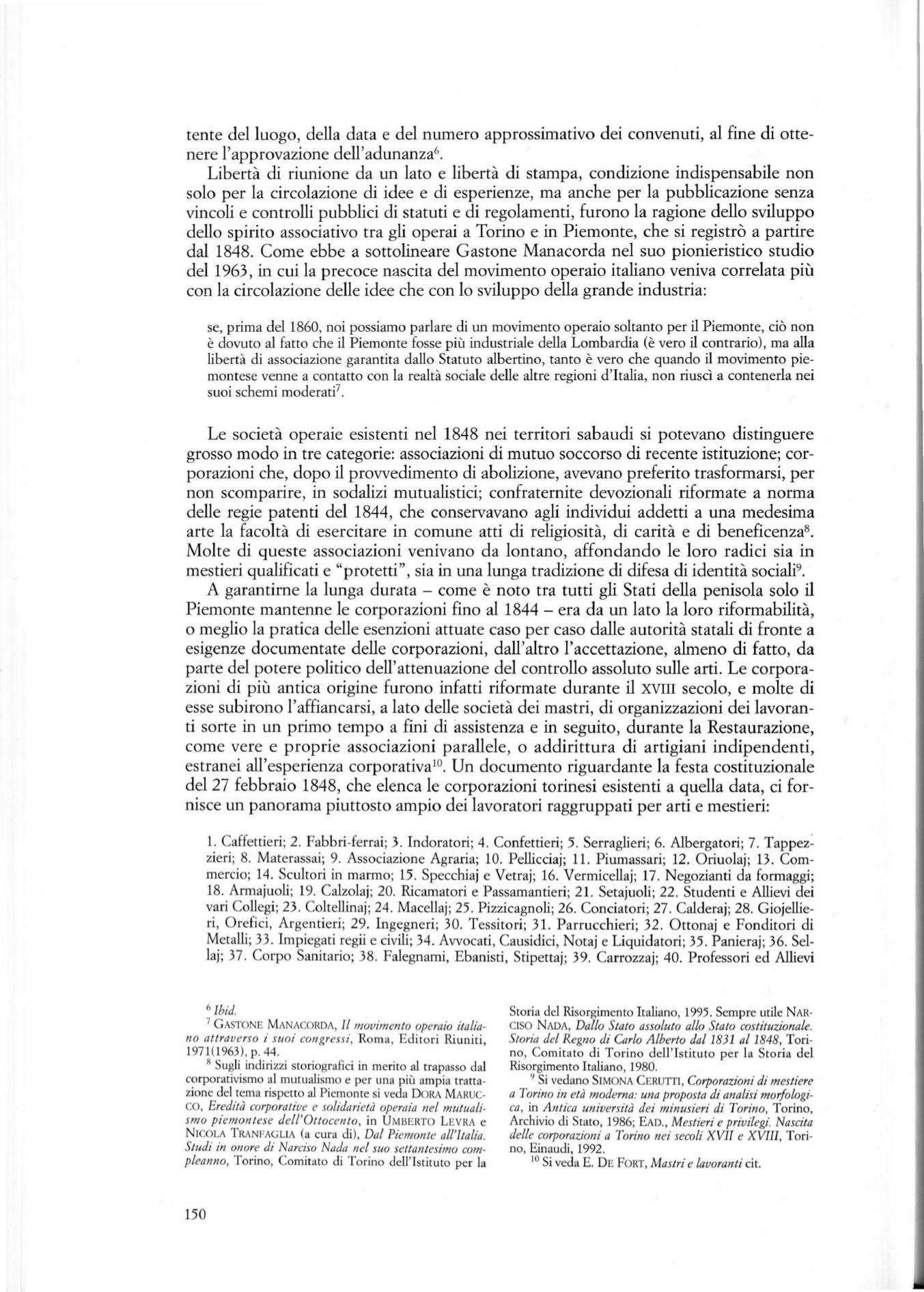
tente del luogo, della data e del numero approssimativo dei convenuti, al fine di otte–
nere l'approvazione dell' adunanza
6 .
Libertà di riunione da un lato e libertà di stampa, condizione indispensabile non
solo per la circolazione di idee e di esperienze, ma anche per la pubblicazione senza
vincoli e controlli pubblici di statuti e di regolamenti, furono la ragione dello sviluppo
dello spirito associativo tra gli operai a Torino e in Piemonte, che si registrò a partire
dal
1848.
Come ebbe a sottolineare Gastone Manacorda nel suo pionieristico studio
del 1963, in cui la precoce nascita del movimento operaio italiano veniva correlata più
con la circolazione delle idee che con lo sviluppo della grande industria:
se, prima del 1860, noi possiamo parlare di un movimento operaio soltanto per il Piemonte, ciò non
è
dovuto al fatto che il Piemonte fosse più industriale della Lombardia
(è
vero il contrario), ma alla
libertà di associazione garantita dallo Statuto albertino, tanto
è
vero che quando il movimento pie–
montese venne a contatto con la realtà sociale delle altre regioni d'Italia, non riuscì a contenerla nei
suoi schemi moderati
7 .
Le società operaie esistenti nel
1848
nei territori sabaudi si potevano distinguere
grosso modo in tre categorie: associazioni di mutuo soccorso di recente istituzione; cor–
porazioni che, dopo il provvedimento di abolizione, avevano preferito trasformarsi, per
non scomparire, in sodalizi mutualistici; confraternite devozionali riformate a norma
delle regie patenti del
1844,
che conservavano agli individui addetti a una medesima
arte la facoltà di esercitare in comune atti di religiosità, di carità e di beneficenza
8 .
Molte di queste associazioni venivano da lontano, affondando le loro radici sia in
mestieri qualificati e "protetti", sia in una lunga tradizione di difesa di identità sociali
9 .
A garantirne la lunga durata - come è noto tra tutti gli Stati della penisola solo il
Piemonte mantenne le corporazioni fino al
1844 -
era da un lato la loro riformabilità,
o meglio la pratica delle esenzioni attuate caso per caso dalle autorità statali di fronte a
esigenze documentate delle corporazioni, dall' altro l'accettazione, almeno di fatto, da
parte del potere politico dell' attenuazione del controllo assoluto sulle arti. Le corpora–
zioni di più antica origine furono infatti riformate durante il
XVIII
secolo, e molte di
esse subirono l'affiancarsi, a lato delle società dei mastri, di organizzazioni dei lavoran–
ti sorte in un primo tempo a fini di assistenza e in seguito, durante la Restaurazione,
come vere e proprie associazioni parallele, o addirittura di artigiani indipendenti,
estranei all'esperienza corporativa
lO .
Un documento riguardante la festa costituzionale
del 27 febbraio
1848,
che elenca le corporazioni torinesi esistenti a quella data, ci for–
nisce un panorama piuttosto ampio dei lavoratori raggruppati per arti e mestieri:
1.
Caffettieri; 2. Fabbri-ferrai; 3. Indoratori; 4. Confettieri; 5. Serraglieri; 6. Albergatori; 7.
Tappez~
zieri; 8. Materassai; 9. Associazione Agraria; 10. Pellicciai; 11. Piumassari; 12. Oriuolai; 13. Com–
mercio; 14. Scultori in marmo; 15. Specchiai e Vetrai; 16. Vermicellai; 17. Negozianti da formaggi;
18. Armaiuoli; 19. Calzolai; 20. Ricamatori e Passamantieri; 21. Setaiuoli; 22. Studenti e Allievi dei
vari Collegi; 23 . Coltellinai; 24. Macellai; 25 . Pizzicagnoli; 26. Conciatori; 27. Calderai; 28. Gioiellie–
ri, Orefici, Argentieri; 29. Ingegneri; 30. Tessitori; 31. Parrucchieri; 32. Ottonai e Fonditori di
Metalli; 33. Impiegati regii e civili; 34. Avvocati, Causidici, Notai e Liquidatori; 35. Panierai; 36. Sel–
lai; 37. Corpo Sanitario; 38. Falegnami, Ebanisti, Stipettai; 39. Carrozzai; 40. Professori ed Allievi
6
Ib/d.
7
GASTONE MANACORDA ,
Il movimento operaio italia–
no attraverso i suoi congressi,
Roma , Editori Riuniti ,
197 1(1963),
p.
44.
8
Sugli indirizzi storiografici in merito al trapasso dal
corporativismo al mutualismo e per una più ampia tratta–
zione del tema rispetto al Piemonte si veda DORA MARUC–
CO,
Eredità corporative e solidarietà operaia nel mutuali–
smo piemontese dell'Ottocento,
in UMBERTO L EVRA e
NICOLA TRANFAG LIA (a cura di),
Dal Piemonte all'Italia.
Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo com–
pleanno,
Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la
150
Storia del Risorgimento Italiano, 1995. Sempre utile N AR–
CISO NADA,
Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale.
Storia del Regno di Carlo Alberto dal
1831
al
1848, Tori–
no , Comitato di Torino d ell'Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, 1980.
9
Si vedano SIMONA CERUTII,
Corporazioni di mestiere
a Torino in età moderna: una proposta di analisi morlologi–
ca,
in
A ntica università dei minusieri di Torino,
Torino,
Archivio di Stato, 1986; EAD.,
Mestieri e privilegi. Nascita
delle corporazioni a Torino nei secoli XVII e XVIII,
Tori–
no, Einaudi, 1992.
IO
Si veda E. D E FORT,
Mastri e lavoranti
cito


















