
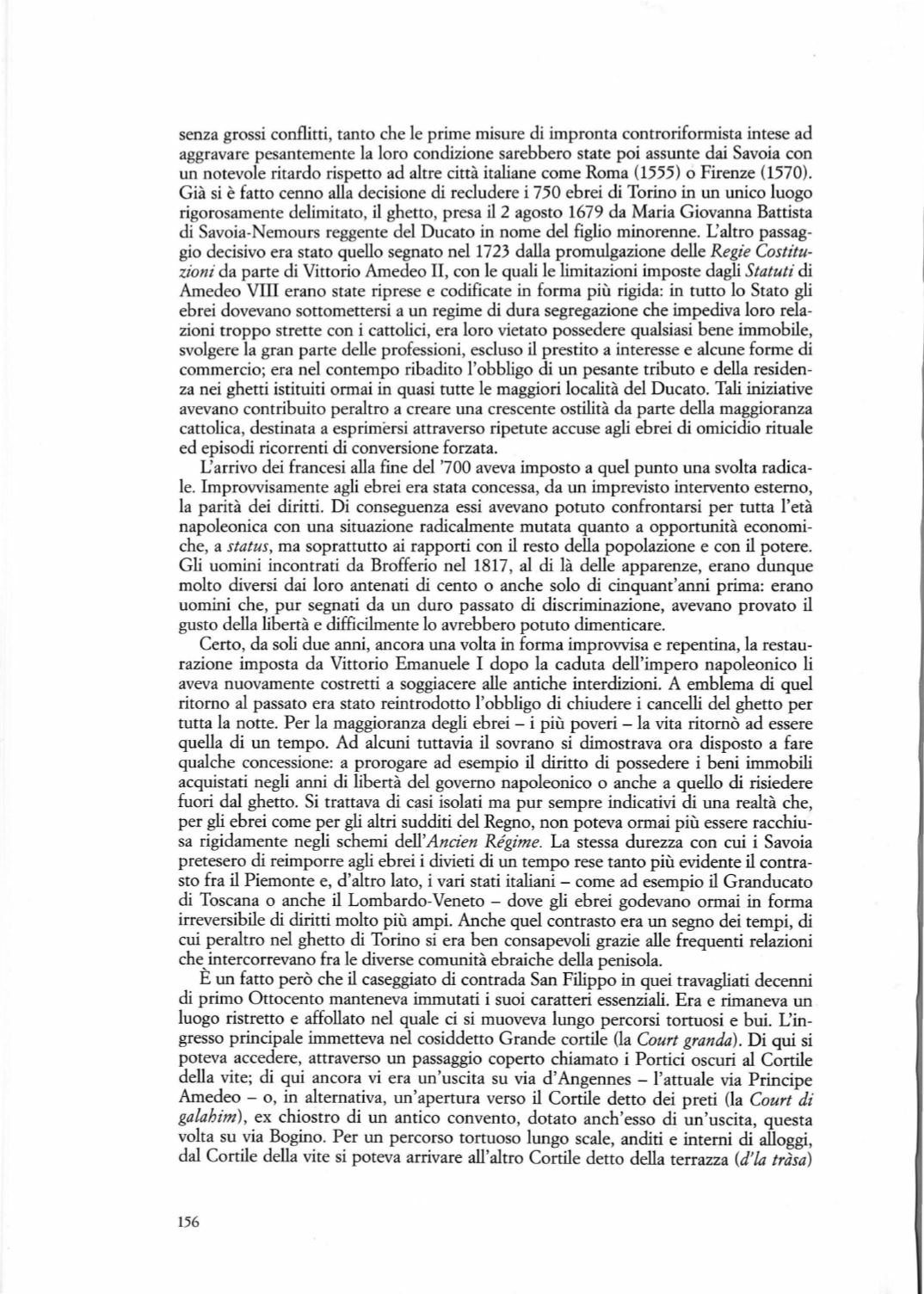
senza grossi conflitti, tanto che le prime misure di impronta controriformista intese ad
aggravare pesantemente la loro condizione sarebbero state poi assunte dai Savoia con
un notevole ritardo rispetto ad altre città italiane come Roma (1555) o Firenze (1570).
Già si è fatto cenno alla decisione di recludere i 750 ebrei di Torino in un unico luogo
rigorosamente delimitato, il ghetto, presa il2 agosto 1679 da Maria Giovanna Battista
di Savoia-Nemours reggente del Ducato in nome del figlio minorenne. L'altro passag–
gio decisivo era stato quello segnato nel 1723 dalla promulgazione delle
Regie Costitu–
zioni
da parte di Vittorio Amedeo II, con le quali le limitazioni imposte dagli
Statuti
di
Amedeo VIII erano state riprese e codificate in forma più rigida: in tutto lo Stato gli
ebrei dovevano sottomettersi a un regime di dura segregazione che impediva loro rela–
zioni troppo strette con i cattolici, era loro vietato possedere qualsiasi bene immobile,
svolgere la gran parte delle professioni, escluso il prestito a interesse e alcune forme di
commercio; era nel contempo ribadito l'obbligo di un pesante tributo e della residen–
za nei ghetti istituiti ormai in quasi tutte le maggiori località del Ducato. Tali iniziative
avevano contribuito peraltro a creare una crescente ostilità da parte della maggioranza
cattolica, destinata a esprimersi attraverso ripetute accuse agli ebrei di omicidio rituale
ed episodi ricorrenti di conversione forzata.
L'arrivo dei francesi alla fine del '700 aveva imposto a quel punto una svolta radica–
le. Improvvisamente agli ebrei era stata concessa, da un imprevisto intervento esterno,
la parità dei diritti. Di conseguenza essi avevano potuto confrontarsi per tutta l'età
napoleonica con una situazione radicalmente mutata quanto a opportunità economi–
che, a
status,
ma soprattutto ai rapporti con
il
resto della popolazione e con il potere.
Gli uomini incontrati da Brofferio nel 1817, al di là delle apparenze, erano dunque
molto diversi dai loro antenati di cento o anche solo di cinquant'anni prima: erano
uomini che, pur segnati da un duro passato di discriminazione, avevano provato il
gusto della libertà e difficilmente lo avrebbero potuto dimenticare.
Certo, da soli due anni, ancora una volta in forma improvvisa e repentina, la restau–
razione imposta da Vittorio Emanuele I dopo la caduta dell'impero napoleonico li
aveva nuovamente costretti a soggiacere alle antiche interdizioni. A emblema di quel
ritorno al passato era stato reintrodotto l'obbligo di chiudere i cancelli del ghetto per
tutta la notte. Per la maggioranza degli ebrei - i più poveri - la vita ritornò ad essere
quella di un tempo. Ad alcuni tuttavia il sovrano si dimostrava ora disposto a fare
qualche concessione: a prorogare ad esempio
il
diritto di possedere i beni immobili
acquistati negli anni di libertà del governo napoleonico o anche a quello di risiedere
fuori dal ghetto. Si trattava di casi isolati ma pur sempre indicativi di una realtà che,
per gli ebrei come per gli altri sudditi del Regno, non poteva ormai più essere racchiu–
sa rigidamente negli schemi
dell'Ancien Régime.
La stessa durezza con cui i Savoia
pretesero di reimporre agli ebrei i divieti di un tempo rese tanto più evidente il contra–
sto fra
il
Piemonte e, d'altro lato, i vari stati italiani - come ad esempio il Granducato
di Toscana o anche il Lombardo-Veneto - dove gli ebrei godevano ormai in forma
irreversibile di diritti molto più ampi. Anche quel contrasto era un segno dei tempi, di
cui peraltro nel ghetto di Torino si era ben consapevoli grazie alle frequenti relazioni
che,intercorrevano fra le diverse comunità ebraiche della penisola.
E un fatto però che il caseggiato di contrada San Filippo in quei travagliati decenni
di primo Ottocento manteneva immutati i suoi caratteri essenziali. Era e rimaneva un
luogo ristretto e affollato nel quale ci si muoveva lungo percorsi tortuosi e bui. L'in–
gresso principale immetteva nel cosiddetto Grande cortile (la
Court granda).
Di qui si
poteva accedere, attraverso un passaggio coperto chiamato i Portici oscuri al Cortile
della vite; di qui ancora vi era un'uscita su via d'Angennes - l'attuale via Principe
Amedeo - o, in alternativa, un'apertura verso il Cortile detto dei preti (la
Court di
galahim)
,
ex chiostro di un antico convento, dotato anch'esso di un'uscita, questa
volta su via Bogino. Per un percorso tortuoso lungo scale, anditi e interni di alloggi,
dal Cortile della vite si poteva arrivare all'altro Cortile detto della terrazza
(d
J
la tràsa)
156


















