
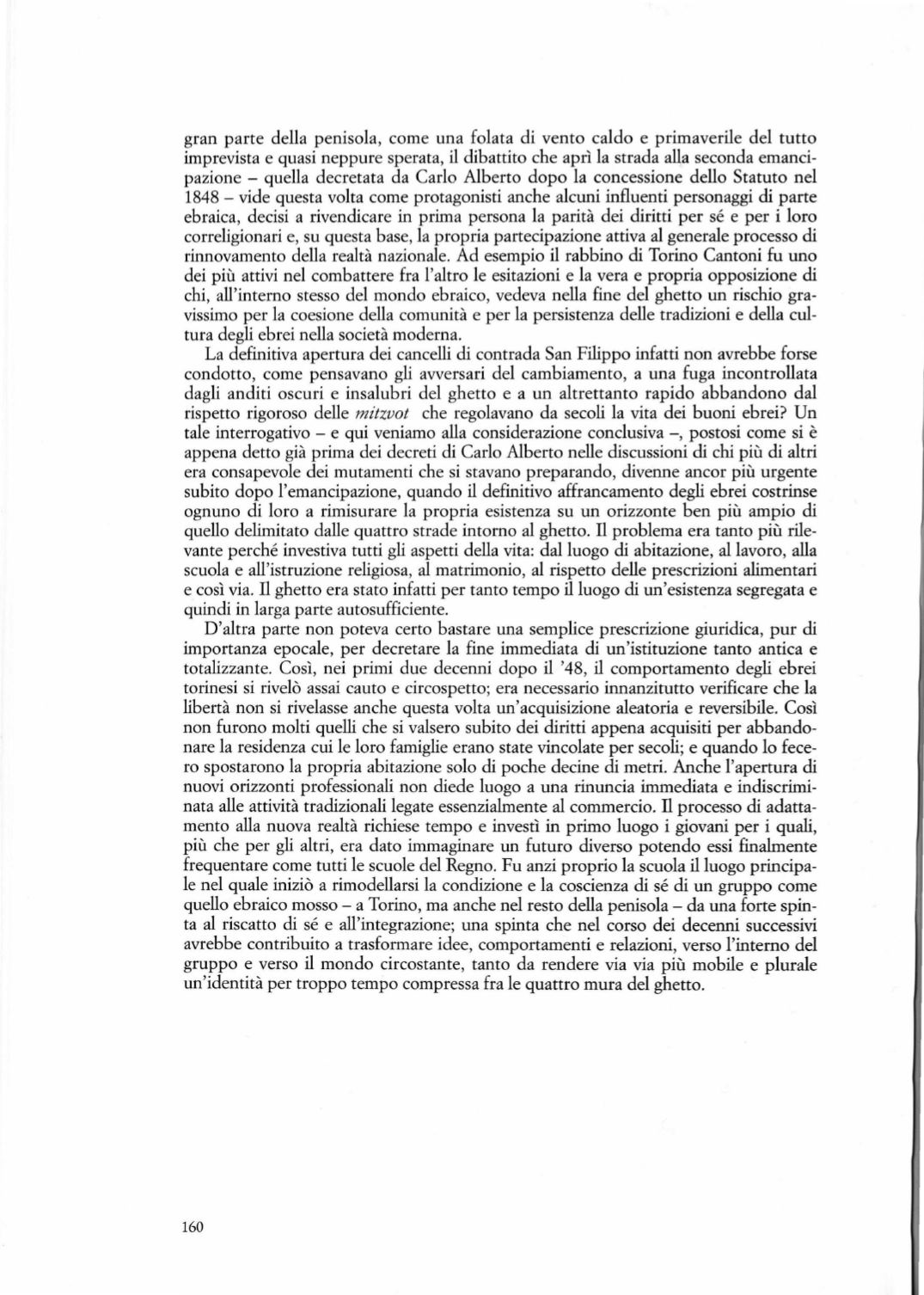
gran parte della penisola, come una folata di vento caldo e primaverile del tutto
imprevista e quasi neppure sperata, il dibattito che aprì la strada alla seconda emanci–
pazione - quella decretata da Carlo Alberto dopo la concessione dello Statuto nel
1848 - vide questa volta come protagonisti anche alcuni influenti personaggi di parte
ebraica, decisi a rivendicare in prima persona la parità dei diritti per sé e per i loro
correligionari e, su questa base, la propria partecipazione attiva al generale processo di
rinnovamento della realtà nazionale. Ad esempio il rabbino di Torino Cantoni fu uno
dei più attivi nel combattere fra l'altro le esitazioni e la vera e propria opposizione di
chi, all 'interno stesso del mondo ebraico, vedeva nella fine del ghetto un rischio gra–
vissimo per la coesione della comunità e per la persistenza delle tradizioni e della cul–
tura degli ebrei nella società moderna.
La definitiva apertura dei cancelli di contrada San Filippo infatti non avrebbe forse
condotto, come pensavano gli avversari del cambiamento, a una fuga incontrollata
dagli anditi oscuri e insalubri del ghetto e a un altrettanto rapido abbandono dal
rispetto rigoroso delle
mitzvot
che regolavano da secoli la vita dei buoni ebrei? Un
tale interrogativo - e qui veniamo alla considerazione conclusiva -, postosi come si è
appena detto già prima dei decreti di Carlo Alberto nelle discussioni di chi più di altri
era consapevole dei mutamenti che si stavano preparando, divenne ancor più urgente
subito dopo l'emancipazione, quando il definitivo affrancamento degli ebrei costrinse
ognuno di loro a rimisurare la propria esistenza su un orizzonte ben più ampio di
quello delimitato dalle quattro strade intorno al ghetto. Il problema era tanto più rile–
vante perché investiva tutti gli aspetti della vita: dal luogo di abitazione, al lavoro, alla
scuola e all'istruzione religiosa, al matrimonio, al rispetto delle prescrizioni alimentari
e così via. Il ghetto era stato infatti per tanto tempo il luogo di un'esistenza segregata e
quindi in larga parte autosufficiente.
D'altra parte non poteva certo bastare una semplice prescrizione giuridica, pur di
importanza epocale, per decretare la fine immediata di un'istituzione tanto antica e
totalizzante. Così, nei primi due decenni dopo il '48, il comportamento degli ebrei
torinesi si rivelò assai cauto e circospetto; era necessario innanzitutto verificare che la
libertà non si rivelasse anche questa volta un' acquisizione aleatoria e reversibile. Così
non furono molti quelli che si valsero subito dei diritti appena acquisiti per abbando–
nare la residenza cui le loro famiglie erano state vincolate per secoli; e quando lo fece–
ro spostarono la propria abitazione solo di poche decine di metri. Anche l'apertura di
nuovi orizzonti professionali non diede luogo a una rinuncia immediata e indiscrimi–
nata alle attività tradizionali legate essenzialmente al commercio. Il processo di adatta–
mento alla nuova realtà richiese tempo e investì in primo luogo i giovani per i quali,
più che per gli altri, era dato immaginare un futuro diverso potendo essi finalmente
frequentare come tutti le scuole del Regno. Fu anzi proprio la scuola il luogo principa–
le nel quale iniziò a rimodellarsi la condizione e la coscienza di sé di un gruppo come
quello ebraico mosso - a Torino, ma anche nel resto della penisola - da una forte spin–
ta al riscatto di sé e all'integrazione; una spinta che nel corso dei decenni successivi
avrebbe contribuito a trasformare idee, comportamenti e relazioni, verso l'interno del
gruppo e verso il mondo circostante, tanto da rendere via via più mobile e plurale
un'identità per troppo tempo compressa fra le quattro mura del ghetto.
160


















