
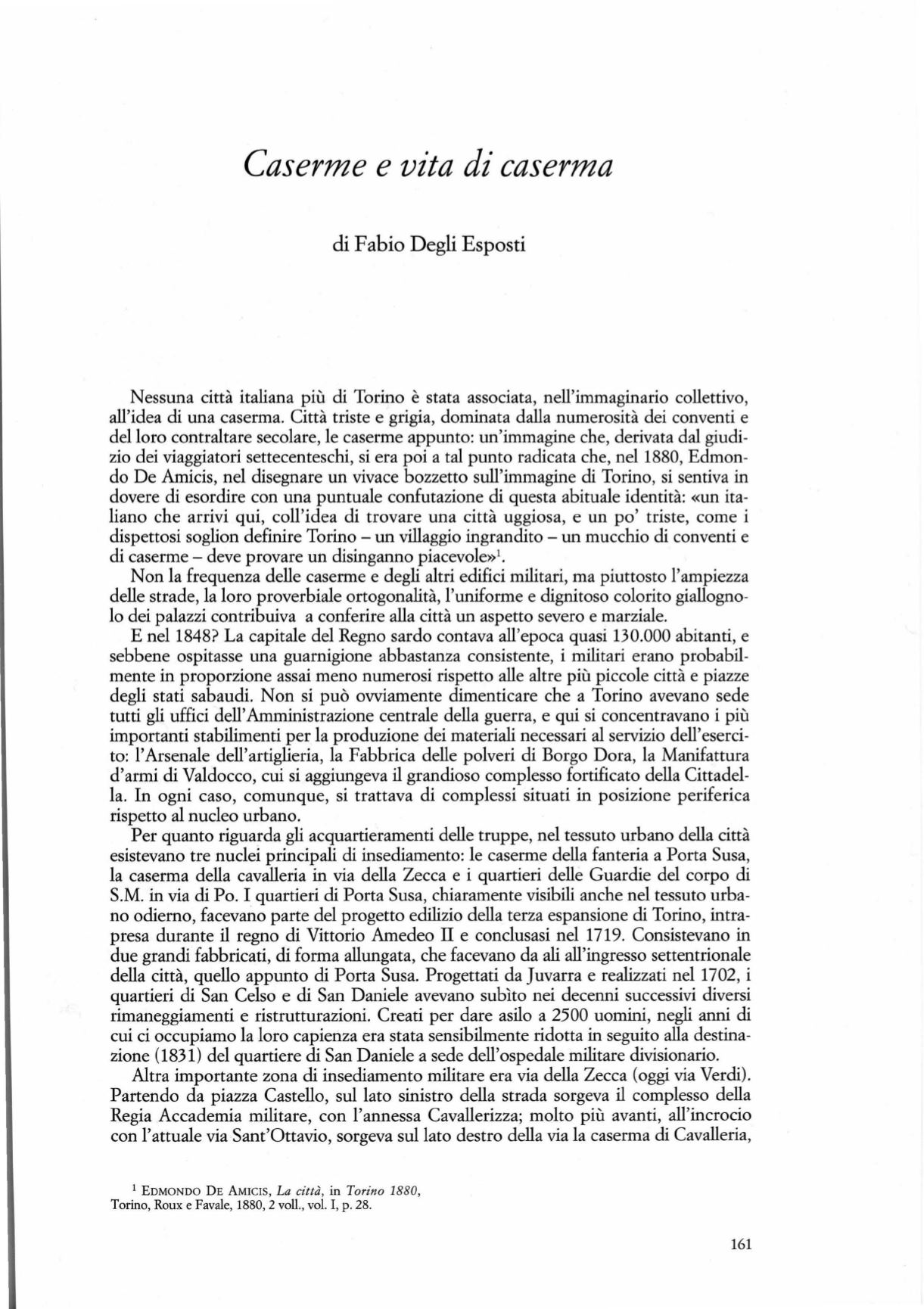
Caserme e vita di caserma
di Fabio Degli Esposti
Nessuna città italiana più di Torino è stata associata, nell'immaginario collettivo,
all'idea di una caserma. Città triste e grigia, dominata dalla numerosità dei conventi e
del loro contraltare secolare, le caserme appunto: un'immagine che, derivata dal giudi–
zio dei viaggiatori settecenteschi, si era poi a tal punto radicata che, nel 1880, Edmon–
do De Amicis, nel disegnare un vivace bozzetto sull'immagine di Torino, si sentiva in
dovere di esordire con una puntuale confutazione di questa abituale identità: «un ita–
liano che arrivi qui, coll'idea di trovare una città uggiosa, e un po' triste, come i
dispettosi soglion definire Torino - un villaggio ingrandito - un mucchio di conventi e
di caserme - deve provare un disinganno piacevole»!.
Non la frequenza delle caserme e degli altri edifici militari, ma piuttosto l'ampiezza
delle strade, la loro proverbiale ortogonalità, l'uniforme e dignitoso colorito giallogno–
lo dei palazzi contribuiva a conferire alla città un aspetto severo e marziale.
E nel 1848? La capitale del Regno sardo contava all'epoca quasi 130.000 abitanti, e
sebbene ospitasse una guarnigione abbastanza consistente, i militari erano probabil–
mente in proporzione assai meno numerosi rispetto alle altre più piccole città e piazze
degli stati sabaudi. Non si può ovviamente dimenticare che a Torino avevano sede
tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra, e qui si concentravano i più
importanti stabilimenti per la produzione dei materiali necessari al servizio dell'eserci–
to: l'Arsenale dell'artiglieria, la Fabbrica delle polveri di Borgo Dora, la Manifattura
d'armi di Valdocco, cui si aggiungeva il grandioso complesso fortificato della Cittadel–
la. In ogni caso, comunque, si trattava di complessi situati in posizione periferica
rispetto al nucleo urbano.
Per quanto riguarda gli acquartieramenti delle truppe, nel tessuto urbano della città
esistevano tre nuclei principali di insediamento: le caserme della fanteria a Porta Susa,
la caserma della cavalleria in via della Zecca e i quartieri delle Guardie del corpo di
S.M. in via di Po. I quartieri di Porta Susa, chiaramente visibili anche nel tessuto urba–
no odierno, facevano parte del progetto edilizio della terza espansione di Torino, intra–
presa durante il regno di Vittorio Amedeo II e conclusasi nel 1719. Consistevano in
due grandi fabbricati, di forma allungata, che facevano da ali all'ingresso settentrionale
della città, quello appunto di Porta Susa. Progettati da
J
uvarra e realizzati nel 1702, i
quartieri di San Celso e di San Daniele avevano subìto nei decenni successivi diversi
rimaneggiamenti e ristrutturazioni. Creati per dare asilo a 2500 uomini, negli anni di
cui ci occupiamo la loro capienza era stata sensibilmente ridotta in seguito alla destina–
zione (1831) del quartiere di San Daniele a sede dell'ospedale militare divisionario.
Altra importante zona di insediamento militare era via della Zecca (oggi via Verdi).
Partendo da piazza Castello, sul lato sinistro della strada sorgeva il complesso della
Regia Accademia militare, con l'annessa Cavallerizza; molto più avanti, all'incrocio
con l'attuale via Sant'Ottavio, sorgeva sul lato destro della via la caserma di Cavalleria,
1 EDMONDO
DE
AMICIS,
La
città,
in
Torino 1880,
Torino, Roux e Favale, 1880, 2 voll. , voI. I, p. 28.
161


















