
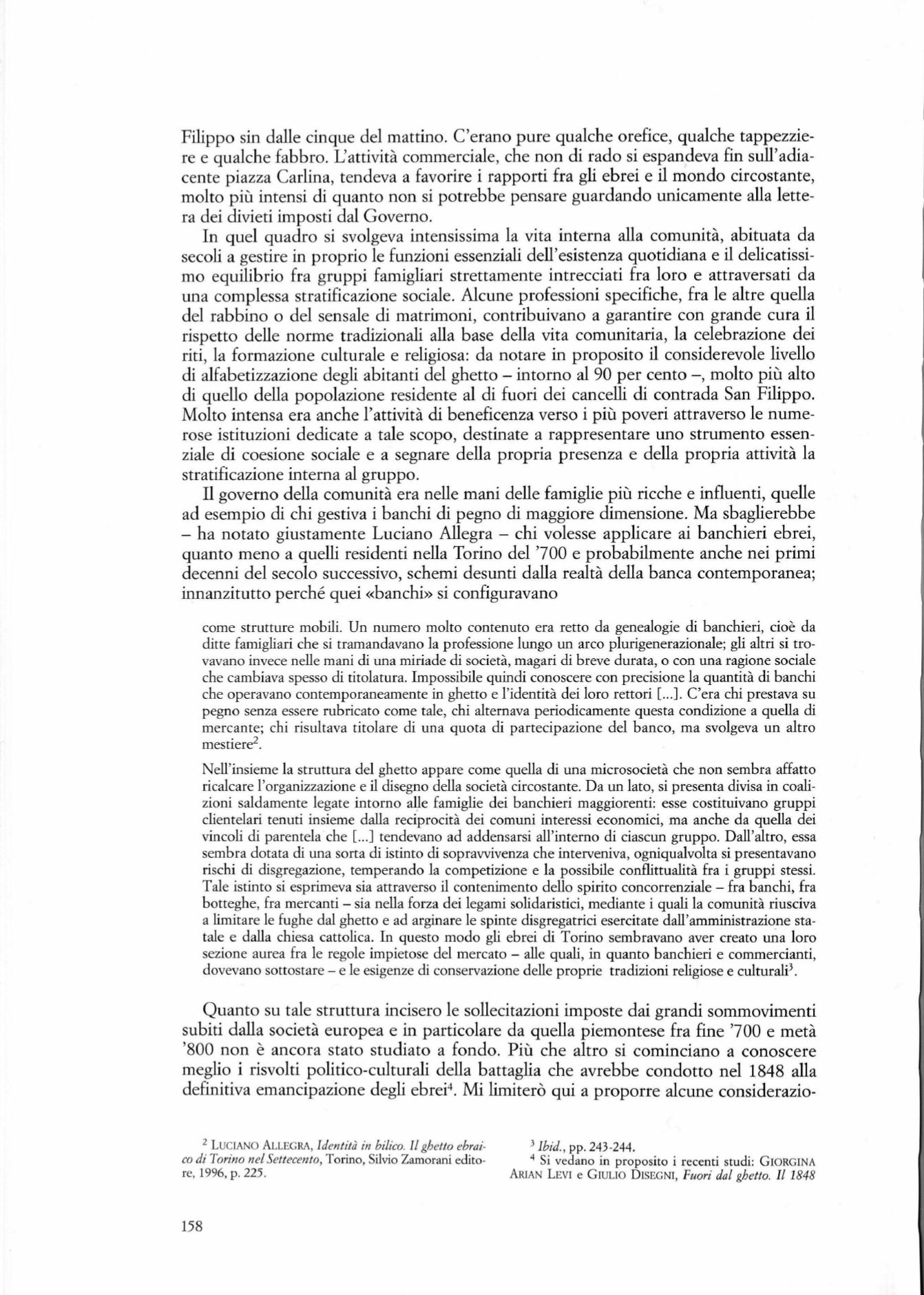
Filippo sin dalle cinque del mattino. C'erano pure qualche orefice, qualche tappezzie–
re e qualche fabbro. L'attività commerciale, che non di rado si espanpeva fin sull'adia–
cente piazza Carlina, tendeva a favorire i rapporti fra gli ebrei e il mondo circostante,
molto più intensi di quanto non si potrebbe pensare guardando unicamente alla lette–
ra dei divieti imposti dal Governo.
In quel quadro si svolgeva intensissima la vita interna alla comunità, abituata da
secoli a gestire in proprio le funzioni essenziali dell' esistenza quotidiana e il delicatissi–
mo equilibrio fra gruppi famigliari strettamente intrecciati fra loro e attraversati da
una complessa stratificazione sociale. Alcune professioni specifiche, fra le altre quella
del rabbino o del sensale di matrimoni, contribuivano a garantire con grande cura il
rispetto delle norme tradizionali alla base della vita comunitaria, la celebrazione dei
riti, la formazione culturale e religiosa: da notare in proposito il considerevole livello
di alfabetizzazione degli abitanti del ghetto - intorno al 90 per cento -, molto più alto
di quello della popolazione residente al di fuori dei cancelli di contrada San Filippo.
Molto intensa era anche l'attività di beneficenza verso i più poveri attraverso le nume–
rose istituzioni dedicate a tale scopo, destinate a rappresentare uno strumento essen–
ziale di coesione sociale e a segnare della propria presenza e della propria attività la
stratificazione interna al gruppo.
Il governo della comunità era nelle mani delle famiglie più ricche e influenti, quelle
ad esempio di chi gestiva i banchi di pegno di maggiore dimensione. Ma sbaglierebbe
- ha notato giustamente Luciano Allegra - chi volesse applicare ai banchieri ebrei,
quanto meno a quelli residenti nella Torino del '700 e probabilmente anche nei primi
decenni del secolo successivo, schemi desunti dalla realtà della banca contemporanea;
innanzitutto perché quei «banchi» si configuravano
come strutture mobili. Un numero molto contenuto era retto da genealogie di banchieri, cioè da
ditte famigliari che si tramandavano la professione lungo un arco plurigenerazionale; gli altri si tro–
vavano invece nelle mani di una miriade di società, magari di breve durata, o con una ragione sociale
che cambiava spesso di titolatura. Impossibile quindi conoscere con precisione la quantità di banchi
che operavano contemporaneamente in ghetto e l'identità dei loro rettori L..
J.
C'era chi prestava su
pegno senza essere rubricato come tale, chi alternava periodicamente questa condizione a quella di
mercante; chi risultava titolare di una quota di partecipazione del banco, ma svolgeva un altro
mestiere
2 .
Nell'insieme la struttura del ghetto appare come quella di una microsocietà che non sembra affatto
ricalcare l'organizzazione e il disegno della società circostante. Da un lato, si presenta divisa in coali–
zioni saldamente legate intorno alle famiglie dei banchieri maggiorenti: esse costituivano gruppi
clientelari tenuti insieme dalla reciprocità dei comuni interessi economici, ma anche da quella dei
vincoli di parentela che [...] tendevano ad addensarsi all'interno di ciascun gruppo. Dall'altro, essa
sembra dotata di una sorta di istinto di sopravvivenza che interveniva, ogniqualvolta si presentavano
rischi di disgregazione, temperando la competizione e la possibile conflittualità fra i gruppi stessi.
Tale istinto si esprimeva sia attraverso il contenimento dello spirito concorrenziale - fra banchi, fra
botteghe, fra mercanti - sia nella forza dei legami solidaristici, mediante i quali la comunità riusciva
a limitare le fughe dal ghetto e ad arginare le spinte disgregatrici esercitate dall'amministrazione sta–
tale e dalla chiesa cattolica. In questo modo gli ebrei di Torino sembravano aver creato wi.a loro
sezione aurea fra le regole impietose del mercato - alle quali, in quanto banchieri e commercianti,
dovevano sottostare - e le esigenze di conservazione delle proprie tradizioni religiose e culturali
3 .
Quanto su tale struttura incisero le sollecitazioni imposte dai grandi sommovimenti
subiti dalla società europea e in particolare da quella piemontese fra fine '700 e metà
'800 non
è
ancora stato studiato a fondo. Più che altro si cominciano a conoscere
meglio i risvolti politico-culturali della battaglia che avrebbe condotto nel 1848 alla
definitiva emancipazione degli ebrei
4 •
Mi limiterò qui a proporre alcune considerazio-
2
LUCIANO ALLEGRA,
Identità in bilico. Il ghetto ebrai–
co di Torino nel Settecento,
Torino, Silvio Zamorani edito–
re, 1996, p. 225.
3
Ibid.,
pp. 243-244.
4
Si vedano in proposito i recenti studi:
GIORGINA
ARrAN LEVI
e
GIULIO DISEGNI,
Fuori dal ghetto. Il 1848
158


















