
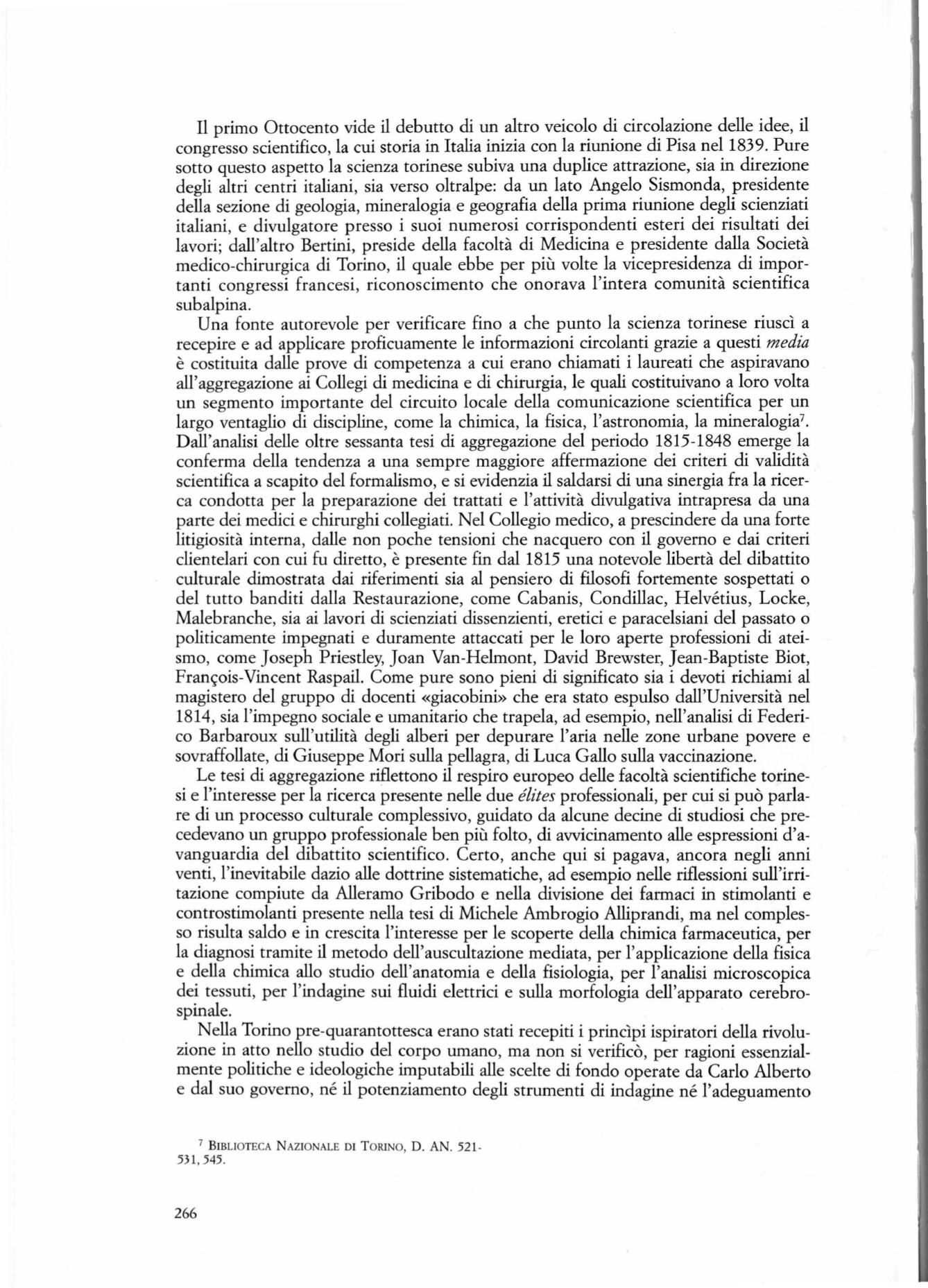
Il primo Ottocento vide il debutto di un altro veicolo di circolazione delle idee, il
congresso scientifico, la cui storia in Italia inizia con la riunione di Pisa nel 1839. Pure
sotto questo aspetto la scienza torinese subiva una duplice attrazione, sia in direzione
degli altri centri italiani, sia verso oltralpe: da un lato Angelo Sismonda, presidente
della sezione di geologia, mineralogia e geografia della prima riunione degli scienziati
italiani, e divulgatore presso i suoi numerosi corrispondenti esteri dei risultati dei
lavori; dall' altro Bertini, preside della facoltà di Medicina e presidente dalla Società
medico-chirurgica di Torino, il quale ebbe per più volte
la
vicepresidenza di impor–
tanti congressi francesi, riconoscimento che onorava l'intera comunità scientifica
subalpina.
Una fonte autorevole per verificare fino a che punto la scienza torinese riuscì a
recepire e ad applicare proficuamente le informazioni circolanti grazie a questi
media
è costituita dalle prove di competenza a cui erano chiamati i laureati che aspiravano
all' aggregazione ai Collegi di medicina e di chirurgia, le quali costituivano a loro volta
un segmento importante del circuito locale della comunicazione scientifica per un
largo ventaglio di discipline, come la chimica, la fisica, l'astronomia, la mineralogia
7 •
Dall'analisi delle oltre sessanta tesi di aggregazione del periodo 1815-1848 emerge la
conferma della tendenza a una sempre maggiore affermazione dei criteri di validità
scientifica a scapito del formalismo, e si evidenzia il saldarsi di una sinergia fra la ricer–
ca condotta per la preparazione dei trattati e l'attività divulgativa intrapresa da una
parte dei medici e chirurghi collegiati. Nel Collegio medico, a prescindere da una forte
litigiosità interna, dalle non poche tensioni che nacquero con il governo e dai criteri
clientelari con cui fu diretto,
è
presente fin dal 1815 una notevole libertà del dibattito
culturale dimostrata dai riferimenti sia al pensiero di filosofi fortemente sospettati o
del tutto banditi dalla Restaurazione, come Cabanis, Condillac, Helvétius, Locke,
Malebranche, sia ai lavori di scienziati dissenzienti, eretici e paracelsiani del passato o
politicamente impegnati e duramente attaccati per le loro aperte professioni di atei–
smo, come Joseph Priestley, Joan Van-Helmont, David Brewster, Jean-Baptiste Biot,
François-Vincent Raspail. Come pure sono pieni di significato sia i devoti richiami al
magistero del gruppo di docenti «giacobini» che era stato espulso dall'Università nel
1814, sia l'impegno sociale e umanitario che trapela, ad esempio, nell'analisi di Federi–
co Barbaroux sull'utilità degli alberi per depurare l'aria nelle zone urbane povere e
sovraffollate, di Giuseppe Mori sulla pellagra, di Luca Gallo sulla vaccinazione.
Le tesi di aggregazione riflettono il respiro europeo delle facoltà scientifiche torine–
si e l'interesse per la ricerca presente nelle due
élites
professionali, per cui si può parla–
re di un processo culturale complessivo, guidato da alcune decine di studiosi che pre–
cedevano un gruppo professionale ben più folto , di avvicinamento alle espressioni d'a–
vanguardia del dibattito scientifico. Certo, anche qui si pagava, ancora negli anni
venti, l'inevitabile dazio alle dottrine sistematiche, ad esempio nelle riflessioni sull'irri–
tazione compiute da Alleramo Gribodo e nella divisione dei farmaci in stimolanti e
controstimolanti presente nella tesi di Michele Ambrogio Alliprandi, ma nel comples–
so risulta saldo .e in crescita l'interesse per le scoperte della chimica farmaceutica, per
la diagnosi tramite il metodo dell'auscultazione mediata, per l'applicazione della fisica
e della chimica allo studio dell' anatomia e della fisiologia, per l'analisi microscopica
dei tessuti, per l'indagine sui fluidi elettrici e sulla morfologia dell'apparato cerebro–
spinale.
Nella Torino pre-quarantottesca erano stati recepiti i princìpi ispiratori della rivolu–
zione in atto nello studio del corpo umano, ma non si verificò, per ragioni essenzial–
mente politiche e ideologiche imputabili alle scelte di fondo operate da Carlo Alberto
e dal suo governo, né il potenziamento degli strumenti di indagine né l'adeguamento
7 BIBLIOTECA N AZIONALE DI T ORINO,
D.
AN. 521 -
531, 545.
266


















