
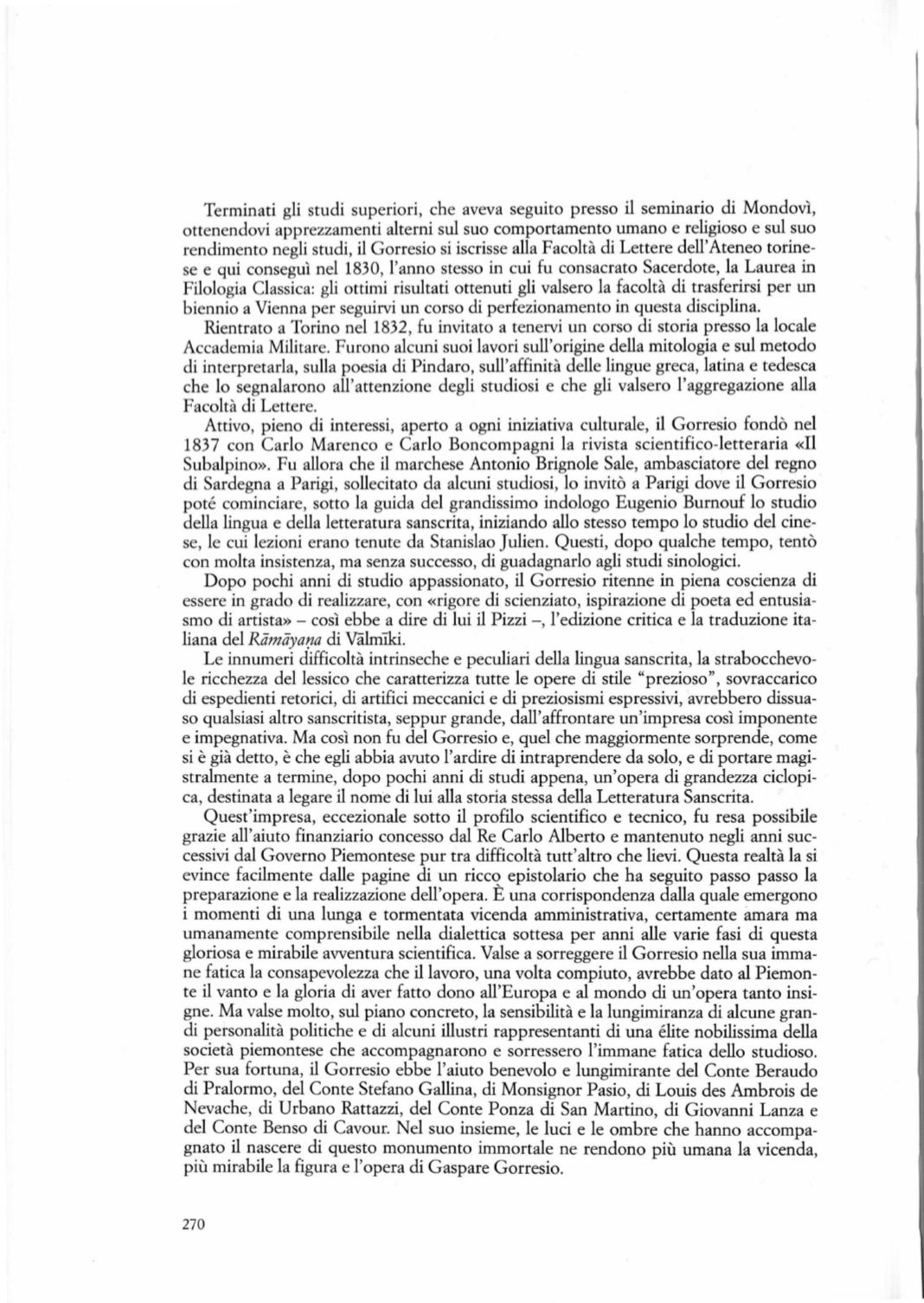
Terminati gli studi superiori, che aveva seguito presso il seminario di Mondovì,
ottenendovi apprezzamenti alterni sul suo comportamento umano e religioso e sul suo
rendimento negli studi, il Gorresio si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell'Ateneo torine–
se e qui conseguì nel 1830, l'anno stesso in cui fu consacrato Sacerdote, la Laurea in
Filologia Classica: gli ottimi risultati ottenuti gli valsero la facoltà di trasferirsi per un
biennio a Vienna per seguirvi un corso di perfezionamento in questa disciplina.
Rientrato a Torino nel 1832, fu invitato a tenervi un corso di storia presso la locale
Accademia Militare. Furono alcuni suoi lavori sull'origine della mitologia e sul metodo
di interpretarla, sulla poesia di Pindaro, sull'affinità delle lingue greca, latina e tedesca
che lo segnalarono all'attenzione degli studiosi e che gli valsero
l'aggregazione
alla
Facoltà di Lettere.
Attivo, pieno di interessi, aperto a ogni iniziativa culturale, il Gorresio fondò nel
1837 con Carlo Marenco e Carlo Boncompagni la rivista scientifico-letteraria «Il
Subalpino». Fu allora che il marchese Antonio Brignole Sale, ambasciatore del regno
di Sardegna a Parigi, sollecitato da alcuni studiosi, lo invitò a Parigi dove il Gorresio
poté cominciare, sotto la guida del grandissimo indologo Eugenio Burnouf lo studio
della lingua e della letteratura sanscrita, iniziando allo stesso tempo lo studio del cine–
se, le cui lezioni erano tenute da Stanislao Julien. Questi, dopo qualche tempo, tentò
con molta insistenza, ma senza successo, di guadagnarlo agli studi sinologici.
Dopo pochi anni di studio appassionato, il Gorresio ritenne in piena coscienza di
essere in grado di realizzare, con «rigore di scienziato, ispirazione di poeta ed entusia–
smo di artista» - così ebbe a dire di lui il Pizzi -,
l'edizione
critica e la traduzione ita–
liana del
Ramaya1Ja
di Valmlki.
Le innumeri difficoltà intrinseche e peculiari della lingua sanscrita, la strabocchevo–
le ricchezza del lessico che caratterizza tutte le opere di stile "prezioso", sovraccarico
di espedienti retorici, di artifici meccanici e di preziosismi espressivi, avrebbero dissua–
so qualsiasi altro sanscritista, seppur grande, dall' affrontare un'impresa così imponente
e impegnativa. Ma così non fu del Gorresio e, quel che maggiormente sorprende, come
si
è
già detto,
è
che egli abbia avuto
l'ardire
di intraprendere da solo, e di portare magi–
stralmente a termine, dopo pochi anni di studi appena, un'opera di grandezza ciclopi–
ca, destinata a legare il nome di lui alla storia stessa della Letteratura Sanscrita.
Quest'impresa, eccezionale sotto il profilo scientifico e tecnico, fu resa possibile
grazie all' aiuto finanziario concesso dal Re Carlo Alberto e mantenuto negli anni suc–
cessivi dal Governo Piemontese pur tra difficoltà tutt' altro che lievi. Questa realtà la si
evince facilmente dalle pagine di un ricco epistolario che ha seguito passo passo la
preparazione e la realizzazione dell'opera.
È
una corrispondenza dalla quale emergono
i momenti di una lunga e tormentata vicenda amministrativa, certamente amara ma
umanamente comprensibile nella dialettica sottesa per anni alle varie fasi di questa
gloriosa e mirabile avventura scientifica. Valse a sorreggere il Gorresio nella sua imma–
ne fatica la consapevolezza che il lavoro, una volta compiuto, avrebbe dato al Piemon–
te il vanto e la gloria di aver fatto dono all'Europa e al mondo di un'opera tanto insi–
gne. Ma valse molto, sul piano concreto, la sensibilità e la lungimiranza di alcune gran–
di personalità politiche e di alcuni illustri rappresentanti di una élite nobilissima della
società piemontese che accompagnarono e sorressero l'immane fatica dello studioso.
Per sua fortuna, il Gorresio ebbe
l'aiuto
benevolo e lungimirante del Conte Beraudo
di Pralormo, del Conte Stefano Gallina, di Monsignor Pasio, di Louis des Ambrois de
Nevache, di Urbano Rattazzi, del Conte Ponza di San Martino, di Giovanni Lanza e
del Conte Benso di Cavour. Nel suo insieme, le luci e le ombre che hanno accompa–
gnato il nascere di questo monumento immortale ne rendono più umana la vicenda,
più mirabile la figura e l'opera di Gaspare Gorresio.
270


















