
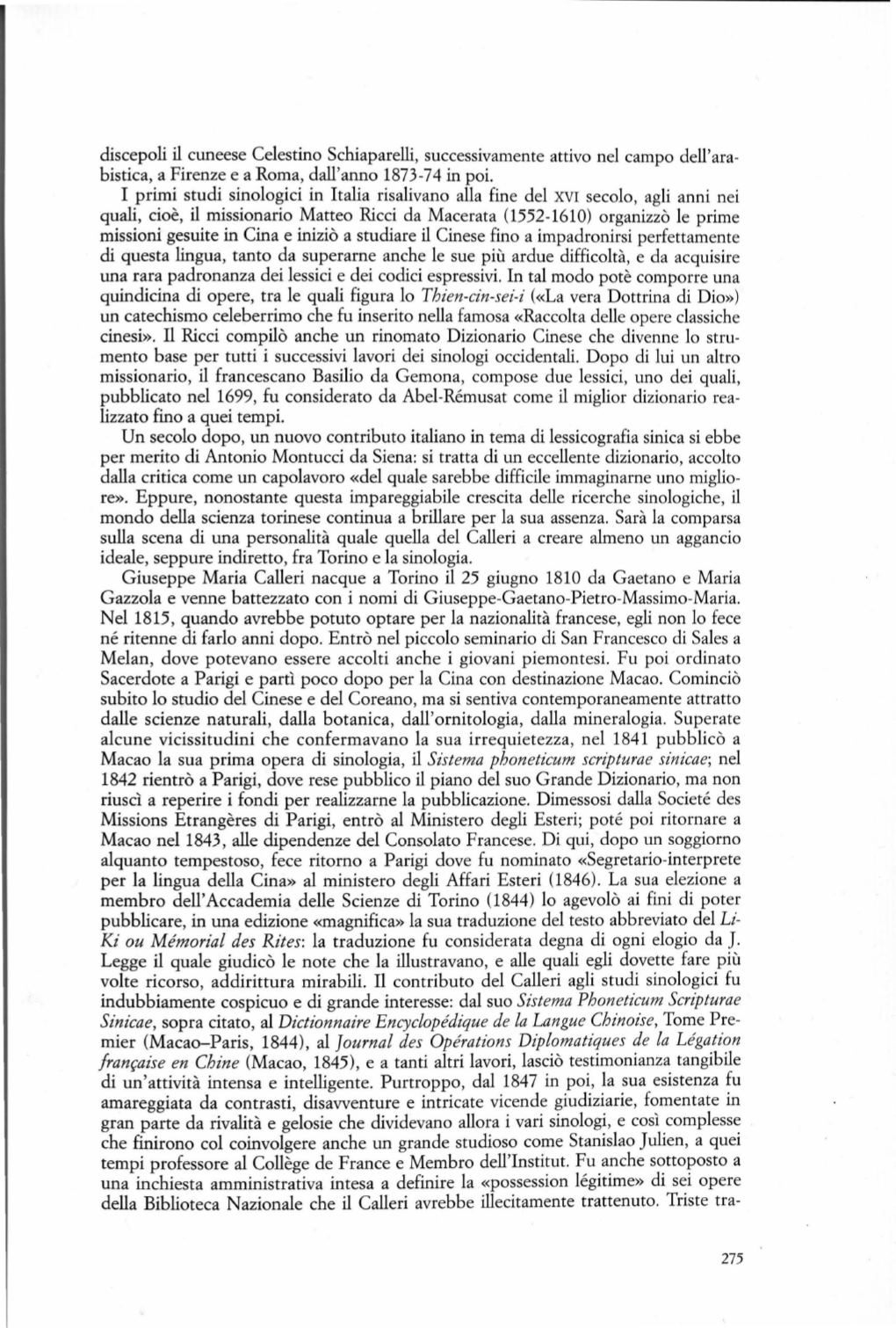
discepoli il cuneese Celestino Schiaparelli, successivamente attivo nel campo dell'ara–
bistica, a Firenze e a Roma, dall'anno 1873-74 in poi.
I primi studi sinologici in Italia risalivano alla fine del
XVI
secolo, agli anni nei
quali, cioè, il missionario Matteo Ricci da Macerata (1552-1610) organizzò le prime
missioni gesuite in Cina e iniziò a studiare il Cinese fino a impadronirsi perfettamente
di questa lingua, tanto da superarne anche le sue più ardue difficoltà, e da acquisire
una rara padronanza dei lessici e dei codici espressivi. In tal modo potè comporre una
quindicina di opere, tra le quali figura lo
Thien-cin-sei-i
(<<La vera Dottrina di Dio»)
un catechismo celeberrimo che fu inserito nella famosa «Raccolta delle opere classiche
cinesi». Il Ricci compilò anche un rinomato Dizionario Cinese che divenne lo stru–
mento base per tutti i successivi lavori dei sinologi occidentali. Dopo di lui un altro
missionario, il francescano Basilio da Gemona, compose due lessici, uno dei quali,
pubblicato nel 1699, fu considerato da Abel-Rémusat come il miglior dizionario rea–
lizzato fino a quei tempi.
Un secolo dopo, un nuovo contributo italiano in tema di lessicografia sinica si ebbe
per merito di Antonio Montucci da Siena: si tratta di un eccellente dizionario, accolto
dalla critica come un capolavoro «del quale sarebbe difficile immaginarne uno miglio–
re». Eppure, nonostante questa impareggiabile crescita delle ricerche sinologiche,
il
mondo della scienza torinese continua a brillare per la sua assenza. Sarà la comparsa
sulla scena di una personalità quale quella del Calleri a creare almeno un aggancio
ideale, seppure indiretto, fra Torino e la sinologia.
Giuseppe Maria Calleri nacque a Torino il 25 giugno 1810 da Gaetano e Maria
Gazzola e venne battezzato con i nomi di Giuseppe-Gaetano-Pietro-Massimo-Maria.
Nel 1815, quando avrebbe potuto optare per la nazionalità francese, egli non lo fece
né ritenne di farlo anni dopo. Entrò nel piccolo seminario di San Francesco di Sales a
Melan, dove potevano essere accolti anche i giovani piemontesi. Fu poi ordinato
Sacerdote a Parigi e partì poco dopo per la Cina con destinazione Macao. Cominciò
subito lo studio del Cinese e del Coreano, ma si sentiva contemporaneamente attratto
dalle scienze naturali, dalla botanica, dall' ornitologia, dalla mineralogia. Superate
alcune vicissitudini che confermavano la sua irrequietezza, nel 1841 pubblicò a
Macao la sua prima opera di sinologia, il
Sistema phoneticum scripturae sinicae;
nel
1842 rientrò a Parigi, dove rese pubblico il piano del suo Grande Dizionario, ma non
riuscì a reperire i fondi per realizzarne la pubblicazione. Dimessosi dalla Societé des
Missions Etrangères di Parigi, entrò al Ministero degli Esteri; poté poi ritornare a
Macao nel 1843, alle dipendenze del Consolato Francese. Di qui, dopo un soggiorno
alquanto tempestoso, fece ritorno a Parigi dove fu nominato «Segretario-interprete
per la lingua della Cina» al ministero degli Affari Esteri (1846). La sua elezione a
membro dell'Accademia delle Scienze di Torino (1844) lo agevolò ai fini di poter
pubblicare, in una edizione «magnifica» la sua traduzione del testo abbreviato del
Li–
Ki ou Mémorial des Rites:
la traduzione fu considerata degna di ogni elogio da
J.
Legge il quale giudicò le note che la illustravano, e alle quali egli dovette fare più
volte ricorso, addirittura mirabili. Il contributo del Calleri agli studi sinologici fu
indubbiamente cospicuo e di grande interesse: dal suo
Sistema Phoneticum Scripturae
Sinicae,
sopra citato, al
Dictionnaire Encyclopédique de la Langue Chinoise,
Tome Pre–
mier (Macao-Paris, 1844), al
Journal des Opérations Diplomatiques de la Légation
jrançaise en Chine
(Macao, 1845), e a tanti altri lavori, lasciò testimonianza tangibile
di un' attività intensa e intelligente. Purtroppo, dal 1847 in poi, la sua esistenza fu
amareggiata da contrasti, disavventure e intricate vicende giudiziarie, fomentate in
gran parte da rivalità e gelosie che dividevano allora i vari sinologi, e così complesse
che finirono col coinvolgere anche un grande studioso come Stanislao
J
ulien, a quei
tempi professore al Collège de France e Membro dell'Institut. Fu anche sottoposto a
una inchiesta amministrativa intesa a definire la «possession légitime» di sei opere
della Biblioteca Nazionale che il Calleri avrebbe illecitamente trattenuto. Triste tra-
275


















