
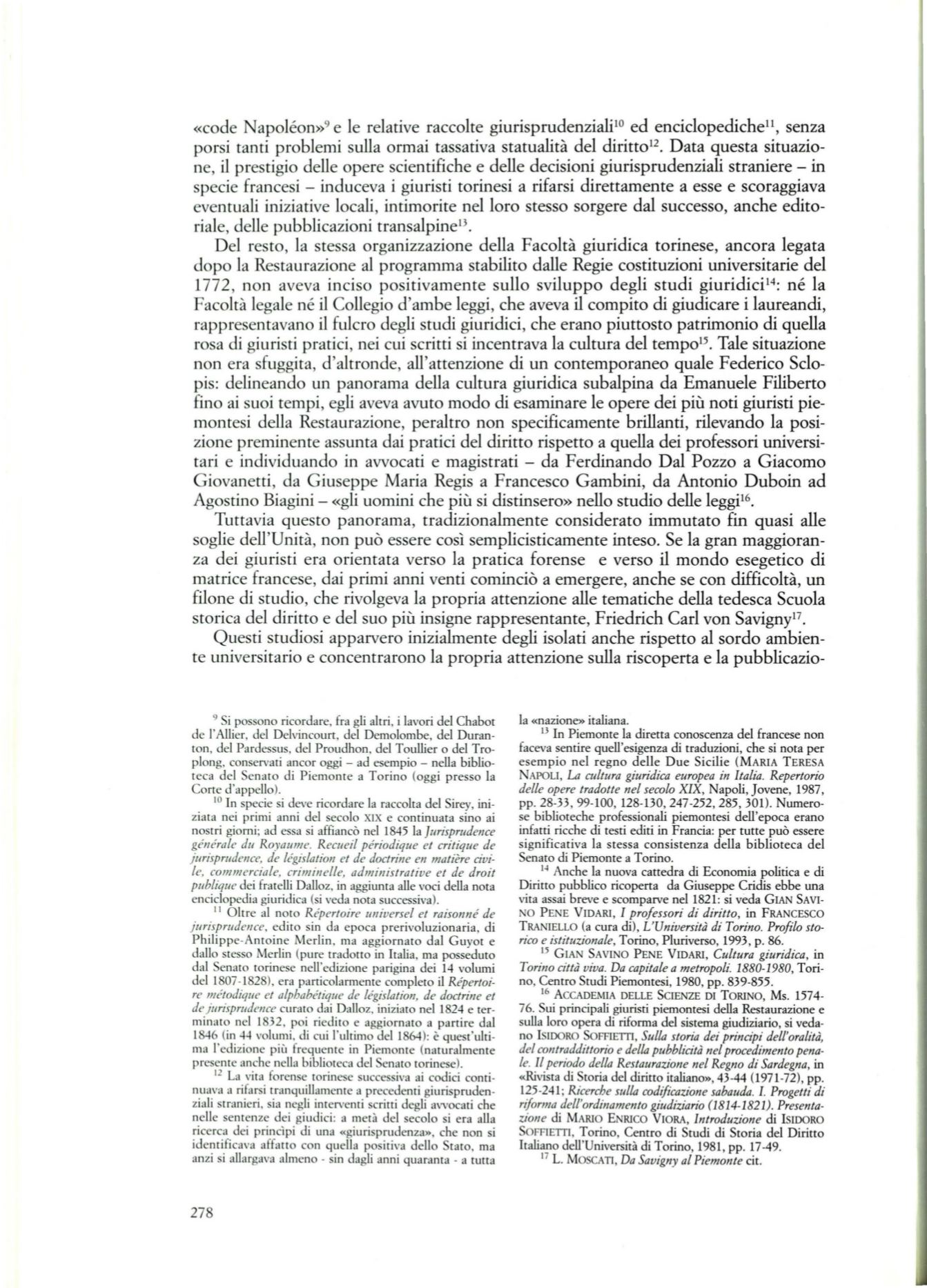
«code Napoléon»9e le relative raccolte giurisprudenziali
10
ed enciclopediche
Il,
senza
porsi tanti problemi sulla ormai tassativa statualità del diritto
I2 •
Data questa situazio–
ne, il prestigio delle opere scientifiche e delle decisioni giurisprudenziali straniere - in
specie francesi - induceva i giuristi torinesi a rifarsi direttamente a esse e scoraggiava
eventuali iniziative locali, intimorite nel loro stesso sorgere dal successo, anche edito–
riale, delle pubblicazioni transalpine
13 .
Del res to , la stessa organizzazione della Facoltà giuridica torinese, ancora legata
dopo la Restaurazione al programma stabilito dalle Regie costituzioni universitarie del
1772 ,
non aveva inciso positivamente sullo sviluppo degli studi giuridici
14 :
né la
Facoltà legale né
il
Collegio d'ambe leggi, che aveva il compito di giudicare i laureandi,
rappresentavano
il
fulcro degli studi giuridici, che erano piuttosto patrimonio di quella
rosa di giuristi pratici , nei cui scritti si incentrava la cultura del tempo
15.
Tale situazione
non era sfuggita, d 'altronde, all'attenzione di un contemporaneo quale Federico Sclo–
pis : delineando un panorama della cultura giuridica subalpina da Emanuele Filiberto
fino ai suoi tempi, egli aveva avuto modo di esaminare le opere dei più noti giuristi pie–
montesi della Restaurazione, peraltro non specificamente brillanti, rilevando la posi–
zione preminente assunta dai pratici del diritto rispetto a quella dei professori universi–
tari e individuando in awocati e magistrati - da Ferdinando Dal Pozzo a Giacomo
Giovanetti, da Giuseppe Maria Regis a Francesco Gambini, da Antonio Duboin ad
Agostino Biagini - «gli uomini che più si distinsero» nello studio delle leggil
6 •
Tuttavia questo panorama, tradizionalmente considerato immutato fin quasi alle
soglie dell 'Unità, non può essere così semplicisticamente inteso. Se la gran maggioran–
za dei giuristi era orientata verso la pratica forense e verso il mondo esegetico di
matrice francese, dai primi anni venti cominciò a emergere, anche se con difficoltà, un
filone di studio, che rivolgeva la propria attenzione alle tematiche della tedesca Scuola
storica del diritto e del suo più insigne rappresentante, Friedrich Cari von Savigny
17.
Questi studiosi apparvero inizialmente degli isolati anche rispetto al sordo ambien–
te universitario e concentrarono la propria attenzione sulla riscoperta e la pubblicazio-
9
Si possono ricordare, fra gli altri , i lavori del Chabot
de l'Allier, del Delvincourt, del Demolombe, del Duran–
ton, del Pardessus, del Proudhon, del Toullier o del Tro–
plong, conservati ancor oggi - ad esempio - nella biblio–
teca d el Senato di Piemonte a Torino (oggi presso la
Corte d'appe]Jo).
lO
In specie si deve ricordare la raccolta del Sirey, ini–
ziata nei primi anni del secolo
XIX
e continuata sino ai
nostri giorn i; ad essa si affiancò nel 1845 la
j urisprudence
générale dII Royaume. Recueil périodique et critique de
jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civi–
le, commerciale, criminelle, adminlstrative et de dro it
publique
dei fratelli Dalloz, in aggiunta alle voci della nota
enciclopedia giuridica (si veda nota successiva).
I l
O ltre al noto
Répertoire univerIel et raisonné de
jurisprudence,
ed ito sin da epoca prerivoluzionaria, di
P hilippe-Antoi ne Merlin , ma aggiornato dal Guyot e
dallo stesso Merlin (pure tradotto in Italia, ma posseduto
dal Senato torinese nell'edizione parigina dei 14 volumi
del 1807-1828), era particolarmente completo
il Répertoi–
re métodlqlle et alphabétique de légi.rlation, de doctrine et
de j llri.rprudence
curato dai Dalloz, iniziato nel 1824 e ter–
minato nel 1832, poi ried ito e aggiornato a partire dal
1846 (in 44 volumi , di cui l'ultimo del 1864):
è
quest 'ulti–
ma l'edizione più frequente in Piemonte (naturalmente
presente anche nella biblioteca del Senato torinese).
12
La vita forense torinese successiva ai codici conti–
nuava a rifarsi tranquillamente a precedenti giurispruden–
ziali stranieri, sia negli interventi scritti degli avvocati che
nelle sentenze dei giudici: a metà del secolo si era alla
ricerca dei princìpi di una «giurisprudenza», che non si
identificava affatto con quella positiva dello Stato, ma
anzi si allargava almeno - sin dagli anni quaranta - a tutta
278
la < nazione» italiana.
I3
In Piemonte la diretta conoscenza del francese non
faceva sentire quell'esigenza di traduzioni, che si nota per
esempio nel regno delle Due Sicilie (MARIA TERESA
NAPOLI,
La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio
delle opere tradotte nel secolo XIX,
Napoli, Jovene, 1987,
pp. 28-33, 99-100, 128-130, 247-252, 285, 301). Numero–
se biblioteche professionali piemontesi dell'epoca erano
infatti ricche di testi editi in Francia: per tutte può essere
significativa la stessa consistenza della biblioteca del
Senato di Piemonte a Torino.
l-l
Anche la nuova cattedra di Economia politica e di
Diritto pubblico ricoperta da Giuseppe Cridis ebbe una
vita assai breve e scomparve nel 1821: si vèda GIAN SAVI–
NO PENE VlDARI,
I professori di diritto,
in FRANCESCO
TRANIELLO (a cura di) ,
L'Università di Torino. Profilo sto–
rico e istituzionale,
Torino, Pluriverso, 1993, p. 86.
15
GIAN SAVINO PENE VlDARI,
Cultura giuridica,
in
Torino città viva. Da capitale a metropoli. 1880-1980,
Tori–
no, Centro Studi Piemontesi, 1980, pp. 839-855.
16
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO, Ms. 1574-
76. Sui principali giuristi piemontesi della Restaurazione e
sulla loro opera di riforma del sistema giudiziario, si veda–
no ISIOORO SOFFIElTl,
Sulla storia dei principi dell'oralità,
del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento pena–
le. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna,
in
«Rivista di Storia del diritto italiano», 43 -44 (1971-72), pp.
125-241; Ricerche sulla codificazione sabauda.
1.
Progetti di
nforma dell'ordinamento giudiziario
(1814-1821).
Presenta–
zione
di MARIO ENRICO VrORA,
Introduzione
di ISIDORO
SOFFI ETTI, Torino, Centro di Studi di Storia del Diritto
Italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 17-49.
17
L.
MOSCATI ,
Da Savigny al Piemonte
cito


















