
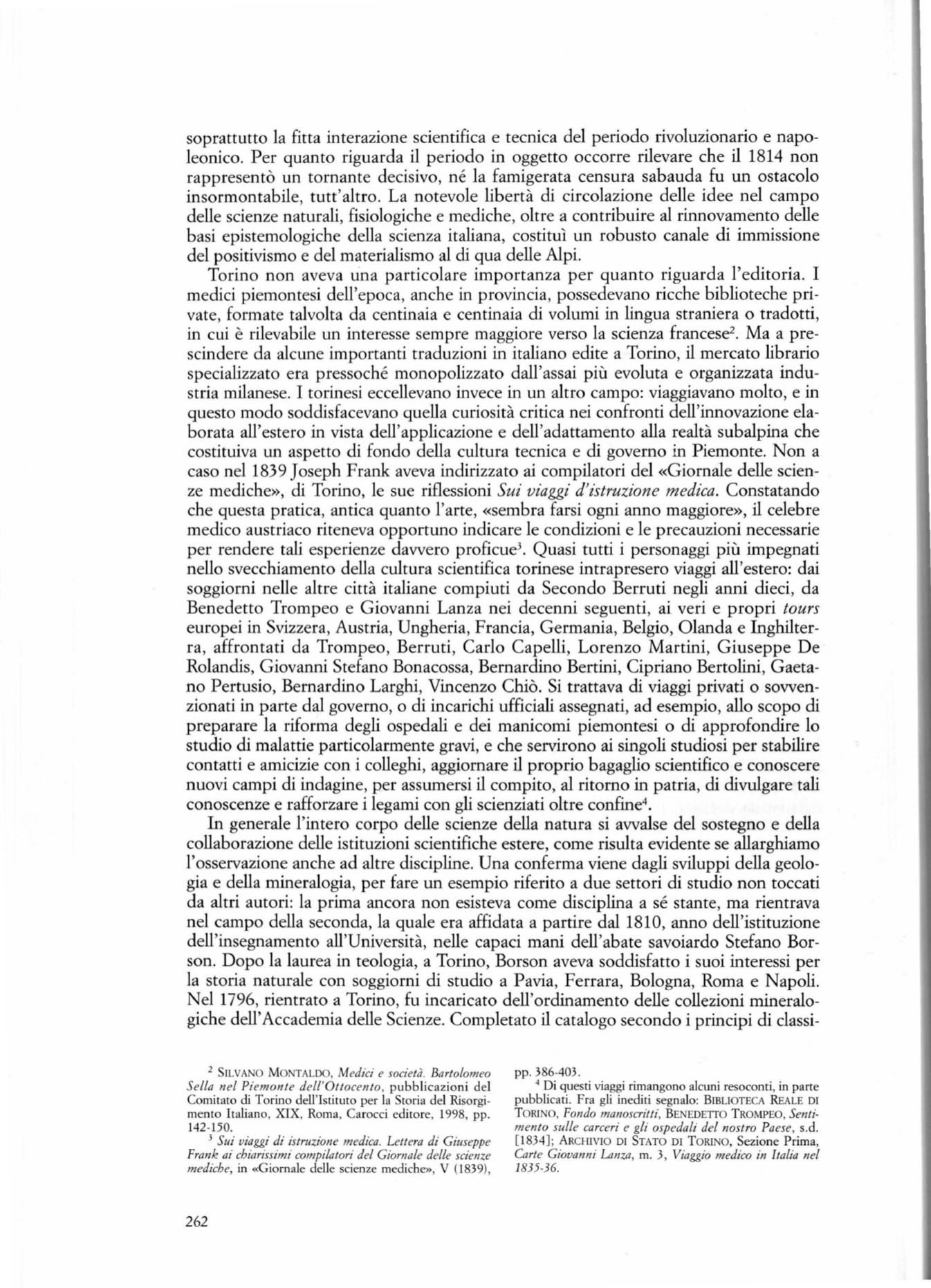
soprattutto la fitta interazione scientifica e tecnica del periodo rivoluzionario e napo–
leonico. Per quanto riguarda il periodo in oggetto occorre rilevare che il 1814 non
rappresentò un tornante decisivo, né la famigerata censura sabauda fu un ostacolo
insormontabile, tutt 'altro. La notevole libertà di circolazione delle idee nel campo
delle scienze naturali, fisiologiche e mediche, oltre a contribuire al rinnovamento delle
basi epistemologiche della scienza italiana, costituì un robusto canale di immissione
del positivismo e del materialismo al di qua delle Alpi.
Torino non aveva una particolare importanza per quanto riguarda l'editoria. I
medici piemontesi dell 'epoca, anche in provincia, possedevano ricche biblioteche pri–
vate, formate talvolta da centinaia e centinaia di volumi in lingua straniera o tradotti,
in cui è rilevabile un interesse sempre maggiore verso la scienza francese2. Ma a pre–
scindere da alcune importanti traduzioni in italiano edite a Torino, il mercato librario
specializzato era pressoché monopolizzato dall'assai più evoluta e organizzata indu–
stria milanese. I torinesi eccellevano invece in un altro campo: viaggiavano molto, e in
questo modo soddisfacevano quella curiosità critica nei confronti dell'innovazione ela–
borata all' estero in vista dell'applicazione e dell'adattamento alla realtà subalpina che
costituiva un aspetto di fondo della cultura tecnica e di governo in Piemonte. Non a
caso nel 1839 Joseph Frank aveva indirizzato ai compilatori del «Giornale delle scien–
ze mediche», di Torino, le sue riflessioni
Sui viaggi d)istruzione medica.
Constatando
che questa pratica, antica quanto l'arte, «sembra farsi ogni anno maggiore», il celebre
medico austriaco riteneva opportuno indicare le condizioni e le precauzioni necessarie
per rendere tali esperienze davvero proficue
3 .
Quasi tutti i personaggi più impegnati
nello svecchiamento della cultura scientifica torinese intrapresero viaggi all'estero: dai
soggiorni nelle altre città italiane compiuti da Secondo Berruti negli anni dieci, da
Benedetto Trompeo e Giovanni Lanza nei decenni seguenti, ai veri e propri
tours
europei in Svizzera, Austria, Ungheria, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Inghilter–
ra, affrontati da Trompeo, Berruti, Carlo Capelli, Lorenzo Martini, Giuseppe De
Rolandis, Giovanni Stefano Bonacossa, Bernardino Bertini, Cipriano Bertolini, Gaeta–
no Pertusio, Bernardino Larghi, Vincenzo Chiò. Si trattava di viaggi privati o sovven–
zionati in parte dal governo, o di incarichi ufficiali assegnati, ad esempio, allo scopo di
preparare la riforma degli ospedali e dei manicomi piemontesi o di approfondire lo
studio di malattie particolarmente gravi, e che servirono ai singoli studiosi per stabilire
contatti e amicizie con i colleghi, aggiornare il proprio bagaglio scientifico e conoscere
nuovi campi di indagine, per assumersi il compito, al ritorno in patria, di divulgare tali
conoscenze e rafforzare i legami con gli scienziati oltre confine
4 •
In generale l'intero corpo delle scienze della natura si avvalse del sostegno e della
collaborazione delle istituzioni scientifiche estere, come risulta evidente se allarghiamo
l'osservazione anche ad altre discipline. Una conferma viene dagli sviluppi della geolo–
gia e della mineralogia, per fare un esempio riferito a due settori di studio non toccati
da altri autori: la prima ancora non esisteva come disciplina a sé stante, ma rientrava
nel campo della seconda, la quale era affidata a partire dal 1810, anno dell 'istituzione
dell'insegnamento all'Università, nelle capaci mani dell'abate savoiardo Stefano Bor–
sono Dopo la laurea in teologia, a Torino, Borson aveva soddisfatto i suoi interessi per
la storia naturale con soggiorni di studio a Pavia, Ferrara, Bologna, Roma e Napoli.
Nel 1796, rientrato a Torino, fu incaricato dell'ordinamento delle collezioni mineralo–
giche dell'Accademia delle Scienze. Completato il catalogo secondo i principi di classi-
2
SILVA
°
Mo
TALDO,
Medici e società. Bartolomeo
Sella nel Piemonte dell'Ottocento ,
pubb licazioni del
Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi–
mento Italian o, XIX, Roma, Carocci editore, 1998, pp.
142-150.
3
Sui viaggi di istruzione medica. Lettera di Giuseppe
Frank ai chiarissimi compilatori del Giornale delle scienze
mediche,
in «Gio rnale delle scienze mediche»,
V
(1839),
262
pp. 386-403.
4
Di questi viaggi rimangono alcuni resoconti, in parte
pubblicati. Fra gli inediti segnalo: BIBLIOTECA REALE
DI
TORI NO,
Fondo manoscritti,
BENEDETTO TROMPEO,
Senti–
mento sulle carceri e gli ospedali del nostro Paese,
s.d.
[1834]; ARCHIVIO DI STATO
DI
TORINO, Sezione Prima,
Carte Giovanni Lanza,
m. 3,
Viaggio medico in Italia nel
1835-36.


















