
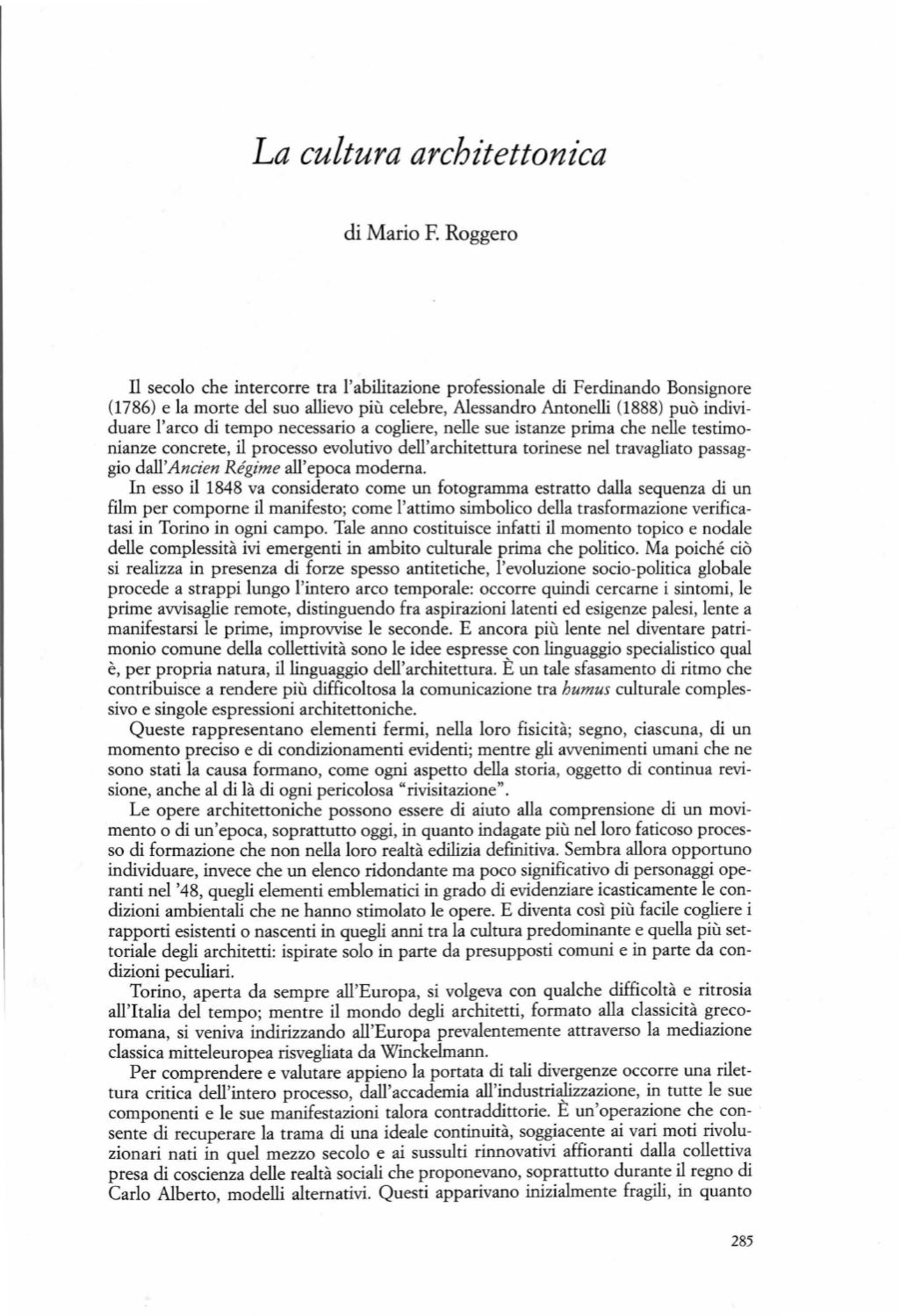
La cultura architettonica
di Mario
F.
Roggero
Il secolo che intercorre tra l'abilitazione professionale di Ferdinando Bonsignore
(1786)
e la morte del suo allievo più celebre, Alessandro Antonelli
(1888)
può indivi–
duare l'arco di tempo necessario a cogliere, nelle sue istanze prima che nelle testimo–
nianze concrete, il processo evolutivo dell' architettura torinese nel travagliato passag–
gio
dall'Ancien Régime
all' epoca moderna.
In esso il
1848
va considerato come un fotogramma estratto dalla sequenza di un
film per comporne il manifesto; come l'attimo simbolico della trasformazione verifica–
tasi in Torino in ogni campo. Tale anno costituisce infatti il momento topico e nodale
delle complessità ivi emergenti in ambito culturale prima che politico. Ma poiché ciò
si realizza in presenza di forze spesso antitetiche, l'evoluzione socio-politica globale
procede a strappi lungo l'intero arco temporale: occorre quindi cercarne i sintomi, le
prime avvisaglie remote, distinguendo fra aspirazioni latenti ed esigenze palesi, lente a
manifestarsi le prime, improvvise le seconde. E ancora più lente nel diventare patri–
monio comune della collettività sono le idee espresse con linguaggio specialistico qual
è,
per propria natura, il linguaggio dell' architettura.
È
un tale sfasamento di ritmo che
contribuisce a rendere più difficoltosa la comunicazione tra
humus
culturale comples–
sivo e singole espressioni architettoniche.
Queste rappresentano elementi fermi, nella loro fisicità; segno, ciascuna, di un
momento preciso e di condizionamenti evidenti; mentre gli avvenimenti umani che ne
sono stati la causa formano, come ogni aspetto della storia, oggetto di continua revi–
sione, anche al di là di ogni pericolosa "rivisitazione".
Le opere architettoniche possono essere di aiuto alla comprensione di un movi–
mento o di un'epoca, soprattutto oggi, in quanto indagate più nel loro faticoso proces–
so di formazione che non nella loro realtà edilizia definitiva. Sembra allora opportuno
individuare, invece che un elenco ridondante ma poco significativo di personaggi ope–
ranti nel
'48,
quegli elementi emblematici in grado di evidenziare icasticamente le con–
dizioni ambientali che ne hanno stimolato le opere. E diventa così più facile cogliere i
rapporti esistenti o nascenti in quegli anni tra la cultura predominante e quella più set–
toriale degli architetti: ispirate solo in parte da presupposti comuni e in parte da con–
dizioni peculiari.
Torino, aperta da sempre all'Europa, si volgeva con qualche difficoltà e ritrosia
all'Italia del tempo; mentre il mondo degli architetti, formato alla classicità greco–
romana, si veniva indirizzando all'Europa prevalentemente attraverso la mediazione
classica mitteleuropea risvegliata da Winckelmann.
Per comprendere e valutare appieno la portata di tali divergenze occorre una rilet–
tura critica dell'intero processo, dall' accademia all'industria}izzazione, in tutte le sue
componenti e le sue manifestazioni talora contraddittorie. E un'operazione che con–
sente di recuperare la trama di una ideale continuità, soggiacente ai vari moti rivolu–
zionari nati in quel mezzo secolo e ai sussulti rinnovativi affioranti dalla collettiva
presa di coscienza delle realtà sociali che proponevano, soprattutto durante il regno di
Carlo Alberto, modelli alternativi. Questi apparivano inizialmente fragili, in quanto
285


















