
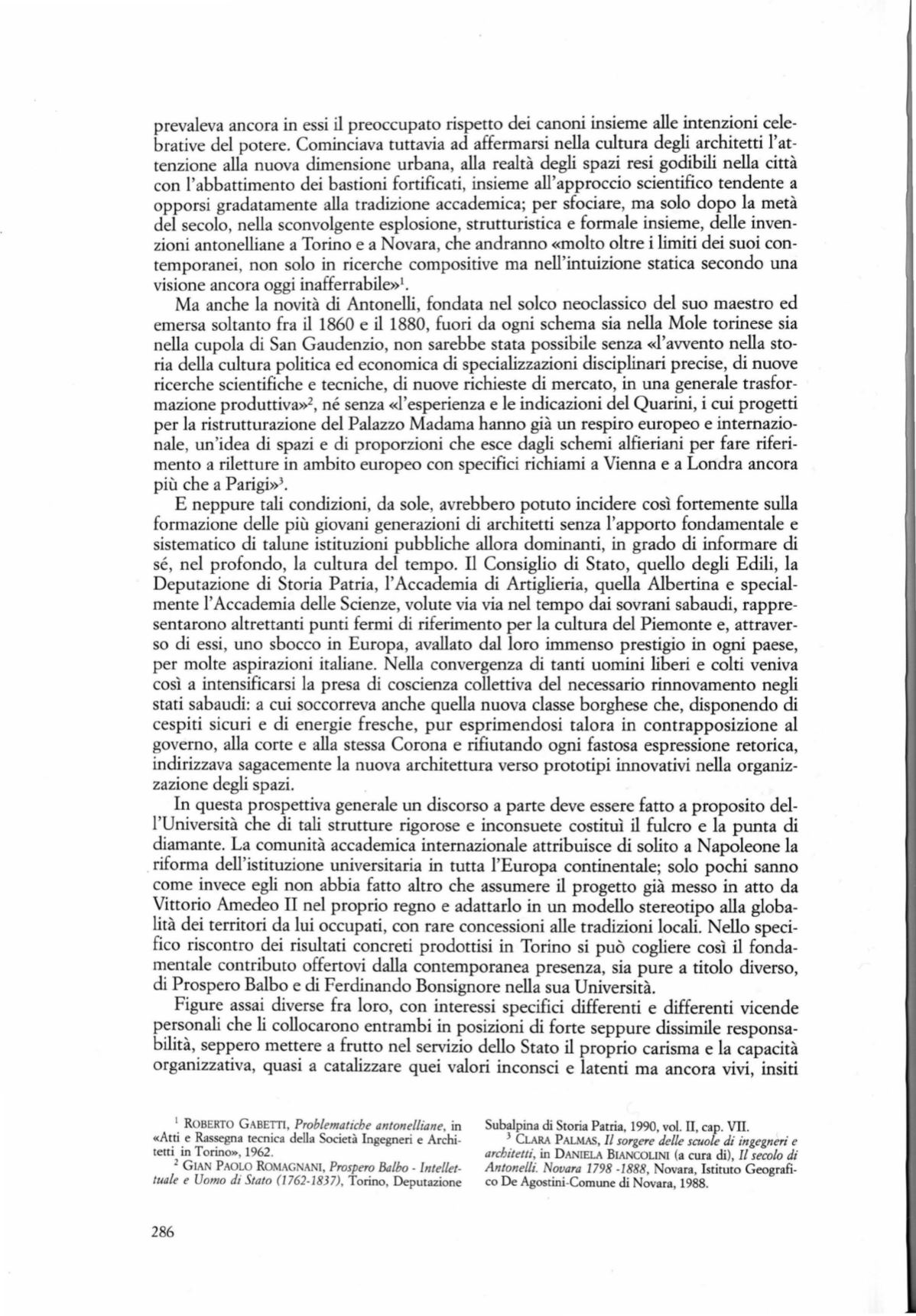
prevaleva ancora in essi il preoccupato rispetto dei canoni insieme alle intenzioni cele–
brative del potere. Cominciava tuttavia ad affermarsi nella cultura degli architetti l'at–
tenzione alla nuova dimensione urbana, alla realtà degli spazi resi godibili nella città
con l'abbattimento dei bastioni fortificati, insieme all' approccio scientifico tendente a
opporsi gradatamente alla tradizione accademica; per sfociare, ma solo dopo la metà
del secolo, nella sconvolgente esplosione, strutturistica e formale insieme, delle inven–
zioni antonelliane a Torino e a Novara, che andranno «molto oltre i limiti dei suoi con–
temporanei, non solo in ricerche compositive ma nell'intuizione statica secondo una
visione ancora oggi inafferrabile»!.
Ma anche la novità di Antonelli, fondata nel solco neoclassico del suo maestro ed
emersa soltanto fra il 1860 e il 1880, fuori da ogni schema sia nella Mole torinese sia
nella cupola di San Gaudenzio, non sarebbe stata possibile senza «l'avvento nella sto–
ria della cultura politica ed economica di specializzazioni disciplinari precise, di nuove
ricerche scientifiche e tecniche, di nuove richieste di mercato, in una generale trasfor–
mazione produttiva»2, né senza «l'esperienza e le indicazioni del Quarini, i cui progetti
per la ristrutturazione del Palazzo Madama hanno già un respiro europeo e internazio–
nale, un'idea di spazi e di proporzioni che esce dagli schemi alfieriani per fare riferi–
mento a riletture in ambito europeo con specifici richiami a Vienna e a Londra ancora
più che a Parigi»3.
E neppure tali condizioni, da sole, avrebbero potuto incidere cosÌ fortemente sulla
formazione delle più giovani generazioni di architetti senza l'apporto fondamentale e
sistematico di talune istituzioni pubbliche allora dominanti, in grado di informare di
sé, nel profondo, la cultura del tempo. Il Consiglio di Stato, quello degli Edili, la
Deputazione di Storia Patria, l'Accademia di Artiglieria, quella Albertina e special–
mente l'Accademia delle Scienze, volute via via nel tempo dai sovrani sabaudi, rappre–
sentarono altrettanti punti fermi di riferimento per la cultura del Piemonte e, attraver–
so di essi, uno sbocco in Europa, avallato dal loro immenso prestigio in ogni paese,
per molte aspirazioni italiane. Nella convergenza di tanti uomini liberi e colti veniva
così a intensificarsi la presa di coscienza collettiva del necessario rinnovamento negli
stati sabaudi: a cui soccorreva anche quella nuova classe borghese che, disponendo di
cespiti sicuri e di energie fresche, pur esprimendosi talora in contrapposizione al
governo, alla corte e alla stessa Corona e rifiutando ogni fastosa espressione retorica,
indirizzava sagacemente la nuova architettura verso prototipi innovativi nella organiz–
zazione degli spazi.
In questa prospettiva generale un discorso a parte deve essere fatto a proposito del–
l'Università che di tali strutture rigorose e inconsuete costituì il fulcro e la punta di
diamante. La comunità accademica internazionale attribuisce di solito a Napoleone la
. riforma dell'istituzione universitaria in tutta l'Europa continentale; solo pochi sanno
come invece egli non abbia fatto altro che assumere il progetto già messo in atto da
Vittorio Amedeo II nel proprio regno e adattarlo in un modello stereotipo alla globa–
lità dei territori da lui occupati, con rare concessioni alle tradizioni locali. Nello speci–
fico riscontro dei risultati concreti prodottisi in Torino si può cogliere così il fonda–
mentale contributo offertovi dalla contemporanea presenza, sia pure a titolo diverso,
di Prospero Balbo e di Ferdinando Bonsignore nella sua Università.
Figure assai diverse fra loro, con interessi specifici differenti e differenti vicende
personali che li collocarono entrambi in posizioni di forte seppure dissimile responsa–
bilità, seppero mettere a frutto nel servizio dello Stato il proprio carisma e la capacità
organizzativa, quasi a catalizzare quei valori inconsci e latenti ma ancora vivi, insiti
l
ROBERTO GABETTI,
Problematiche antonelliane,
in
«Atti e Rassegna tecnica della Società Ingegneri e Archi–
tetti in Torino», 1962.
2
GIAN PAOLO ROMAGNANI,
Prospero Balbo
-
Intellet–
tuale e Uomo di Stato
(1762-1837),
Torino, Deputazione
286
Subalpina di Storia Patria, 1990, voI. II, cap.
VII.
3
CLARA PALMAS,
Il sorgere delle scuole di ingegneri e
architetti,
in DANIELA BIANCOLINI (a cura di),
Il secolo di
Antonelli. Novara
1798 -1 888,
Novara, Istituto Geografi–
co De Agostini-Comune di Novara, 1988.


















