
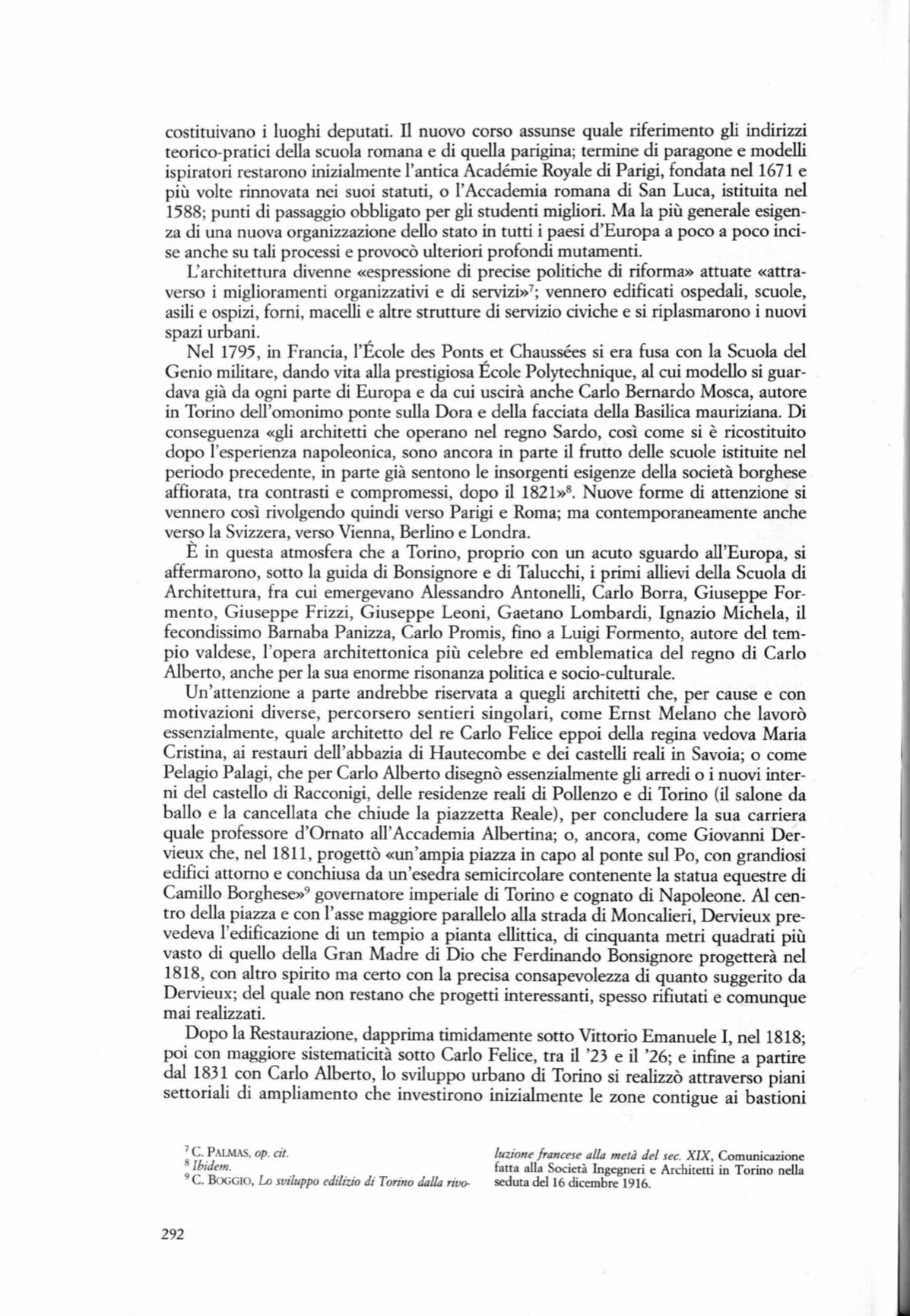
costituivano i luoghi deputati. Il nuovo corso assunse quale riferimento gli indirizzi
teorico-pratici della scuola romana e di quella parigina; termine di paragone e modelli
ispiratori restarono inizialmente l'antica Académie Royale di Parigi, fondata nel
1671
e
più volte rinnovata nei suoi statuti, o l'Accademia romana di San Luca, istituita nel
1588;
punti di passaggio obbligato per gli studenti migliori. Ma la più generale esigen–
za di una nuova organizzazione dello stato in tutti i paesi d'Europa a poco a poco inci–
se anche su tali processi e provocò ulteriori profondi mutamenti.
L'architettura divenne «espressione di precise politiche di riforma» attuate «attra–
verso i miglioramenti organizzativi e di servizi»7; vennero edificati ospedali, scuole,
asili e ospizi, forni, macelli e altre strutture di servizio civiche e si riplasmarono i nuovi
spazi urbani.
Nel
1795,
in Francia, l'École des Ponts et Chaussées si era fusa con la Scuola del
Genio militare, dando vita alla prestigiosa École Polytechnique, al cui modello si guar–
dava già da ogni parte di Europa e da cui uscirà anche Carlo Bernardo Mosca, autore
in Torino dell'omonimo ponte sulla Dora e della facciata della Basilica mauriziana. Di
conseguenza «gli architetti che operano nel regno Sardo, così come si
è
ricostituito
dopo l'esperienza napoleonica, sono ancora in parte il frutto delle scuole istituite nel
periodo precedente, in parte già sentono le insorgenti esigenze della società borghese
affiorata, tra contrasti e compromessi, dopo il
1821»8.
Nuove forme di attenzione si
vennero così rivolgendo quindi verso Parigi e Roma; ma contemporaneamente anche
verso la Svizzera, verso Vienna, Berlino e Londra.
È
in questa atmosfera che a Torino, proprio con un acuto sguardo all'Europa, si
affermarono, sotto la guida di Bonsignore e di Talucchi, i primi allievi della Scuola di
Architettura, fra cui emergevano Alessandro Antonelli, Carlo Borra, Giuseppe For–
mento, Giuseppe Frizzi, Giuseppe Leoni, Gaetano Lombardi, Ignazio Michela,
il
fecondissimo Barnaba Panizza, Carlo Promis, fino a Luigi Formento, autore del tem–
pio valdese, l'opera architettonica più celebre ed emblematica del regno di Carlo
Alberto, anche per la sua enorme risonanza politica e socio-culturale.
Un'attenzione a parte andrebbe riservata a quegli architetti che, per cause e con
motivazioni diverse, percorsero sentieri singolari, come Ernst Melano che lavorò
essenzialmente, quale architetto del re Carlo Felice eppoi della regina vedova Maria
Cristina, ai restauri dell' abbazia di Hautecombe e dei castelli reali in Savoia; o come
Pelagio Palagi, che per Carlo Alberto disegnò essenzialmente gli arredi o i nuovi inter–
ni del castello di Racconigi, delle residenze reali di Pollenzo e di Torino (il salone da
ballo e la cancellata che chiude la piazzetta Reale), per concludere la sua carriera
quale professore d'Ornato all'Accademia Albertina; o, ancora, come Giovanni Der–
vieux che, nel
1811 ,
progettò «un'ampia piazza in capo al ponte sul Po, con grandiosi
edifici attorno e conchiusa da un'esedra semicircolare contenente la statua equestre di
Camillo Borghese»9governatore imperiale di Torino e cognato di Napoleone. Al cen–
tro della piazza e con l'asse maggiore parallelo alla strada di Moncalieri, Dervieux pre–
vedeva l'edificazione di un tempio a pianta ellittica, di cinquanta metri quadrati più
vasto di quello della Gran Madre di Dio che Ferdinando Bonsignore progetterà nel
1818,
con altro spirito ma certo con la precisa consapevolezza di quanto suggerito da
Dervieux; del quale non restano che progetti interessanti, spesso rifiutati e comunque
mai realizzati.
Dopo la Restaurazione, dapprima timidamente sotto Vittorio Emanuele I, nel
1818;
poi con maggiore sistematicità sotto Carlo Felice, tra il
'23
e il
'26;
e infine a partire
dal
1831
con Carlo Alberto, lo sviluppo urbano di Torino si realizzò attraverso piani
settoriali di ampliamento che investirono inizialmente le zone contigue ai bastioni
292
7
C.
P ALMAS,
Op.
cito
8
Ibidem.
9
C.
BOGGIO,
Lo sviluppo edilizio di Torino dalla rivo-
luzione francese alla metà del sec. XIX,
Comunicazione
fatta alla Società Ingegneri e Architetti in Torino nella
seduta del 16 dicembre 1916.


















