
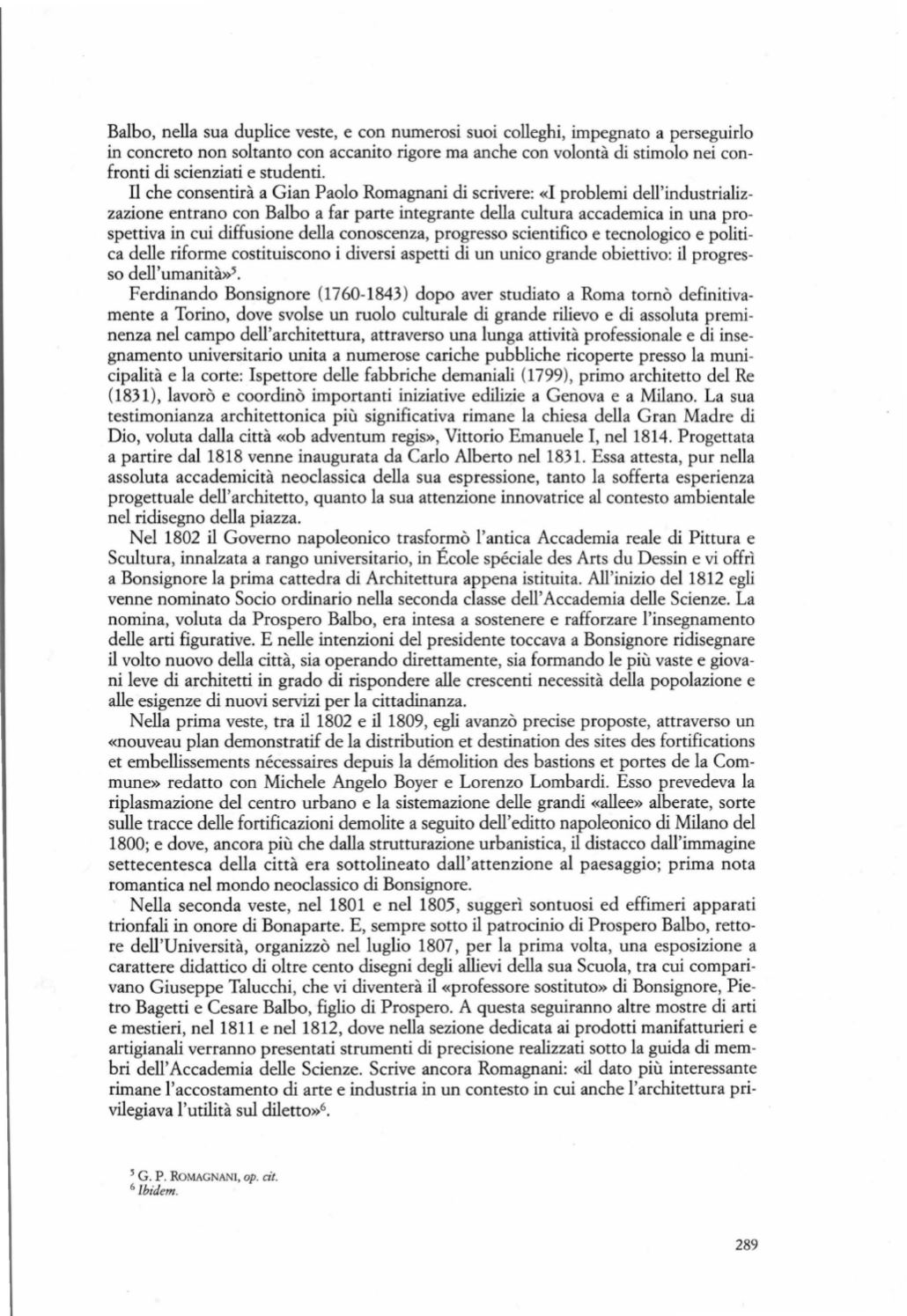
Balbo, nella sua duplice veste, e con numerosi suoi colleghi, impegnato a perseguirlo
in concreto non soltanto con accanito rigore ma anche con volontà di stimolo nei con–
fronti di scienziati e studenti.
Il che consentirà a Gian Paolo Romagnani di scrivere: «I problemi dell'industrializ–
zazione entrano con Balbo a far parte integrante della cultura accademica in una pro–
spettiva in cui diffusione della conoscenza, progresso scientifico e tecnologico e politi–
ca delle riforme costituiscono i diversi aspetti di un unico grande obiettivo: il progres–
so dell'umanità»5.
Ferdinando Bonsignore
(1760-1843)
dopo aver studiato a Roma tornò definitiva–
mente a Torino, dove svolse un ruolo culturale di grande rilievo e di assoluta premi–
nenza nel campo dell' architettura, attraverso una lunga attività professionale e di inse–
gnamento universitario unita a numerose cariche pubbliche ricoperte presso la muni–
cipalità e la corte: Ispettore delle fabbriche demaniali
(1799) ,
primo architetto del Re
(1831),
lavorò e coordinò importanti iniziative edilizie a Genova e a Milano. La sua
testimonianza architettonica più significativa rimane la chiesa della Gran Madre di
Dio, voluta dalla città «ob adventum regis», Vittorio Emanuele
I,
nel
1814.
Progettata
a partire dal
1818
venne inaugurata da Carlo Alberto nel
1831.
Essa attesta, pur nella
assoluta accademicità neoclassica della sua espressione, tanto la sofferta esperienza
progettuale dell' architetto, quanto la sua attenzione innovatrice al contesto ambientale
nel ridisegno della piazza.
Nel
1802
il Governo napoleonico trasformò l'antica Accademia reale di Pittura e
Scultura, innalzata a rango universitario, in École spéciale des Arts du Dessin e vi offrì
a Bonsignore la prima cattedra di Architettura appena istituita. All'inizio del
1812
egli
venne nominato Socio ordinario nella seconda classe dell'Accademia delle Scienze. La
nomina, voluta da Prospero Balbo, era intesa a sostenere e rafforzare l'insegnamento
delle arti figurative. E nelle intenzioni del presidente toccava a Bonsignore ridisegnare
il volto nuovo della città, sia operando direttamente, sia formando le più vaste e giova–
ni leve di architetti in grado di rispondere alle crescenti necessità della popolazione e
alle esigenze di nuovi servizi per la cittadinanza.
Nella prima veste, tra il
1802
e il
1809,
egli avanzò precise proposte, attraverso un
«nouveau pIan demonstratif de la distribution et destination des sites des fortifications
et embellissements nécessaires depuis la démolition des bastions et portes de la Com–
mune» redatto con Michele Angelo Boyer e Lorenzo Lombardi. Esso prevedeva la
riplasmazione del centro urbano e la sistemazione delle grandi «allee» alberate, sorte
sulle tracce delle fortificazioni demolite a seguito dell'editto napoleonico di Milano del
1800;
e dove, ancora più che dalla strutturazione urbanistica, il distacco dall'immagine
settecentesca della città era sottolineato dall ' attenzione al paesaggio; prima nota
romantica nel mondo neoclassico di Bonsignore.
, Nella seconda veste, nel
1801
e nel
1805,
suggerì sontuosi ed effimeri apparati
trionfali in onore di Bonaparte. E, sempre sotto il patrocinio di Prospero Balbo, retto–
re dell'Università, organizzò nel luglio
1807,
per la prima volta, una esposizione a
carattere didattico di oltre cento disegni degli allievi della sua Scuola, tra cui compari–
vano Giuseppe Talucchi, che vi diventerà il «professore sostituto» di Bonsignore, Pie–
tro Bagetti e Cesare Balbo, figlio di Prospero. A questa seguiranno altre mostre di arti
e mestieri, nel
1811
e nel
1812,
dove nella sezione dedicata ai prodotti manifatturieri e
artigianali verranno presentati strumenti di precisione realizzati sotto la guida di mem–
bri dell'Accademia delle Scienze. Scrive ancora Romagnani: «il dato più interessante
rimane l'accostamento di arte e industria in un contesto in cui anche l'architettura pri–
vilegiava l'utilità sul diletto»6.
j
G. P.
ROMAGNANI,
op.
cito
6
Ibidem.
289


















