
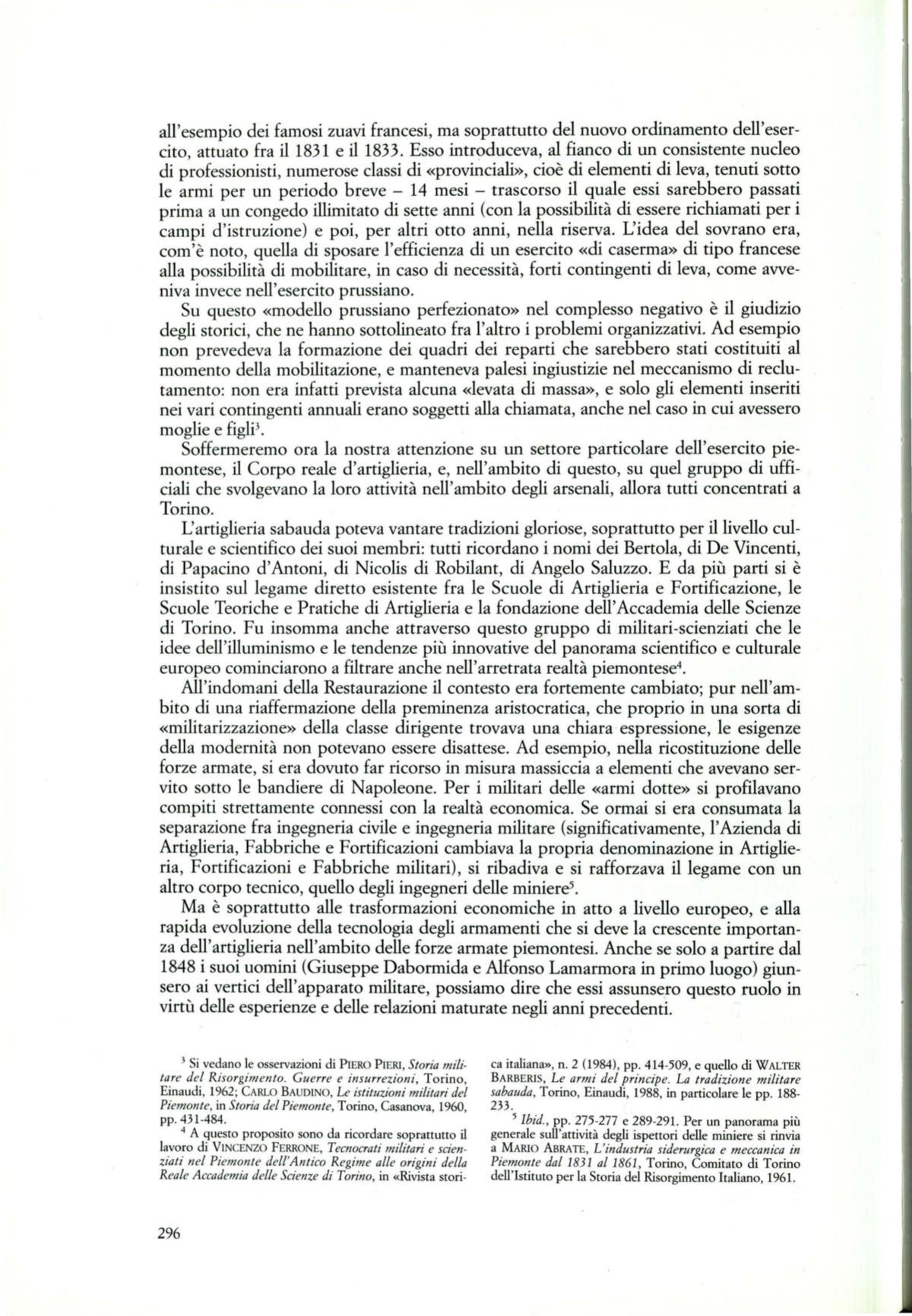
all'esempio dei famosi zuavi francesi, ma soprattutto del nuovo ordinamento dell'eser–
cito attuato fra il 1831 e il 1833 . Esso introduceva, al fianco di un consistente nucleo
,
.
di professionisti, numerose classi di «provinciali», cioè di elementi di leva, tenuti sotto
le armi per un periodo breve - 14 mesi - trascorso il quale essi sarebbero passati
prima a un congedo illimitato di sette anni (con la possibilità di essere richiamati per i
campi d 'istruzione) e poi, per altri otto anni, nella riserva. L'idea del sovrano era,
com'è noto, quella di sposare l'efficienza di un esercito «di caserma» di tipo francese
alla possibilità di mobilitare, in caso di necessità, forti contingenti di leva, come avve–
niva invece nell'esercito prussiano.
Su questo «modello prussiano perfezionato» nel complesso negativo è il giudizio
degli storici, che ne hanno sottolineato fra l'altro i problemi organizzativi. Ad esempio
non prevedeva la formazione dei quadri dei reparti che sarebbero stati costituiti al
momento della mobilitazione, e manteneva palesi ingiustizie nel meccanismo di reclu–
tamento: non era infatti prevista alcuna «levata di massa», e solo gli elementi inseriti
nei vari contingenti annuali erano soggetti alla chiamata, anche nel caso in cui avessero
moglie e figli
3 •
Soffermeremo ora la nostra attenzione su un settore particolare dell'esercito pie–
montese, il Corpo reale d'artiglieria, e, nell' ambito di questo, su quel gruppo di uffi–
ciali che svolgevano la loro attività nell' ambito degli arsenali, allora tutti concentrati a
Torino.
L'artiglieria sabauda poteva vantare tradizioni gloriose, soprattutto per il livello cul–
turale e scientifico dei suoi membri: tutti ricordano i nomi dei Bertola, di De Vincenti,
di Papacino d 'Antoni, di Nicolis di Robilant, di Angelo Saluzzo. E da più parti si è
insistito sul legame diretto esistente fra le Scuole di Artiglieria e Fortificazione, le
Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e la fondazione dell'Accademia delle Scienze
di Torino. Fu insomma anche attraverso questo gruppo di militari-scienziati che le
idee dell'illuminismo e le tendenze più innovative del panorama scientifico e culturale
europeo cominciarono a filtrare anche nell 'arretrata realtà piemontese
4 .
All'indomani della Restaurazione il contesto era fortemente cambiato; pur nell'am–
bito di una riaffermazione della preminenza aristocratica, che proprio in una sorta di
«militarizzazione» della classe dirigente trovava una chiara espressione, le esigenze
della modernità non potevano essere disattese. Ad esempio, nella ricostituzione delle
forze armate, si era dovuto far ricorso in misura massiccia a elementi che avevano ser–
vito sotto le bandiere di Napoleone. Per i militari delle «armi dotte» si profilavano
compiti strettamente connessi con la realtà economica. Se ormai si era consumata la
separazione fra ingegneria civile e ingegneria militare (significativamente, l'Azienda di
Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni cambiava la propria denominazione in Artiglie–
ria , Fortificazioni e Fabbriche militari), si ribadiva e si rafforzava il legame con un
altro corpo tecnico, quello degli ingegneri delle miniere5.
Ma è soprattutto alle trasformazioni economiche in atto a livello europeo, e alla
rapida evoluzione della tecnologia degli armamenti che si deve la crescente importan–
za dell'artiglieria nell' ambito delle forze armate piemontesi. Anche se solo a partire dal
1848 i suoi uomini (Giuseppe Dabormida e Alfonso Lamarmora in primo luogo) giun–
sero ai vertici dell'apparato militare, possiamo dire che essi assunsero questo ruolo in
virtù delle esperienze e delle relazioni maturate negli anni precedenti.
3
Si vedano le osservazioni di PIERO PIERI,
Storia mili–
tare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni,
To rino,
Einaudi, 1962; CARLO BAUDINO,
Le istituzioni militari del
Piemonte,
in
Storia del Piemonte,
Torino, Casanova, 1960,
pp. 431-484.
4
A questo proposito sono da ricordare soprattutto
il
lavoro di VINCENZO FERRONE,
Tecnocrati militari e scien–
ziati nel Piemonte dell'Antico Regime alle origini della
Reale Accademia delle Scienze di Torino,
in «Rivista stori-
296
ca italiana», n . 2 (1984), pp. 414-509, e quello di WALTER
BARBERIS,
Le armi del principe. La tradizione militare
sabauda,
Torino, Einaudi, 1988, in particolare le pp. 188-
233 .
5
Ibid. ,
pp. 275-277 e 289-291. Per un panorama più
generale sull'attività degli ispettori delle miniere si rinvia
a MARIO ASRATE,
L'industria siderurgica e meccanica in
Piemonte dal
1831
al
1861, Torino, Comitato di Torino
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1961.


















