
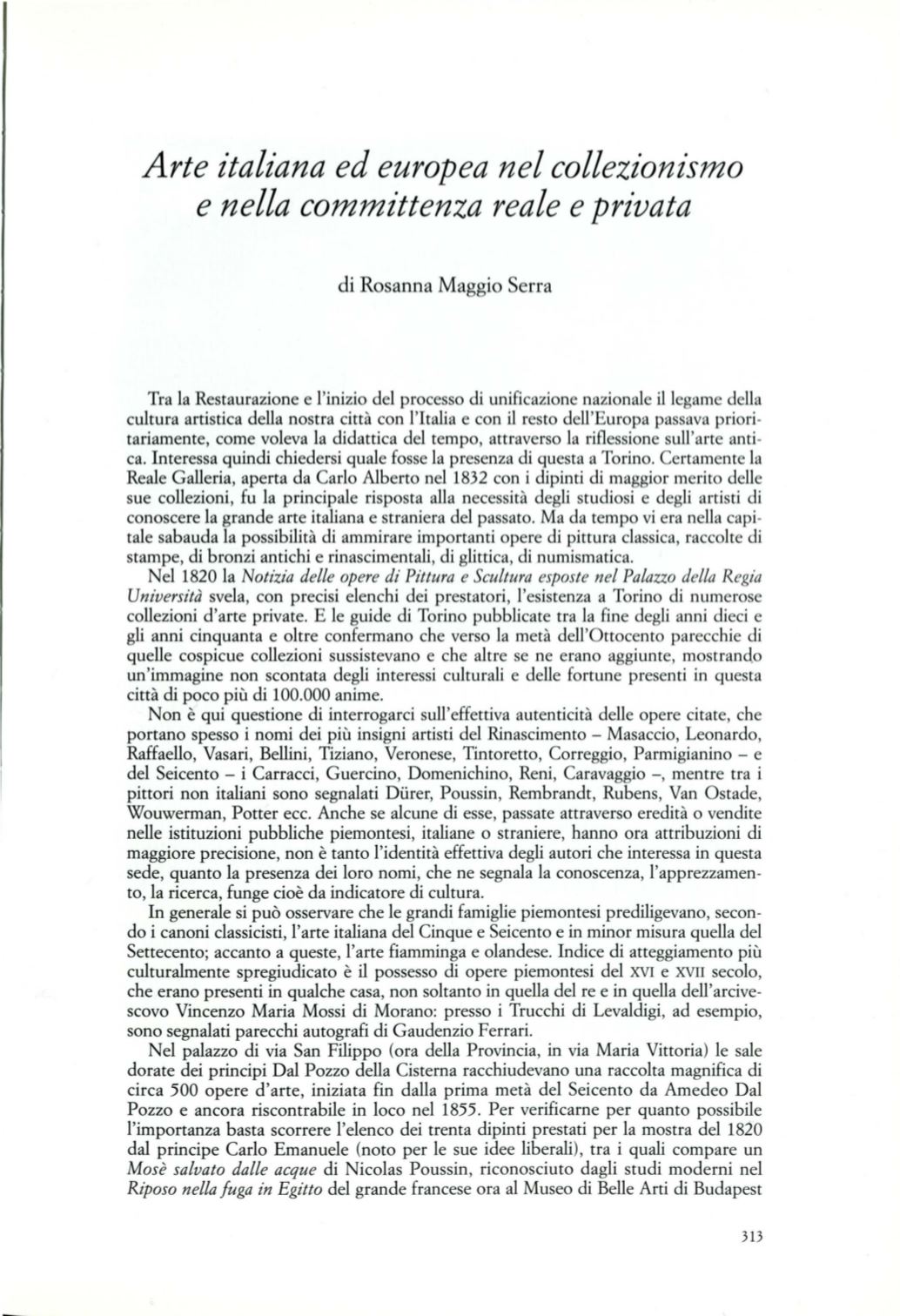
Arte italiana ed europea nel collezionismo
e
nella committenza reale e privata
di Rosanna Maggio Serra
Tra la Restaurazione e l'inizio del processo di unificazione nazionale il legame della
cultura artistica della nostra città con l'Italia e con il resto dell'Europa passava priori–
tariamente, come voleva la didattica del tempo, attraverso la riflessione sull'arte anti–
ca. Interessa quindi chiedersi quale fosse la presenza di questa a Torino. Certamente la
Reale Galleria, aperta da Carlo Alberto nel 1832 con i dipinti di maggior merito delle
sue collezioni, fu la principale risposta alla necessità degli studiosi e degli artisti di
conoscere la grande arte italiana e straniera del passato. Ma da tempo vi era nella capi–
tale sabauda la possibilità di ammirare importanti opere di pittura classica, raccolte di
stampe, di bronzi antichi e rinascimentali, di glittica, di numismatica.
Nel 1820 la
Notizia delle opere di Pittura e Scultura esposte nel Palazzo della Regia
Università
svela, con precisi elenchi dei prestatori, l'esistenza a Torino di numerose
collezioni d'arte private. E le guide di Torino pubblicate tra la fine degli anni dieci e
gli anni cinquanta e oltre confermano che verso la metà dell'Ottocento parecchie di
quelle cospicue collezioni sussistevano e che altre se ne erano aggiunte, mostrando
un 'immagine non scontata degli interessi culturali e delle fortune presenti in questa
città di poco più di 100.000 anime.
Non è qui questione di interrogarci sull'effettiva autenticità delle opere citate, che
portano spesso i nomi dei più insigni artisti del Rinascimento - Masaccio, Leonardo,
Raffaello, Vasari, Bellini, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Correggio, Parmigianino - e
del Seicento - i Carracci, Guercino, Domenichino, Reni, Caravaggio -, mentre tra i
pittori non italiani sono segnalati Diirer, Poussin, Rembrandt, Rubens, Van Ostade,
Wouwerman, Potter ecc. Anche se alcune di esse, passate attraverso eredità o vendite
nelle istituzioni pubbliche piemontesi, italiane o straniere, hanno ora attribuzioni di
maggiore precisione, non è tanto l'identità effettiva degli autori che interessa in questa
sede, quanto la presenza dei loro nomi, che ne segnala la conoscenza, l'apprezzamen–
to, la ricerca, funge cioè da indicatore di cultura.
In generale si può osservare che le grandi famiglie piemontesi prediligevano, secon–
do i canoni classicisti, l'arte italiana del Cinque e Seicento e in minor misura quella del
Settecento; accanto a queste, l'arte fiamminga e olandese. Indice di atteggiamento più
culturalmente spregiudicato è il possesso di opere piemontesi del
XVI
e
XVII
secolo,
che erano presenti in qualche casa, non soltanto in quella del re e in quella dell' arcive–
scovo Vincenzo Maria Mossi di Morano: presso i Trucchi di Levaldigi, ad esempio,
sono segnalati parecchi autografi di Gaudenzio Ferrari.
Nel palazzo di via San Filippo (ora della Provincia, in via Maria Vittoria) le sale
dorate dei principi Dal Pozzo della Cisterna racchiudevano una raccolta magnifica di
circa 500 opere d'arte, iniziata fin dalla prima metà del Seicento da Amedeo Dal
Pozzo e ancora riscontrabile in loco nel 1855. Per verificarne per quanto possibile
l'importanza basta scorrere l'elenco dei trenta dipinti prestati per la mostra del 1820
dal principe Carlo Emanuele (noto per le sue idee liberali), tra i quali compare un
Mosè salvato dalle acque
di Nicolas Poussin, riconosciuto dagli studi moderni nel
Riposo nella fuga in Egitto
del grande francese ora al Museo di Belle Arti di Budapest
313


















