
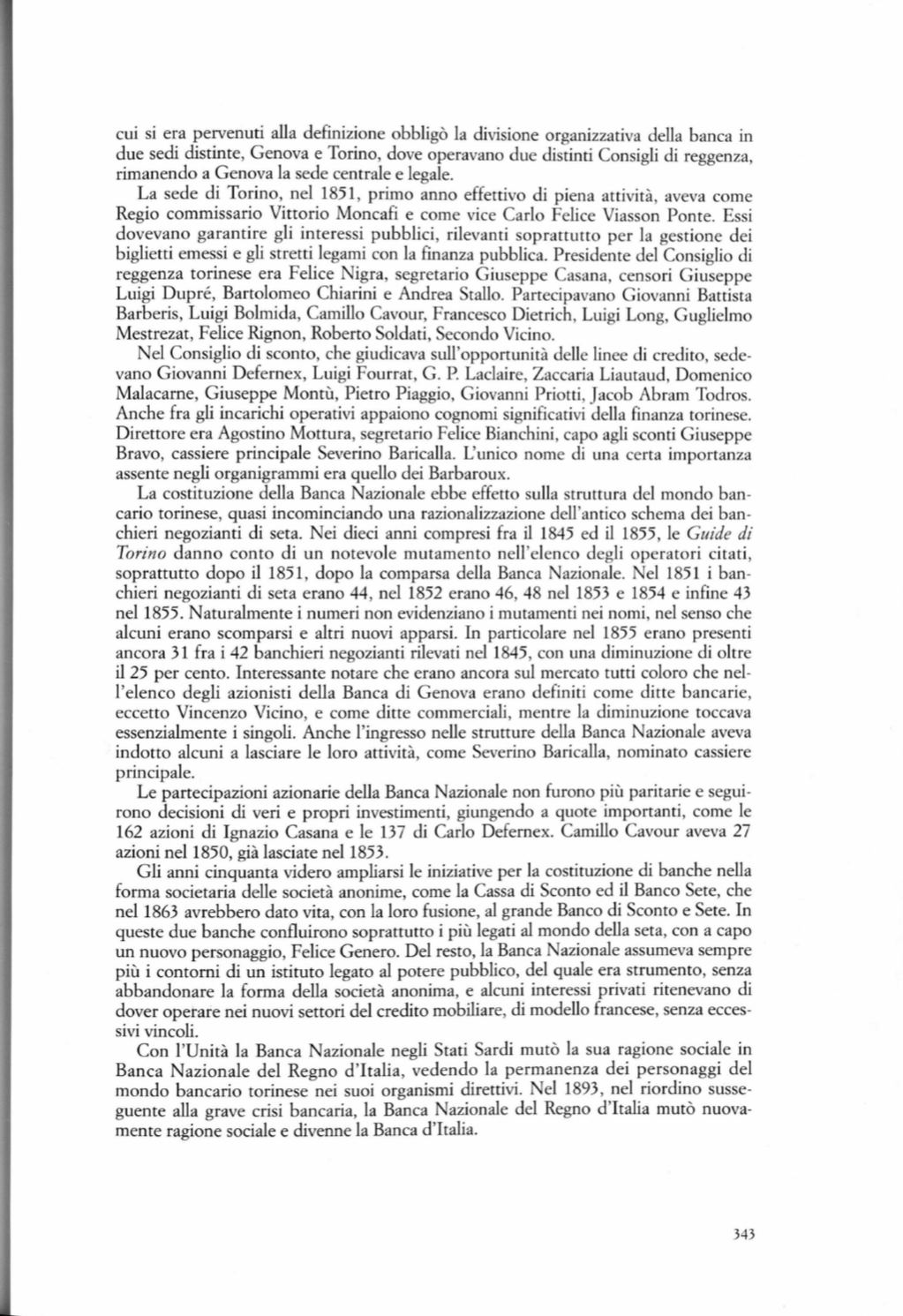
cui si era pervenuti alla definizione obbligò la divisione organizzativa della banca in
due sedi distinte, Genova e Torino, dove operavano due distinti Consigli di reggenza,
rimanendo a Genova la sede centrale e legale.
La sede di Torino, nel 1851, primo anno effettivo di piena attività , aveva come
Regio commissario Vittorio Moncafi e come vice Carlo Felice Viasson Ponte. Essi
dovevano garantire gli interessi pubblici, rilevanti soprattutto per la gestione dei
biglietti emessi e gli stretti legami con la finanza pubblica. Presidente del Consiglio di
reggenza torinese era Felice Nigra, segretario Giuseppe Casana, censori Giuseppe
Luigi Dupré, Bartolomeo Chiarini e Andrea Stallo. Partecipavano Giovanni Battista
Barberis, Luigi Bolmida, Camillo Cavour, Francesco Dietrich, Luigi Long, Guglielmo
Mestrezat, Felice Rignon, Roberto Soldati, Secondo Vicino.
Nel Consiglio di sconto, che giudicava sull'opportunità delle linee di credito, sede–
vano Giovanni Defernex, Luigi Fourrat, G .
P.
Laclaire, Zaccaria Liautaud , Domenico
Malacarne, Giuseppe Montù, Pietro Piaggio, Giovanni Priotti,
J
acob Abram Todros.
Anche fra gli incarichi operativi appaiono cognomi significativi della finanza torinese.
Direttore era Agostino Mottura, segretario Felice Bianchini, capo agli sconti Giuseppe
Bravo, cassiere principale Severino Baricalla. L'unico nome di una certa importanza
assente negli organigrammi era quello dei Barbaroux.
La costituzione della Banca Nazionale ebbe effetto sulla struttura del mondo ban–
cario torinese, quasi incominciando una razionalizzazione dell'antico schema dei ban–
chieri negozianti di seta . Nei dieci anni compresi fra il 1845 ed il 1855, le
Guide di
Torino
danno conto di un notevole mutamento nell'elenco degli operatori citati,
soprattutto dopo il 1851, dopo la comparsa della Banca Nazionale. Nel 1851 i ban–
chieri negozianti di seta erano 44, nel 1852 erano 46, 48 nel 1853 e 1854 e infine 43
nel 1855. Naturalmente i numeri non evidenziano i mutamenti nei nomi, nel senso che
alcuni erano scomparsi e altri nuovi apparsi. In particolare nel 1855 erano presenti
ancora 31 fra i 42 banchieri negozianti rilevati nel 1845, con una diminuzione di oltre
il 25 per cento. Interessante notare che erano ancora sul mercato tutti coloro che nel–
l'elenco degli azionisti della Banca di Genova erano definiti come ditte bancarie,
eccetto Vincenzo Vicino, e come ditte commerciali, mentre la diminuzione toccava
essenzialmente i singoli. Anche l'ingresso nelle strutture della Banca Nazionale aveva
indotto alcuni a lasciare le loro attività, come Severino Baricalla, nominato cassiere
principale.
Le partecipazioni azionarie della Banca Nazionale non furono più paritarie e segui–
rono decisioni di veri e propri investimenti, giungendo a quote importanti, come le
162 azioni di Ignazio Casana e le 137 di Carlo Defernex. Camillo Cavour aveva 27
azioni nel 1850, già lasciate nel 1853.
Gli anni cinquanta videro ampliarsi le iniziative per la costituzione di banche nella
forma societaria delle società anonime, come la Cassa di Sconto ed il Banco Sete, che
nel 1863 avrebbero dato vita, con la loro fusione, al grande Banco di Sconto e Sete. In
queste due banche confluirono soprattutto i più legati al mondo della seta, con a capo
un nuovo personaggio, Felice Genero. Del resto, la Banca Nazionale assumeva sempre
più i contorni di un istituto legato al potere pubblico, del quale era strumento, senza
abbandonare la forma della società anonima, e alcuni interessi privati ritenevano di
dover operare nei nuovi settori del credito mobiliare, di modello francese, senza ecces–
sivi vincoli.
Con l'Unità la Banca Nazionale negli Stati Sardi mutò la sua ragione sociale in
Banca Nazionale del Regno d'Italia, vedendo la permanenza dei personaggi del
mondo bancario torinese nei suoi organismi direttivi. Nel 1893, nel riordino susse–
guente alla grave crisi bancaria, la Banca Nazionale del Regno d'Italia mutò nuova–
mente ragione sociale e divenne la Banca d'Italia.
343


















