
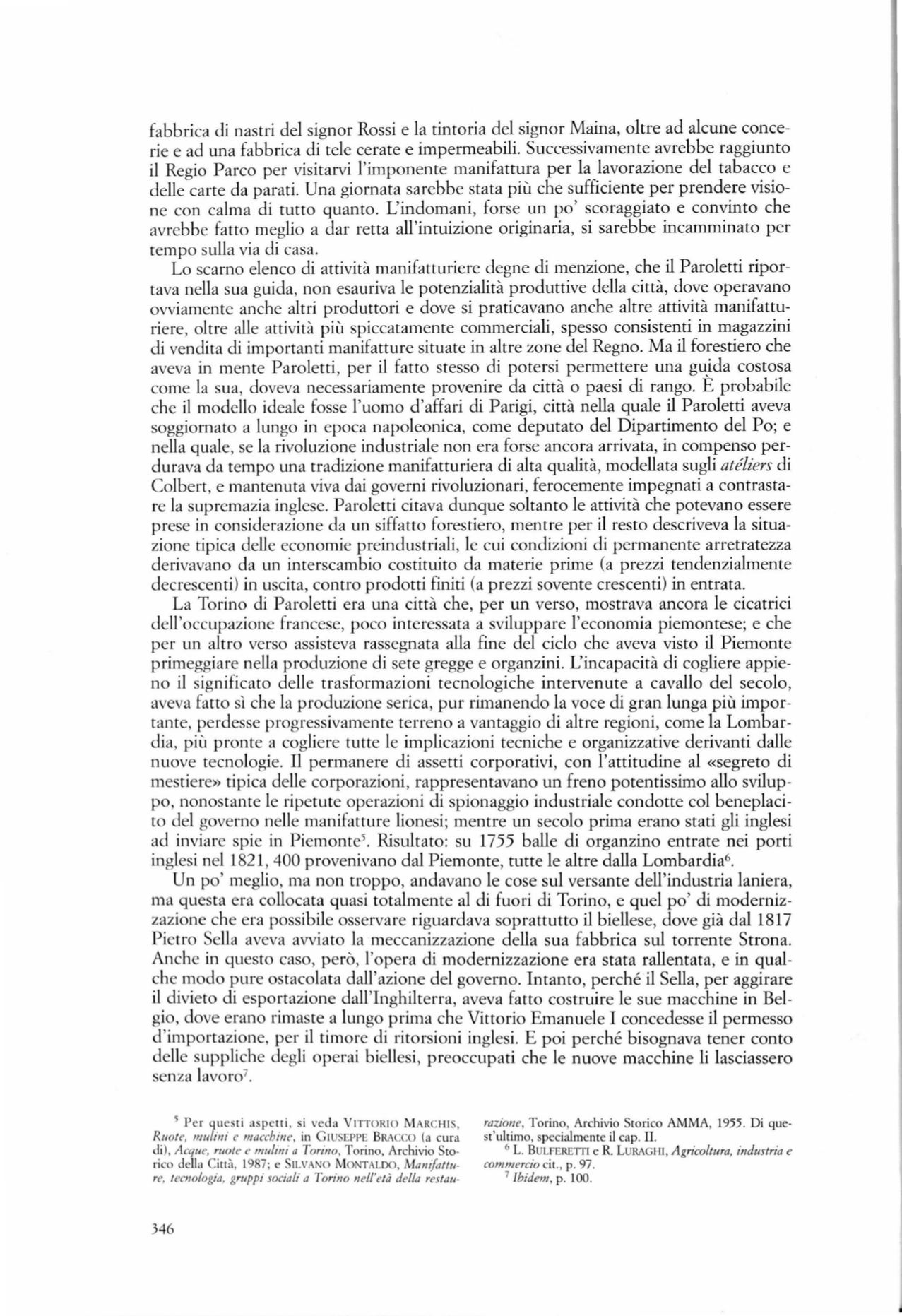
fabbrica di nastri del signor Rossi e la tintoria del signor Maina, oltre ad alcune conce–
ri e e ad una fabbrica di tele cerate e impermeabili. Successivamente avrebbe raggiunto
il Regio Parco per visitarvi l'imponente manifattura per la lavorazione del tabacco e
delle carte da parati. Una giornata sarebbe stata più che sufficiente per prendere visio–
ne con calma di tutto quanto. L'indomani, forse un po' scoraggiato e convinto che
av rebbe fatto meglio a dar retta all'intuizione originaria, si sarebbe incamminato per
tempo sulla via di casa.
Lo sca rno elenco di attività manifatturiere degne di menzione, che il Paroletti ripor–
tava nella sua guida, non esauriva le potenzialità produttive della città , dove operavano
ovviamente anche altri produttori e dove si praticavano anche altre attività manifattu–
ri ere, oltre alle attività più spiccatamente commerciali, spesso consistenti in magazzini
di vendita di importanti manifatture situate in altre zone del Regno. Ma il forestiero che
aveva in mente Paroletti, per il fatto stesso di potersi permettere una guida costosa
come la sua , doveva necessa riamente provenire da città o paesi di rango. E probabile
che
il
modello ideale fosse l' uomo d 'affari di Parigi, città nella quale il Paroletti aveva
soggiornato a lungo in epoca napoleonica, come deputato del Dipartimento del Po; e
nella quale, se la rivoluzione industriale non era forse ancora arrivata, in compenso per–
durava da tempo una tradizione manifatturiera di alta qualità, modellata sugli
atéliers
di
Colbert, e mantenuta viva dai governi rivoluzionari, ferocemente impegnati a contrasta–
re la supremazia inglese. Paroletti citava dunque soltanto le attività che potevano essere
prese in considerazione da un siffatto forestiero, mentre per il resto descriveva la situa–
zione tipica delle economie preindustriali, le cui condizioni di permanente arretratezza
derivavano da un interscambio costituito da materie prime (a prezzi tendenzialmente
decrescenti) in uscita , contro prodotti finiti (a prezzi sovente crescenti) in entrata.
La Torino di Paroletti era una città che, per un verso, mostrava ancora le cicatrici
dell 'occupazione francese, poco interessata a sviluppare l'economia piemontese; e che
per un altro verso assisteva rassegnata alla fine del ciclo che aveva visto il Piemonte
primeggiare nella produzione di sete gregge e organzini. L'incapacità di cogliere appie–
no il significato delle trasformazioni tecnologiche intervenute a cavallo del secolo,
aveva fatto sì che la produzione serica , pur rimanendo la voce di gran lunga più impor–
tante, perdesse progressivamente terreno a vantaggio di altre regioni, come la Lombar–
dia, più pronte a cogliere tutte le implicazioni tecniche e organizzative derivanti dalle
nuove tecnologie. Il permanere di assetti corporativi, con l'attitudine al «segreto di
mestiere» tipica delle corporazioni, rappresentavano un freno potentissimo allo svilup–
po , nonostante le ripetute operazioni di spionaggio industriale condotte col beneplaci–
to del governo nelle manifatture lionesi; mentre un secolo prima erano stati gli inglesi
ad inviare spie in Piemonte
5 .
Risultato: su 1755 balle di organzino entrate nei porti
inglesi nel 182 1,
400
provenivano dal Piemonte, tutte le altre dalla Lombardia
6 .
Un po' meglio, ma non troppo , andavano le cose sul versante dell'industria laniera,
ma ques ta era collocata quasi totalmente al di fuori di Torino, e quel po' di moderniz–
zazione che era possibile osservare riguardava soprattutto
il
biellese, dove già dal 1817
Pietro Sella aveva avviato la meccanizzazione della sua fabbrica sul torrente Strona.
Anche in questo caso, però, l'opera di modernizzazione era stata rallentata, e in qual–
che modo pure ostacolata dall 'azione del governo. Intanto, perché il Sella, per aggirare
il
divieto di esportazione dall'Inghilterra , aveva fatto costruire le sue macchine in Bel–
gio, dove erano rimaste a lungo prima che Vittorio Emanuele I concedesse il permesso
d 'importazione, per il timore di ritorsioni inglesi. E poi perché bisognava tener conto
delle suppli che degli operai biellesi, preoccupati che le nuove macchine li lasciassero
senza lavor0
7 •
~
Per
questi aspe tti , si veda VITTOR IO MARCH IS,
Ruote, /III/lini e macchine,
in GI SEPPE BRACCO (a cura
di) ,
Acque, ruote e !fIulini a Torino,
Torino, Archivio Sto–
rico della Città,
1987;
e SILVA O Mo TALOO,
Mani/altu–
re, tecnologia, gruppi sociali a Torino nell'età della restatl-
346
razione,
Torino, Archivio Storico AMMA, 1955. Di que–
st'u1tinlO, specialmente
il
cap.
II.
6
L.
BULFERETTI
e
R.
L URAG I-U ,
Agricoltura, industria e
commercio
cit., p.
97.
7
Ibidem,
p.
100.


















