
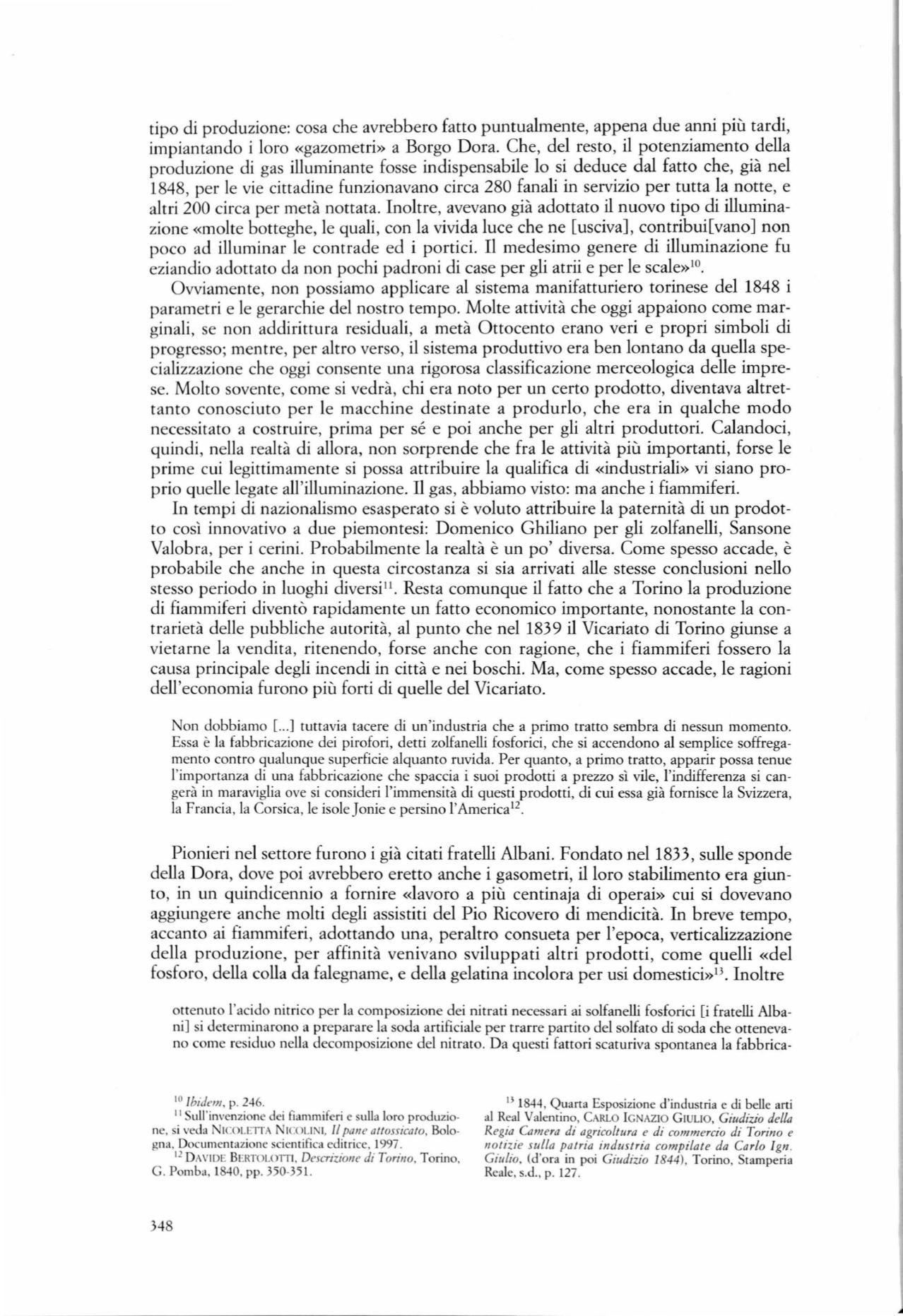
tipo di produzione: cosa che avrebbero fatto puntualmente, appena due anni più tardi,
impiantando i loro «gazometri» a Borgo Dora. Che, del resto, il potenziamento della
produzione di gas illuminante fosse indispensabile lo si deduce dal fatto che, già nel
1848, per le vie cittadine funzionavano circa 280 fanali in servizio per tutta la notte, e
altri 200 circa per metà nottata. Inoltre, avevano già adottato il nuovo tipo di illumina–
zione «molte botteghe, le quali, con la vivida luce che ne [usciva], contribui [vano] non
poco ad illuminar le contrade ed i portici. Il medesimo genere di illuminazione fu
eziandio adottato da non pochi padroni di case per gli atrii e per le scale» lO.
Owiamente, non possiamo applicare al sistema manifatturiero torinese del 1848 i
parametri e le gerarchie del nostro tempo. Molte attività che oggi appaiono come mar–
ginali , se non addirittura residuali, a metà Ottocento erano veri e propri simboli di
progresso; mentre, per altro verso, il sistema produttivo era ben lontano da quella spe–
cializzazione che oggi consente una rigorosa classificazione merceologica delle impre–
se. Molto sovente, come si vedrà, chi era noto per un certo prodotto, diventava altret–
tanto conosciuto per le macchine destinate a produdo, che era in qualche modo
necessitato a costruire, prima per sé e poi anche per gli altri produttori. Calandoci,
quindi, nella realtà di allora, non sorprende che fra le attività più importanti, forse le
prime cui legittimamente si possa attribuire la qualifica di «industriali» vi siano pro–
prio quelle legate all'illuminazione. Il gas, abbiamo visto: ma anche i fiammiferi.
In tempi di nazionalismo esasperato si
è
voluto attribuire la paternità di un prodot–
to così innovativo a due piemontesi: Domenico Ghiliano per gli zolfanelli, Sansone
Valobra, per i cerini. Probabilmente la realtà è un po' diversa. Come spesso accade, è
probabile che anche in questa circostanza si sia arrivati alle stesse conclusioni nello
stesso periodo in luoghi diversi
Il.
Resta comunque il fatto che a Torino la produzione
di fiammiferi diventò rapidamente un fatto economico importante, nonostante la con–
trarietà delle pubbliche autorità, al punto che nel 1839 il Vicariato di Torino giunse a
vietarne la vendita, ritenendo, forse anche con ragione , che i fiammiferi fossero la
causa principale degli incendi in città e nei boschi. Ma, come spesso accade, le ragioni
dell'economia furono più forti di quelle del Vicariato.
Non dobbiamo [.. .] tuttavia tacere di un 'industria che a primo tratto sembra di nessun momento.
Essa
è
la fabbricazione dei pirofori, detti zolfanelli fosforici , che si accendono al semplice soffrega–
mento contro qualunque superficie alquanto ruvida. Per quanto, a primo tratto, apparir possa tenue
l'importanza di una fab bricazione che spaccia i suoi prodotti a prezzo sì vile, l'indifferenza si can–
gerà in maraviglia ove si consideri l'immensità
di
questi prodotti, di cui essa già fornisce la Svizzera,
la Francia, la Corsica,
le
isole Jonie e persino l'America
I2 .
Pionieri nel settore furono i già citati fratelli Albani. Fondato nel 1833 , sulle sponde
della Dora, dove poi avrebbero eretto anche i gasometri, il loro stabilimento era giun–
to , in un quindicennio a fornire «lavoro a più centinaja di operai» cui si dovevano
aggiungere anche molti degli assistiti del Pio Ricovero di mendicità. In breve tempo,
accanto ai fiammiferi , adottando una , peraltro consueta per l'epoca, verticalizzazione
della produzione, per affinità venivano sviluppati altri prodotti , come quelli «del
fosforo , della colla da falegname, e della gelatina incolora per usi domestici»13. Inoltre
ottenuto l'acido nitrico per la composizione dei nitrati necessari ai solfanelli fosforici [i fratelli Alba–
ni] si determinarono a preparare la soda artificiale per trarre parùto del solfato di soda che otteneva–
no come residuo nella decomposizione del nitrato. Da questi fattori scaturiva spontanea la fabbrica-
IO
Ibidem,
p.
2-16.
Il
Sull'invenzione dei fiammiferi e sulla loro produzio–
ne, si veda NICOLETIi\ ICOLlN I,
Il palle attossicato,
Bolo–
gna, Documentazione scientifica editrice,
1997.
12
DAVIDE BERTOLOTII,
Descriziolle di Torino,
To rino,
G . Pomba, 1840, pp. 350-35 1.
348
l}
1844, Quarta Esposizione d'industria e
di
belle arti
al Real Valentino, CARLO
le
AZIO GI ULIO,
Giudizio della
Regia Camera di agricoltura e di commercio di Torino e
notizie sulla patria industria compilate da Carlo 19n.
Giulio,
(d 'ora in poi
Giudizio
1844),
Torino, Stamperia
Reale, s.d., p.
127.


















