
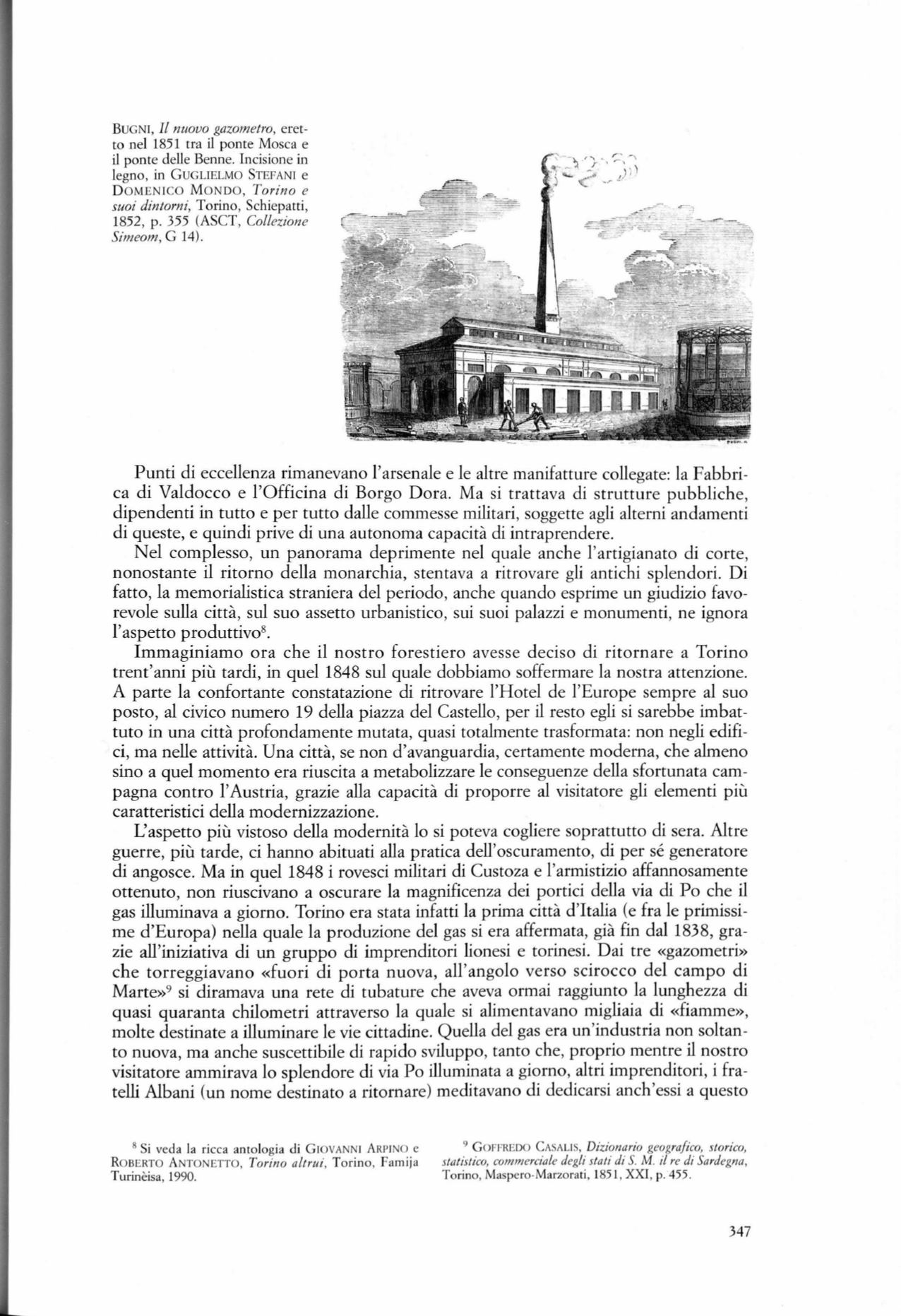
BUGNI,
Il nuovo gazometro,
eret-
to
nel 1851 tra
il
ponte Mosca e
il
ponte delle Benne. Incisione in
legno, in GUGLIELMO STEFANI e
DOMENI CO MONDO,
Torino e
suoi dintorni,
Torino, Schiepatti,
1852, p . 355
(ASCT,
Collezione
Simeom,
G 14) .
Punti di eccellenza rimanevano l'arsenale e le altre manifatture collegate: la Fabbri–
ca di Valdocco e l'Officina di Borgo Dora. Ma si trattava di strutture pubbliche,
dipendenti in tutto e per tutto dalle commesse militari, soggette agli alterni andamenti
di queste, e quindi prive di una autonoma capacità di intraprendere.
Nel complesso, un panorama deprimente nel quale anche l'artigianato di corte,
nonostante il ritorno della monarchia, stentava a ritrovare gli antichi splendori. Di
fatto, la memorialistica straniera del periodo, anche quando esprime un giudizio favo–
revole sulla città, sul suo assetto urbanistico, sui suoi palazzi e monumenti, ne ignora
l'aspetto produttiv0
8 .
Immaginiamo ora che il nostro forestiero avesse deciso di ritornare a Torino
trent'anni più tardi, in quel 1848 sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione.
A parte la confortante constatazione di ritrovare l'Hotel de l'Europe sempre al suo
posto, al civico numero
19
della piazza del Castello, per il resto egli si sarebbe imbat–
tuto in una città profondamente mutata, quasi totalmente trasformata: non negli edifi–
ci, ma nelle attività. Una città, se non d'avanguardia, certamente moderna, che almeno
sino a quel momento era riuscita a metabolizzare le conseguenze della sfortunata cam–
pagna contro l'Austria, grazie alla capacità di proporre al visitatore gli elementi più
caratteristici della modernizzazione.
L'aspetto più vistoso della modernità lo si poteva cogliere soprattutto di sera. Altre
guerre, più tarde, ci hanno abituati alla pratica dell 'oscuramento, di per sé generatore
di
angosce. Ma in quel 1848 i rovesci militari di Custoza e l'armistizio affannosamente
ottenuto, non riuscivano a oscurare la magnificenza dei portici della via di Po che il
gas illuminava a giorno. Torino era stata infatti la prima città d'Italia (e fra le primissi–
me d'Europa) nella quale la produzione del gas si era affermata, già fin dal 1838, gra–
zie all'iniziativa di un gruppo di imprenditori lionesi e torinesi. Dai tre «gazometri»
che torreggiavano «fuori di porta nuova, all'angolo verso scirocco del campo di
Marte»9 si diramava una rete di tubature che aveva ormai raggiunto la lunghezza di
quasi quaranta chilometri attraverso la quale si alimentavano migliaia di «fiamme»,
molte destinate a illuminare le vie cittadine. Quella del gas era un'industria non soltan–
to nuova, ma anche suscettibile di rapido sviluppo, tanto che, proprio mentre il nostro
visitatore ammirava lo splendore di via Po illuminata a giorno, altri imprenditori, i fra–
telli Albani (un nome destinato a ritornare) meditavano di dedicarsi anch 'essi a questo
8
Si veda la ricca antologia di
GIOVANNI ARPINO
e
ROBERTO A NTONETTO,
Torino altrui,
To rin o, Famija
Turinèisa, 1990.
9 G OFFREDO CASALlS,
Dizionario geografico, storico,
statistico, commerciale degli stati di
S. M.
il re di Sardegna ,
Torino, Maspero-Marzorati , 185 1, XXI, p. 455.
347


















