
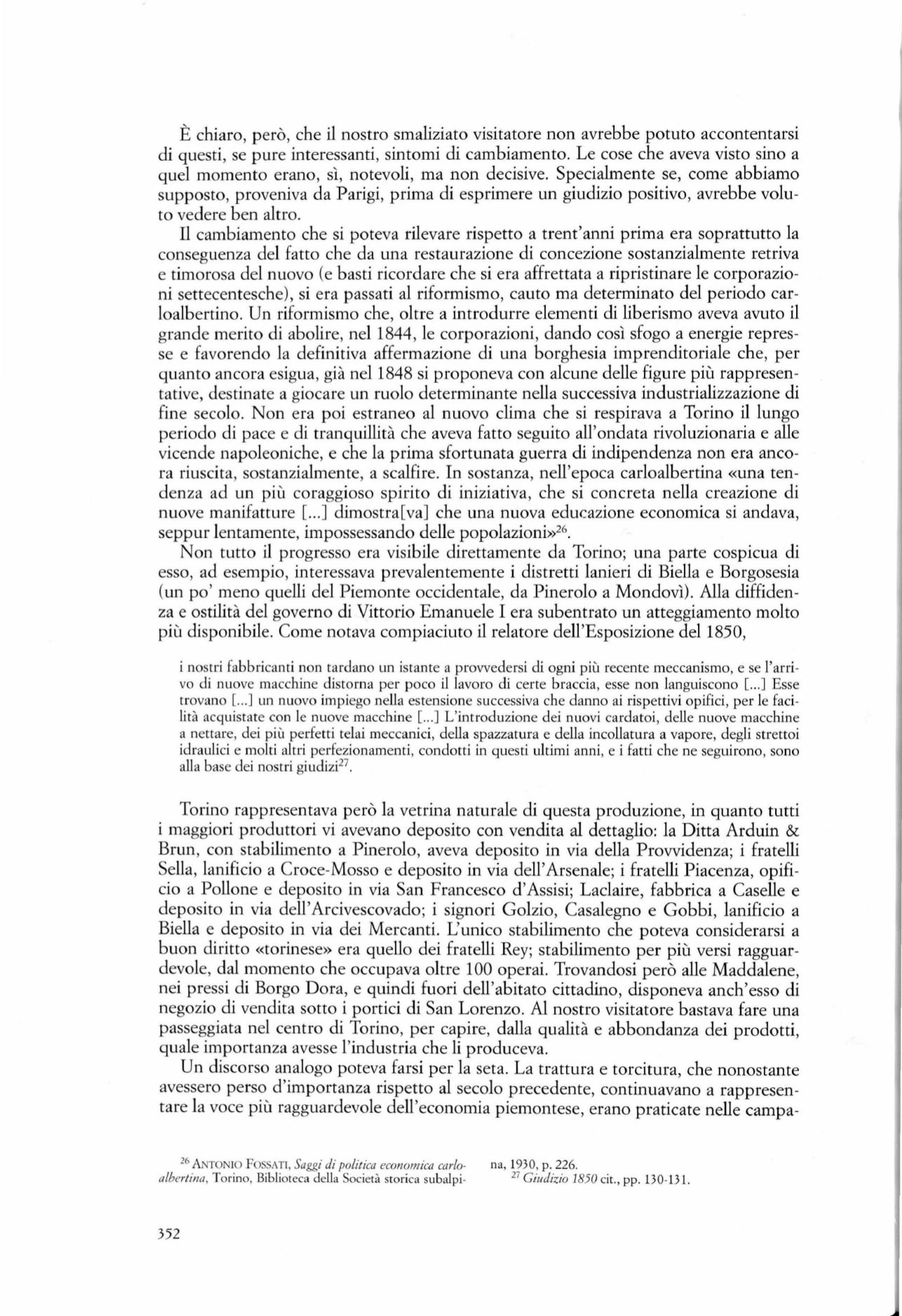
È
chiaro, però, che
il
nostro smaliziato visitatore non avrebbe potuto accontentarsi
di questi, se pure interessanti, sintomi di cambiamento. Le cose che aveva visto sino a
quel momento erano, sì, notevoli, ma non decisive. Specialmente se, come abbiamo
supposto, proveniva da Parigi, prima di esprimere un giudizio positivo, avrebbe volu–
to vedere ben altro.
Il cambiamento che si poteva rilevare rispetto a trent'anni prima era soprattutto la
conseguenza del fatto che da una restaurazione di concezione sostanzialmente retriva
e timorosa del nuovo (e basti ricordare che si era affrettata a ripristinare le corporazio–
ni settecentesche), si era passati al riformismo, cauto ma determinato del periodo car–
loalbertino. Un riformismo che, oltre a introdurre elementi di liberismo aveva avuto il
grande merito di abolire, nel 1844, le corporazioni, dando così sfogo a energie repres–
se e favorendo la definitiva affermazione di una borghesia imprenditoriale che, per
quanto ancora esigua, già nel 1848 si proponeva con alcune delle figure più rappresen–
tative, destinate a giocare un ruolo determinante nella successiva industrializzazione di
fine secolo. Non era poi estraneo al nuovo clima che si respirava a Torino il lungo
periodo di pace e di tranquillità che aveva fatto seguito all' ondata rivoluzionaria e alle
vicende napoleoniche, e che la prima sfortunata guerra di indipendenza non era anco–
ra riuscita, sostanzialmente, a scalfire. In sostanza, nell'epoca carloalbertina «una ten–
denza ad un più coraggioso spirito di iniziativa, che si concreta nella creazione di
nuove manifatture [... ] dimostra[va] che una nuova educazione economica si andava,
seppur lentamente, impossessando delle popolazioni»26.
Non tutto il progresso era visibile direttamente da Torino; una parte cospicua di
esso, ad esempio, interessava prevalentemente i distretti lanieri di Biella e Borgosesia
(un po' meno quelli del Piemonte occidentale, da Pinerolo a Mondovì). Alla diffiden–
za e ostilità del governo di Vittorio Emanuele I era subentrato un atteggiamento molto
più disponibile. Come notava compiaciuto il relatore dell'Esposizione del 1850,
i nostri fabbricanti non tardano un istante a provvedersi di ogni più recente meccanismo, e se l'arri–
vo di nuove macchine distoma per poco
il
lavoro di certe braccia, esse non languiscono [...] Esse
trovano [, ..] un nuovo impiego nella estensione successiva che danno ai rispettivi opifici, per le faci–
lità acquistate con le nuove macchine [...] L'introduzione dei nuovi cardatoi, delle nuove macchine
a nettare, dei più perfetti telai meccanici, della spazzatura e della incollatura a vapore, degli strettoi
idraulici e molti altri perfezionamenti, condotti in questi ultimi anni, e i fatti che ne seguirono, sono
alla base dei nostri giudizi
27 .
Torino rappresentava però la vetrina naturale di questa produzione, in quanto tutti
i maggiori produttori vi avevano deposito con vendita al dettaglio: la Ditta Arduin
&
Brun, con stabilimento a Pinerolo, aveva deposito in via della Provvidenza; i fratelli
Sella, lanificio a Croce-Mosso e deposito in via dell'Arsenale; i fratelli Piacenza, opifi–
cio a Pollone e deposito in via San Francesco d'Assisi; Laclaire, fabbrica a Caselle e
deposito in via dell'Arcivescovado; i signori Golzio, Casalegno e Gobbi, lanificio a
Biella e deposito in via dei Mercanti. L'unico stabilimento che poteva considerarsi a
buon diritto «torinese» era quello dei fratelli Rey; stabilimento per più versi ragguar–
devole, dal momento che occupava oltre 100 operai. Trovandosi però alle Maddalene,
nei pressi di Borgo Dora, e quindi fuori dell' abitato cittadino, disponeva anch'esso di
negozio di vendita sotto i portici di San Lorenzo. Al nostro visitatore bastava fare una
passeggiata nel centro di Torino, per capire, dalla qualità e abbondanza dei prodotti,
quale importanza avesse l'industria che li produceva.
Un discorso analogo poteva farsi per la seta. La trattura e torcitura, che nonostante
avessero perso d 'importanza rispetto al secolo precedente, continuavano a rappresen–
tare la voce più ragguardevole dell 'economia piemontese, erano praticate nelle campa-
26 ANTO IO F OSSATI ,
Saggi di politica economica car/o–
a/bertina,
Torino, Biblioteca della Società storica subalpi-
352
na, 1930,
p.
226.
27
Giudizio 1850
cit. , pp. 130-131.


















