
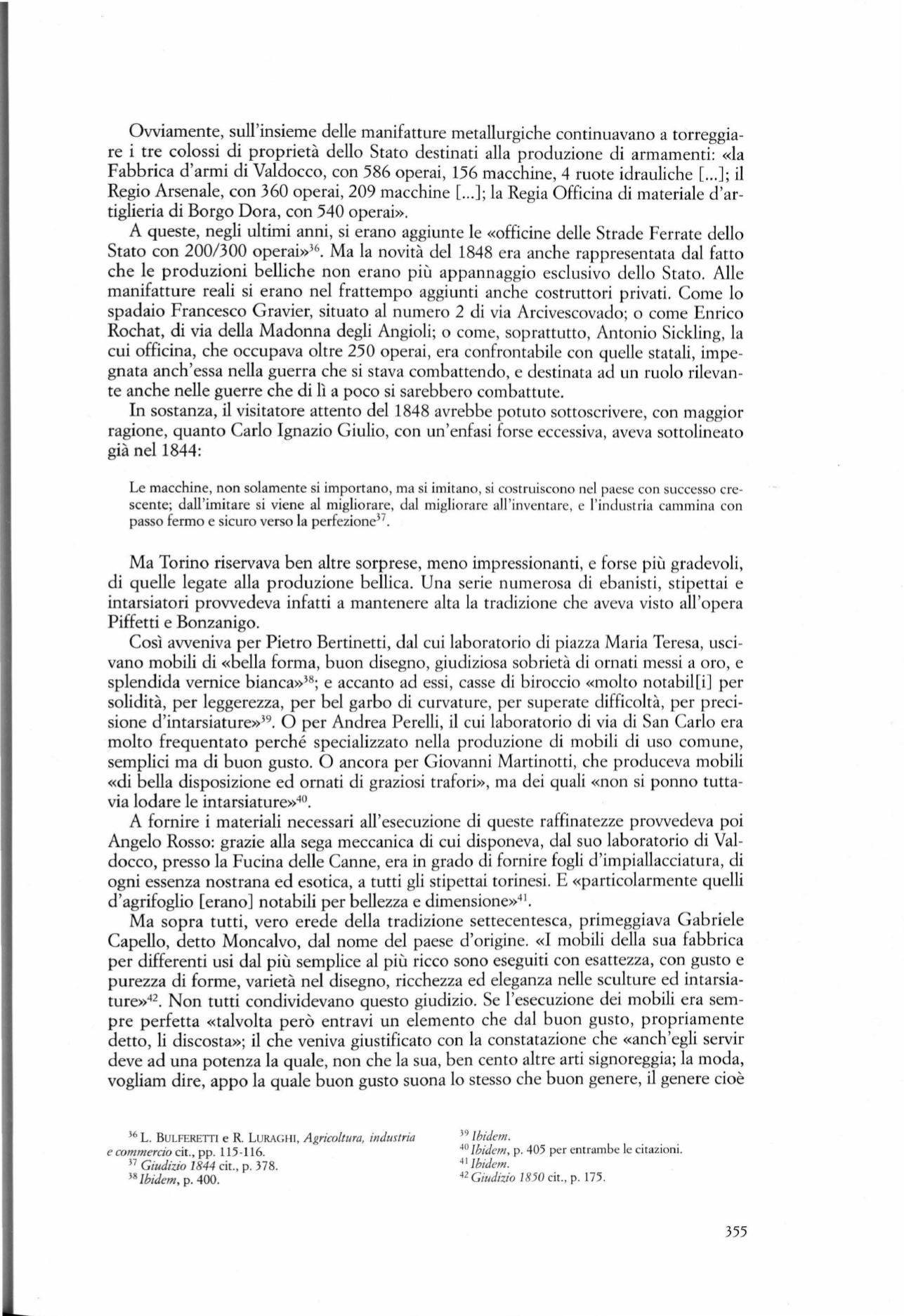
Ovviamente, sull'insieme delle manifatture metallurgiche continuavano a torreggia–
re i tre colossi di proprietà dello Stato destinati alla produzione di armamenti: «la
Fabbrica d'armi di Valdocco, con
586
operai,
156
macchine,
4
ruote idrauliche [... ]; il
R~gio
Arsenale, con
360
operai,
209
macchine
L.];
la Regia Officina di materiale d 'ar–
tiglieria di Borgo Dora, con
540
operai».
A queste, negli ultimi anni, si erano aggiunte le «officine delle Strade Ferrate dello
Stato con
200/ 300
operai»36. Ma la novità del
1848
era anche rappresentata dal fatto
che le produzioni belliche non erano più appannaggio esclusivo dello Stato. Alle
manifatture reali si erano nel frattempo aggiunti anche costruttori privati. Come lo
spadaio Francesco Gravier, situato al numero
2
di via Arcivescovado; o come Enrico
Rochat, di via della Madonna degli Angioli; o come, soprattutto, Antonio Sickling, la
cui officina, che occupava oltre
250
operai, era confrontabile con quelle statali, impe–
gnata anch'essa nella guerra che si stava combattendo , e destinata ad un ruolo rilevan–
te anche nelle guerre che di
lì
a poco si sarebbero combattute.
In sostanza, il visitatore attento del
1848
avrebbe potuto sottoscrivere, con maggior
ragione, quanto Carlo Ignazio Giulio, con un 'enfasi fors e eccessiva, aveva sottolineato
già nel
1844:
Le macchine, non solamente si importano, ma si imitano, si costruiscono nel paese con successo cre–
scente; dall 'imitare si viene al migliorare, dal migliorare all 'inventare, e l'industria cammina con
passo fermo e sicuro verso la
perfezion~7 .
Ma Torino riservava ben altre sorprese, meno impressionanti, e forse più gradevoli,
di quelle legate alla produzione bellica. Una serie numerosa di ebanisti, stipettai e
intarsiatori provvedeva infatti a mantenere alta la tradizione che aveva visto all 'opera
Piffetti e Bonzanigo.
CosÌ avveniva per Pietro Bertinetti, dal cui laboratorio di piazza Maria Teresa, usci–
vano mobili di «bella forma, buon disegno, giudiziosa sobrietà di ornati messi a oro , e
splendida vernice bianca»38; e accanto ad essi, casse di biroccio «molto notabil[i] per
solidità, per leggerezza, per bel garbo di curvature, per superate difficoltà, per preci–
sione d'intarsiature»39. O per Andrea Perelli, il cui laboratorio di via di San Carlo era
molto frequentato perché specializzato nella produzione di mobili di uso comune,
semplici ma di buon gusto. O ancora per Giovanni Martinotti, che produceva mobili
«di bella disposizione ed ornati di graziosi trafori», ma dei quali «non si ponno tutta–
via lodare le intarsiature»40.
A fornire i materiali necessari all' esecuzione di queste raffinatezze provvedeva poi
Angelo Rosso: grazie alla sega meccanica di cui disponeva, dal suo laboratorio di Val–
docco, presso la Fucina delle Canne, era in grado di fornire fogli d'impiallacciatura, di
ogni essenza nostrana ed esotica, a tutti gli stipettai torinesi. E «particolarmente quelli
d'agrifoglio [erano] notabili per bellezza e dimensione»41.
Ma sopra tutti, vero erede della tradizione settecentesca, primeggiava Gabriele
Capello, detto Moncalvo, dal nome del paese d 'origine. «I mobili della sua fabbrica
per differenti usi dal più semplice al più ricco sono eseguiti con esattezza, con gusto e
purezza di forme, varietà nel disegno, ricchezza ed eleganza nelle sculture ed intarsia–
ture»42. Non tutti condividevano questo giudizio. Se l'esecuzione dei mobili era sem–
pre perfetta «talvolta però entravi un elemento che dal buon gusto, propriamente
detto, li discosta»; il che veniva giustificato con la constatazione che «anch'egli servir
deve ad una potenza la quale, non che la sua, ben cento altre arti signoreggia; la moda,
vogliam dire, appo la quale buon gusto suona lo stesso che buon genere, il genere cioè
36
L.
B ULFERETII
e
R.
L URAGHI ,
Agricoltura, industria
e commercio
cit., pp. 115-116.
J7
Giudizio
1844 cit. , p. 378.
J8
Ibidem,
p. 400.
J9
Ibidem.
40
Ibidem,
p. 405 per entrambe le citazioni .
41
Ibidem.
42
Giudizio 1850
cit., p. 175 .
355


















