
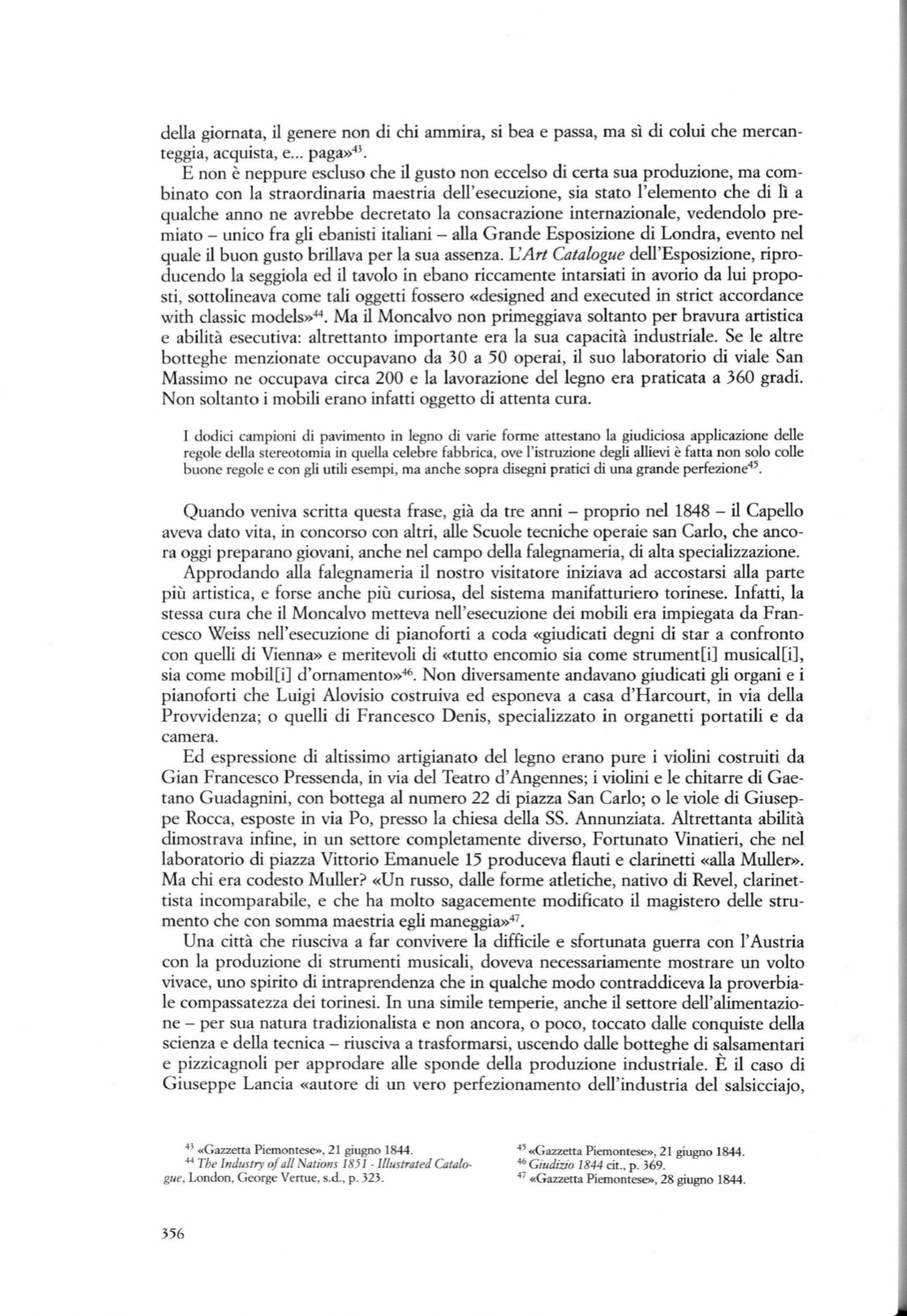
della giornata, il genere non di chi ammira, si bea e passa, ma sÌ di colui che mercan-
.
.
43
teggla, acqUista, e... paga» .
E non è neppure escluso che il gusto non eccelso di certa sua produzione, ma com–
binato con la straordinaria maestria dell' esecuzione, sia stato l'elemento che di
lì
a
qualche anno ne avrebbe decretato la consacrazione internazionale, vedendolo pre–
miato - unico fra gli ebanisti italiani - alla Grande Esposizione di Londra, evento nel
quale
il
buon gusto brillava per la sua assenza.
L'Art Catalogue
dell'Esposizione, ripro–
ducendo la seggiola ed il tavolo in ebano riccamente intarsiati in avorio da lui propo–
sti, sottolineava come tali oggetti fossero «designed and executed in strict accordance
with classic models»44. Ma il Moncalvo non primeggiava soltanto per bravura artistica
e abilità esecutiva: altrettanto importante era la sua capacità industriale. Se le altre
botteghe menzionate occupavano da 30 a 50 operai, il suo laboratorio di viale San
Massimo ne occupava circa 200 e la lavorazione del legno era praticata a 360 gradi.
Non soltanto i mobili erano infatti oggetto di attenta cura.
I dodici campioni di pavimento
in
legno di varie forme attestano la giudiciosa applicazione delle
regole della stereotomia
in
quella celebre fabbrica, ove l'istruzione degli allievi è fatta non solo colle
buone regole e con gli utili esempi, ma anche sopra disegni pratici di una grande perfezione
45 .
Quando veniva scritta questa frase, già da tre anni - proprio nel 1848 - il Capello
aveva dato vita, in concorso con altri, alle Scuole tecniche operaie san Carlo, che anco–
ra oggi preparano giovani, anche nel campo della falegnameria, di alta specializzazione.
Approdando alla falegnameria il nostro visitatore iniziava ad accostarsi alla parte
più artistica, e forse anche più curiosa, del sistema manifatturiero torinese. Infatti, la
stessa cura che il Moncalvo metteva nell'esecuzione dei mobili era impiegata da Fran–
cesco Weiss nell'esecuzione di pianoforti a coda «giudicati degni di star a confronto
con quelli di Vienna» e meritevoli di «tutto encomio sia come strument[i] musical[i],
sia come mobil[i] d 'ornamento»46. Non diversamente andavano giudicati gli organi e i
pianoforti che Luigi Alovisio costruiva ed esponeva a casa d'Harcourt, in via della
Provvidenza; o quelli di Francesco Denis, specializzato in organetti portatili e da
camera.
Ed espressione di altissimo artigianato del legno erano pure i violini costruiti da
Gian Francesco Pressenda, in via del Teatro d'Angennes; i violini e le chitarre di Gae–
tano Guadagnini, con bottega al numero 22 di piazza San Carlo; o le viole di Giusep–
pe Rocca, esposte in via Po, presso la chiesa della SS. Annunziata. Altrettanta abilità
dimostrava infine, in un settore completamente diverso, Fortunato Vinatieri, che nel
laboratorio di piazza Vittorio Emanuele 15 produceva flauti e clarinetti «alla Muller».
Ma chi era codesto Muller? «Un russo, dalle forme atletiche, nativo di Revel, clarinet–
tista incomparabile, e che ha molto sagacemente modificato il magistero delle stru–
mento che con somma maestria egli maneggia»47 .
Una città che riusciva a far convivere la difficile e sfortunata guerra con l'Austria
con la produzione di strumenti musicali, doveva necessariamente mostrare un volto
vivace, uno spirito di intraprendenza che in qualche modo contraddiceva la proverbia–
le compassatezza dei torinesi. In una simile temperie, anche il settore dell' alimentazio–
ne - per sua natura tradizionalista e non ancora, o poco, toccato dalle conquiste della
scienza e della tecnica - riusciva a trasformarsi, uscendo dalle botteghe di salsamentari
e pizzicagnoli per approdare alle sponde della produzione industriale.
È
il caso di
Giuseppe Lancia «autore di un vero perfezionamento dell 'industria del salsicciajo,
43
«Gazzetta Piemontese», 21 giugno 1844.
44
The Industry
0/
all Nations
1851 -
Wustrated Catalo–
gue,
London, George Vertue, s.d., p. 323 .
356
45
«Gazzetta Piemontese», 21 giugno 1844.
46
Giudizio
1844 cit., p. 369.
47
«Gazzetta Piemontese», 28 giugno 1844.


















