
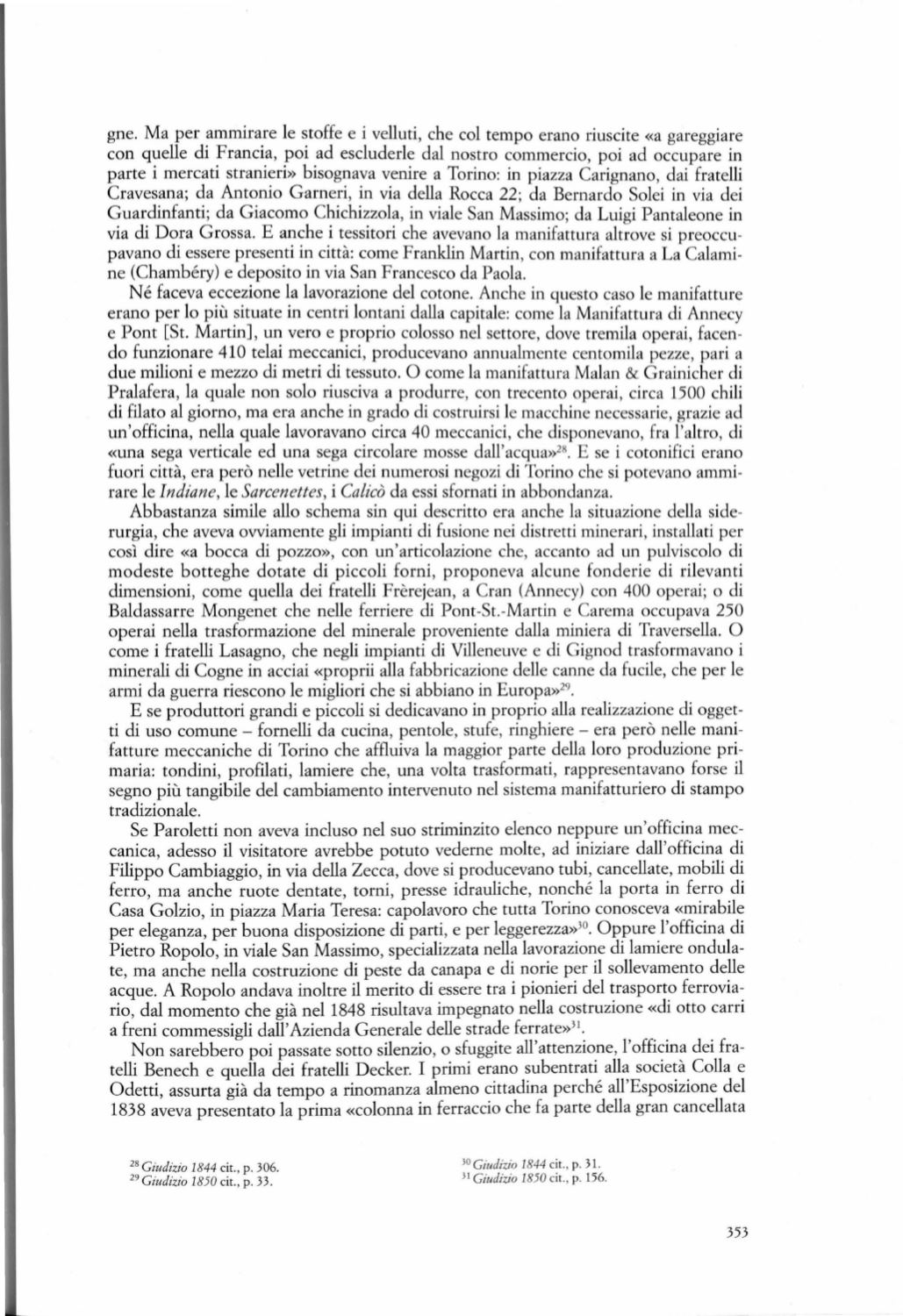
gne. Ma per ammirare le stoffe e i velluti, che col tempo erano riuscite «a gareggiare
con quelle di Francia, poi ad escluderle dal nostro commercio, poi ad occupare in
parte i mercati stranieri» bisognava venire a Torino: in piazza Carignano, dai fratelli
Cravesana; da Antonio Garneri, in via della Rocca
22;
da Bernardo Solei in via dei
Guardinfanti; da Giacomo Chichizzola, in viale San Massimo; da Luigi Pantaleone in
via di Dora Grossa. E anche i tessitori che avevano la manifattura altrove si preoccu–
pavano di essere presenti in città: come Frank1in Martin, con manifattura a La Calami–
ne (Chambéry) e deposito in via San Francesco da Paola.
Né faceva eccezione la lavorazione del cotone. Anche in questo caso le manifatture
erano per lo più situate in centri lontani dalla capitale: come la Manifattura di Annecy
e Pont [St. Martin], un vero e proprio colosso nel settore, dove tremila operai, facen–
do funzionare 410 telai meccanici, producevano annualmente centomila pezze, pari a
due milioni e mezzo di metri di tessuto. O come la manifattura Malan
&
Grainicher di
Pralafera, la quale non solo riusciva a produrre, con trecento operai, circa
1500
chili
di filato al giorno, ma era anche in grado di costruirsi le macchine necessarie, grazie ad
un' officina, nella quale lavoravano circa 40 meccanici, che disponevano, fra l'altro, di
«una sega verticale ed una sega circolare mosse dall 'acqua»28. E se i cotonifici erano
fuori città, era però nelle vetrine dei numerosi negozi di Torino che si potevano ammi–
rare le
Indiane,
le
Sareenettes,
i
Calieò
da essi sfornati in abbondanza.
Abbastanza simile allo schema sin qui descritto era anche la situazione della side–
rurgia, che aveva ovviamente gli impianti di fusione nei distretti minerari, installati per
così dire «a bocca di pozzo», con un'articolazione che, accanto ad un pulviscolo di
modeste botteghe dotate di piccoli forni, proponeva alcune fonderie di rilevanti
dimensioni, come quella dei fratelli Frèrejean, a Cran (Annecy) con 400 operai; o di
Baldassarre Mongenet che nelle ferriere di Pont-St.-Martin e Carema occupava
250
operai nella trasformazione del minerale proveniente dalla miniera di Traversella. O
come i fratelli Lasagno, che negli impianti di Villeneuve e di Gignod trasformavano i
minerali di Cogne in acciai «proprii alla fabbricazione delle canne da fucile, che per le
armi da guerra riescono le migliori che si abbiano in Europa»29.
E se produttori grandi e piccoli si dedicavano in proprio alla realizzazione di ogget–
ti di uso comune - fornelli da cucina, pentole, stufe, ringhiere - era però nelle mani–
fatture meccaniche di Torino che affluiva la maggior parte della loro produzione pri–
maria: tondini, profilati, lamiere che, una volta trasformati, rappresentavano forse
il
segno più tangibile del cambiamento intervenuto nel sistema manifatturiero di stampo
tradizionale.
Se Paroletti non aveva incluso nel suo striminzito elenco neppure un'officina mec–
canica, adesso il visitatore avrebbe potuto vederne molte, ad iniziare dall'officina di
Filippo Cambiaggio, in via della Zecca, dove si producevano tubi, cancellate, mobili di
ferro, ma anche ruote dentate, torni, presse idrauliche, nonché la porta in ferro di
Casa Golzio, in piazza Maria Teresa: capolavoro che tutta Torino conosceva «mirabile
per eleganza, per buona disposizione di parti, e per leggerezza»3o. Oppure l'officina di
Pietro Ropolo, in viale San Massimo, specializzata nella lavorazione di lamiere ondula–
te, ma anche nella costruzione di peste da canapa e di norie per il sollevamento delle
acque. A Ropolo andava inoltre il merito di essere tra i pionieri del trasporto ferrovia–
rio, dal momento che già nel 1848 risultava impegnato nella costruzione «di otto carri
a freni commessigli dall'Azienda Generale delle strade ferrate»31.
Non sarebbero poi passate sotto silenzio, o sfuggite all' attenzione, l'officina dei fra–
telli Benech e quella dei fratelli Decker. I primi erano subentrati alla società Colla e
Odetti, assurta già da tempo a rinomanza almeno cittadina perché all'Esposizione del
1838 aveva presentato la prima «colonna in ferraccio che fa parte della gran cancellata
28
Giudizio
1844
cit. ,
p. 306.
29
Giudizio 1850
cit.,
p. 33.
30
Giudizio
1844
cit. ,
p.
3l.
31
Giudizio 1850
cit.,
p.
156.
353


















