
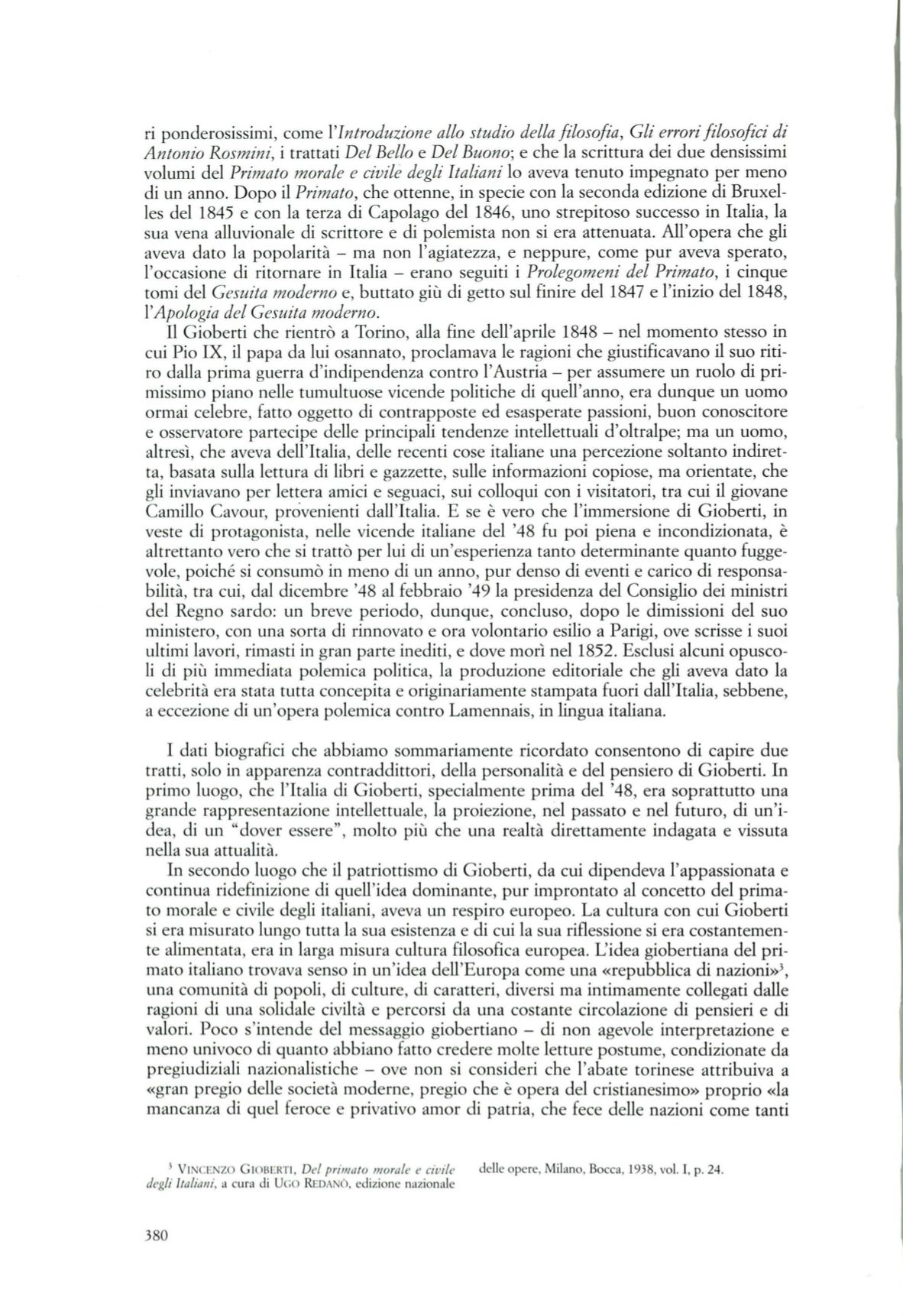
ri ponderosissimi, come
l'Introduzione allo studio della filosofia, Gli errori filosofici di
Antonio Rosmini,
i trattati
Del Bello
e
Del Buono;
e che la scrittura dei due densissimi
volumi del
Primato morale e civile degli Italiani
lo aveva tenuto impegnato per meno
di un anno. Dopo il
Primato,
che ottenne, in specie con la seconda edizione di Bruxel–
les del 1845 e con la terza di Capolago del 1846, uno strepitoso successo in Italia, la
sua vena alluvionale di scrittore e di polemista non si era attenuata. All' opera che gli
aveva dato la popolarità - ma non l'agiatezza, e neppure, come pur aveva sperato,
l'occasione di ritornare in Italia - erano seguiti i
Prolegomeni del Primato,
i cinque
tomi del
Gesuita moderno
e, buttato giù di getto sul finire del 1847 e l'inizio del 1848,
l'Apologia del Gesuita moderno.
Il Gioberti che rientrò a Torino, alla fine dell'aprile 1848 - nel momento stesso in
cui Pio IX, il papa da lui osannato, proclamava le ragioni che giustificavano il suo riti–
ro dalla prima guerra d'indipendenza contro l'Austria - per assumere un ruolo di pri–
missimo piano nelle tumultuose vicende politiche di quell' anno, era dunque un uomo
ormai celebre, fatto oggetto di contrapposte ed esasperate passioni, buon conoscitore
e osservatore partecipe delle principali tendenze intellettuali d'oltralpe; ma un uomo,
altresÌ , che aveva dell'Italia, delle recenti cose italiane una percezione soltanto indiret–
ta , basata sulla lettura di libri e gazzette, sulle informazioni copiose, ma orientate, che
gli inviavano per lettera amici e seguaci, sui colloqui con i visitatori, tra cui il giovane
Camillo Cavour, provenienti dall'Italia. E se è vero che l'immersione di Gioberti, in
veste di protagonista, nelle vicende italiane del '48 fu poi piena e incondizionata,
è
altrettanto vero che si trattò per lui di un 'esperienza tanto determinante quanto fugge–
vole, poiché si consumò in meno di un anno, pur denso di eventi e carico di responsa–
bilità, tra cui, dal dicembre'48 al febbraio' 49 la presidenza del Consiglio dei ministri
del Regno sardo: un breve periodo, dunque, concluso, dopo le dimissioni del suo
ministero, con una sorta di rinnovato e ora volontario esilio a Parigi, ove scrisse i suoi
ultimi lavori, rimasti in gran parte inediti, e dove morì nel 1852. Esclusi alcuni opusco–
li di più immediata polemica politica, la produzione editoriale che gli aveva dato la
celebrità era stata tutta concepita e originariamente stampata fuori dall'Italia, sebbene,
a eccezione di un' opera polemica contro Lamennais, in lingua italiana.
I dati biografici che abbiamo sommariamente ricordato consentono di capire due
tratti, solo in apparenza contraddittori, della personalità e del pensiero di Gioberti. In
primo luogo, che l'Italia di Gioberti, specialmente prima del '48, era soprattutto una
grande rappresentazione intellettuale, la proiezione, nel passato e nel futuro, di un'i–
dea , di un "dover essere" , molto più che una realtà direttamente indagata e vissuta
nella sua attualità.
In secondo luogo che il patriottismo di Gioberti, da cui dipendeva l'appassionata e
continua ridefinizione di quell'idea dominante, pur improntato al concetto del prima–
to morale e civile degli italiani, aveva un respiro europeo. La cultura con cui Gioberti
si era misurato lungo tutta la sua esistenza e di cui la sua riflessione si era costantemen–
te alimentata, era in larga misura cultura filosofica europea. L'idea giobertiana del pri–
mato italiano trovava senso in un 'idea dell 'Europa come una «repubblica di nazioni»3,
una comunità di popoli , di culture, di caratteri, diversi ma intimamente collegati dalle
ragioni di una solidale civiltà e percorsi da una costante circolazione di pensieri e di
valori. Poco s'intende del messaggio giobertiano - di non agevole interpretazione e
meno univoco di quanto abbiano fatto credere molte letture postume, condizionate da
pregiudiziali nazionalistiche - ove non si consideri che l'abate torinese attribuiva a
«gran pregio delle società moderne, pregio che è opera del cristianesimo» proprio «la
mancanza di quel feroce e privativo amor di patria , che fece delle nazioni come tanti
J
VI NCENZO GIOBERTI,
Del primato morale e civile
delle opere, Milano, Bocca, 1938, voI. I, p.
24.
degli Italiani,
a cura di
Uco
REDANÒ,
edizione nazionale
380


















