
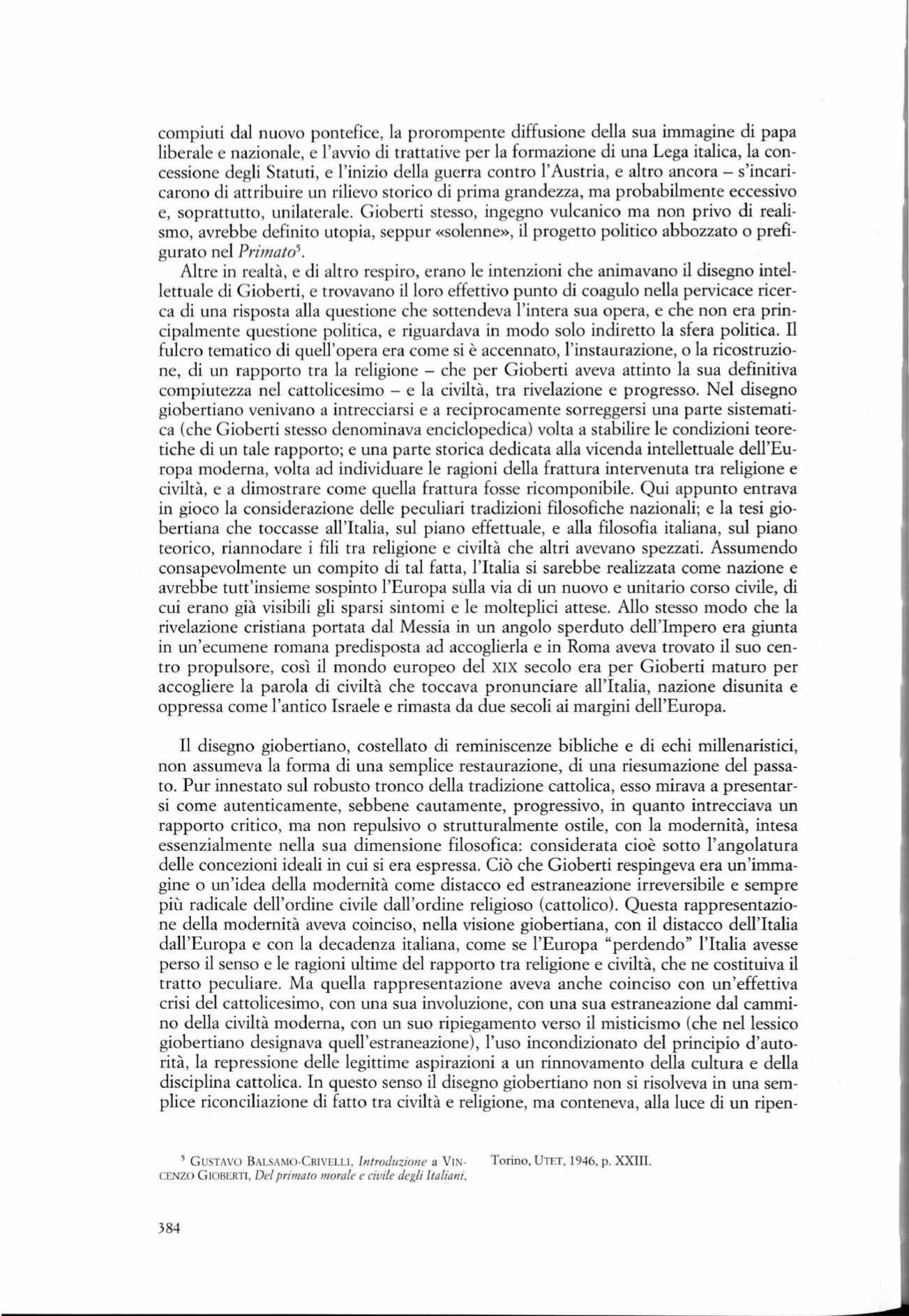
compiuti dal nuovo pontefice, la prorompente diffusione della sua immagine di papa
liberale e nazionale, e l'awio di trattative per la formazione di una Lega italica, la con–
cessione degli Statuti, e l'inizio della guerra contro l'Austria, e altro ancora - s'incari–
carono di attribuire un rilievo storico di prima grandezza, ma probabilmente eccessivo
e, soprattutto , unilaterale. Gioberti stesso , ingegno vulcanico ma non privo di reali–
smo, avrebbe definito utopia, seppur «solenne», il progetto politico abbozzato o prefi–
gurato nel
Primato
5 •
Altre in realtà, e di altro respiro , erano le intenzioni che animavano il disegno intel–
lettuale di Gioberti, e trovavano il loro effettivo punto di coagulo nella pervicace ricer–
ca di una risposta alla questione che sottendeva l'intera sua opera, e che non era prin–
cipalmente questione politica, e riguardava in modo solo indiretto la sfera politica. Il
fulcro tematico di quell 'opera era come si è accennato, l'instaurazione, o la ricostruzio–
ne, di un rapporto tra la religione - che per Gioberti aveva attinto la sua definitiva
compiutezza nel cattolicesimo - e la civiltà, tra rivelazione e progresso. Nel disegno
giobertiano venivano a intrecciarsi e a reciprocamente sorreggersi una parte sistemati–
ca (che Gioberti stesso denominava enciclopedica) volta a stabilire le condizioni teore–
tiche di un tale rapporto; e una parte storica dedicata alla vicenda intellettuale dell'Eu–
ropa moderna, volta ad individuare le ragioni della frattura intervenuta tra religione e
civiltà, e a dimostrare come quella frattura fosse ricomponibile. Qui appunto entrava
in gioco la considerazione delle peculiari tradizioni filosofiche nazionali; e la tesi gio–
bertiana che toccasse all'Italia, sul piano effettuale, e alla filosofia italiana, sul piano
teorico, riannodare i fili tra religione e civiltà che altri avevano spezzati. Assumendo
consapevolmente un compito di tal fatta , l'Italia si sarebbe realizzata come nazione e
avrebbe tutt'insieme sospinto l'Europa sulla via di un nuovo e unitario corso civile, di
cui erano già visibili gli sparsi sintomi e le molteplici attese. Allo stesso modo che la
rivelazione cristiana portata dal Messia in un angolo sperduto dell'Impero era giunta
in un 'ecumene romana predisposta ad accoglierla e in Roma aveva trovato il suo cen–
tro propulsore, così il mondo europeo del
XIX
secolo era per Gioberti maturo per
accogliere la parola di civiltà che toccava pronunciare all'Italia, nazione disunita e
oppressa come l'antico Israele e rimasta da due secoli ai margini dell'Europa.
Il disegno giobertiano, costellato di reminiscenze bibliche e di echi millenaristici,
non assumeva la forma di una semplice restaurazione, di una riesumazione del passa–
to. Pur innestato sul robusto tronco della tradizione cattolica, esso mirava a presentar–
si come autenticamente, sebbene cautamente, progressivo, in quanto intrecciava un
rapporto critico, ma non repulsivo o strutturalmente ostile, con la modernità, intesa
essenzialmente nella sua dimensione filosofica : considerata cioè sotto l' angolatura
delle concezioni ideali in cui si era espressa. Ciò che Gioberti respingeva era un'imma–
gine o un'idea della modernità come distacco ed estraneazione irreversibile e sempre
più radicale dell'ordine civile dall 'ordine religioso (cattolico). Questa rappresentazio–
ne della modernità aveva coinciso , nella visione giobertiana, con il distacco dell'Italia
dall 'Europa e con la decadenza italiana, come se l'Europa "perdendo" l'Italia avesse
perso il senso e le ragioni ultime del rapporto tra religione e civiltà, che ne costituiva il
tratto peculiare. Ma quella rappresentazione aveva anche coinciso con un'effettiva
crisi del cattolicesimo, con una sua involuzione, con una sua estraneazione dal cammi–
no della civiltà moderna, con un suo ripiegamento verso il misticismo (che nel lessico
giobertiano designava quell' estraneazione), l'uso incondizionato del principio d'auto–
rità , la repressione delle legittime aspirazioni a un rinnovamento della cultura e della
disciplina cattolica. In questo senso il disegno giobertiano non si risolveva in una sem–
plice riconciliazione di fatto tra civiltà e religione, ma conteneva, alla luce di un ripen-
5 G USTAVO B ALSAMO-CRIVELLI ,
Introduzione
a
VI N-
Torino,
UTET,
1946,
p.
XXIII.
CENZO GIOBERTI,
Del primato morale e civile degli Italiani,
384


















