
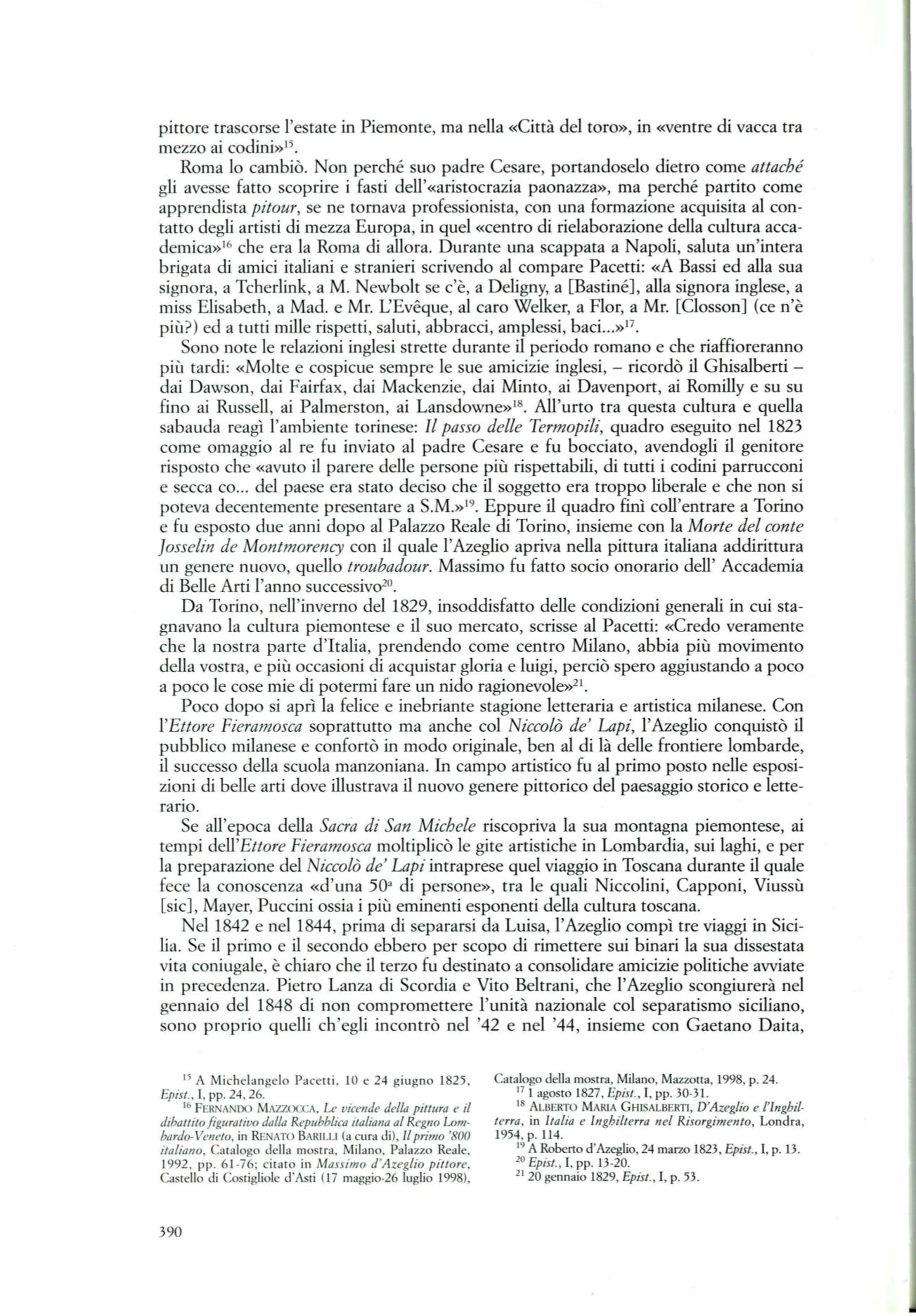
pittore trascorse l'estate in Piemonte, ma nella «Città del toro», in «ventre di vacca tra
mezzo ai codini» 15 .
Roma lo cambiò. Non perché suo padre Cesare, portandoselo dietro come
attaché
gli avesse fatto scoprire i fasti dell'«aristocrazia paonazza», ma perché partito come
apprendista
pitour,
se ne tornava professionista, con una formazione acquisita al con–
tatto degli artisti di mezza Europa, in quel «centro di rielaborazione della cultura acca–
demica»16 che era la Roma di allora. Durante una scappata a Napoli, saluta un'intera
brigata di amici italiani e stranieri scrivendo al compare Pacetti: «A Bassi ed alla sua
signora, a Tcherlink, a M. Newbolt se c'è, a Deligny, a [BastinéJ, alla signora inglese, a
miss Elisabeth, a Mad. e Mr. L'Eveque, al caro Welker, a FIor, a Mr. [Closson] (ce n'è
più?) ed a tutti mille rispetti, saluti, abbracci, amplessi, baci...»17.
Sono note le relazioni inglesi strette durante il periodo romano e che riaffioreranno
più tardi: «Molte e cospicue sempre le sue amicizie inglesi, - ricordò il Ghisalberti -
dai Dawson, dai Fairfax , dai Mackenzie, dai Minto, ai Davenport, ai Romilly e su su
fino ai Russell, ai Palmerston, ai Lansdowne»18. All'urto tra questa cultura e quella
sabauda reagì l'ambiente torinese:
Il passo delle Termopili,
quadro eseguito nel
1823
come omaggio al re fu inviato al padre Cesare e fu bocciato, avendogli il genitore
risposto che «avuto il parere delle persone più rispettabili, di tutti i codini parrucconi
e secca co... del paese era stato deciso che il soggetto era troppo liberale e che non si
poteva decentemente presentare a S.M.»19. Eppure il quadro finì coll'entrare a Torino
e fu esposto due anni dopo al Palazzo Reale di Torino, insieme con la
Morte del conte
foss elin de Montmorency
con
il
quale l'Azeglio apriva nella pittura italiana addirittura
un genere nuovo, quello
troubadour.
Massimo fu fatto socio onorario dell' Accademia
di Belle Arti l'anno successiv0 20 .
Da Torino, nell'inverno del
1829,
insoddisfatto delle condizioni generali in cui sta–
gnavano la cultura piemontese e il suo mercato, scrisse al Pacetti: «Credo veramente
che la nostra parte d'Italia, prendendo come centro Milano, abbia più movimento
della vostra , e più occasioni di acquistar gloria e luigi, perciò spero aggiustando a poco
a poco le cose mie di potermi fare un nido ragionevole»21.
Poco dopo si aprì la felice e inebriante stagione letteraria e artistica milanese. Con
l'Ettore Fieramosca
soprattutto ma anche col
Niccolò de' Lapi,
l'Azeglio conquistò il
pubblico milanese e confortò in modo originale, ben al di là delle frontiere lombarde,
il successo della scuola manzoniana. In campo artistico fu al primo posto nelle esposi–
zioni di belle arti dove illustrava il nuovo genere pittorico del paesaggio storico e lette–
rano.
Se all' epoca della
Sacra di San Michele
riscopriva la sua montagna piemontese, ai
tempi dell'
Ettore Fieramosca
moltiplicò le gite artistiche in Lombardia, sui laghi, e per
la preparazione del
Niccolò de' Lapi
intraprese quel viaggio in Toscana durante il quale
fece la conoscenza «d'una
50"
di persone», tra le quali Niccolini, Capponi, Viussù
[sic] , Mayer, Puccini ossia i più eminenti esponenti della cultura toscana.
Nel
1842
e nel
1844,
prima di separarsi da Luisa, l'Azeglio compì tre viaggi in Sici–
lia. Se il primo e il secondo ebbero per scopo di rimettere sui binari la sua dissestata
vita coniugale, è chiaro che il terzo fu destinato a consolidare amicizie politiche awiate
in precedenza. Pietro Lanza di Scordia e Vito Beltrani, che l'Azeglio scongiurerà nel
gennaio del
1848
di non compromettere l'unità nazionale col separatismo siciliano,
sono proprio quelli ch'egli incontrò nel
'42
e nel
'44,
insieme con Gaetano Daita,
15
A Mi chelange lo Pacet ti,
lO
e 24 giug no 1825,
Epist.,
l ,
pp.
24, 26.
16
FERNANDO MAZZOCCA,
Le vicende della pittura e il
dibattito figurativo dalla Repubblica italiana al Regno Lom–
bardo- Veneto,
in RENATO BARILLI (a cura di) ,
Il primo '800
italiano,
Catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale,
1992, pp. 61-76; citato in
MaSJimo d'Azeglio pittore,
Castello di Costigliole d 'Asti (17 maggio-26 luglio 1998),
390
Catalogo della mostra, Milano, Mazzotta, 1998,
p.
24.
17
l
agosto 1827,
Epist.,
I ,
pp.
30-3
l.
18
ALBERTO MARIA GHISALBERTI,
D'A zeglio e !'Inghil–
terra,
in
Italia e Inghilterra nel Risorgimento,
Londra,
1954, p. 114.
19
A Roberto d'Azeglio, 24 marzo 1823,
Epist.,
I,
p.
13.
20
Epist.,
I,
pp.
13
-20.
21
20 gennaio 1829,
Epist.,
I,
p. 53 .


















