
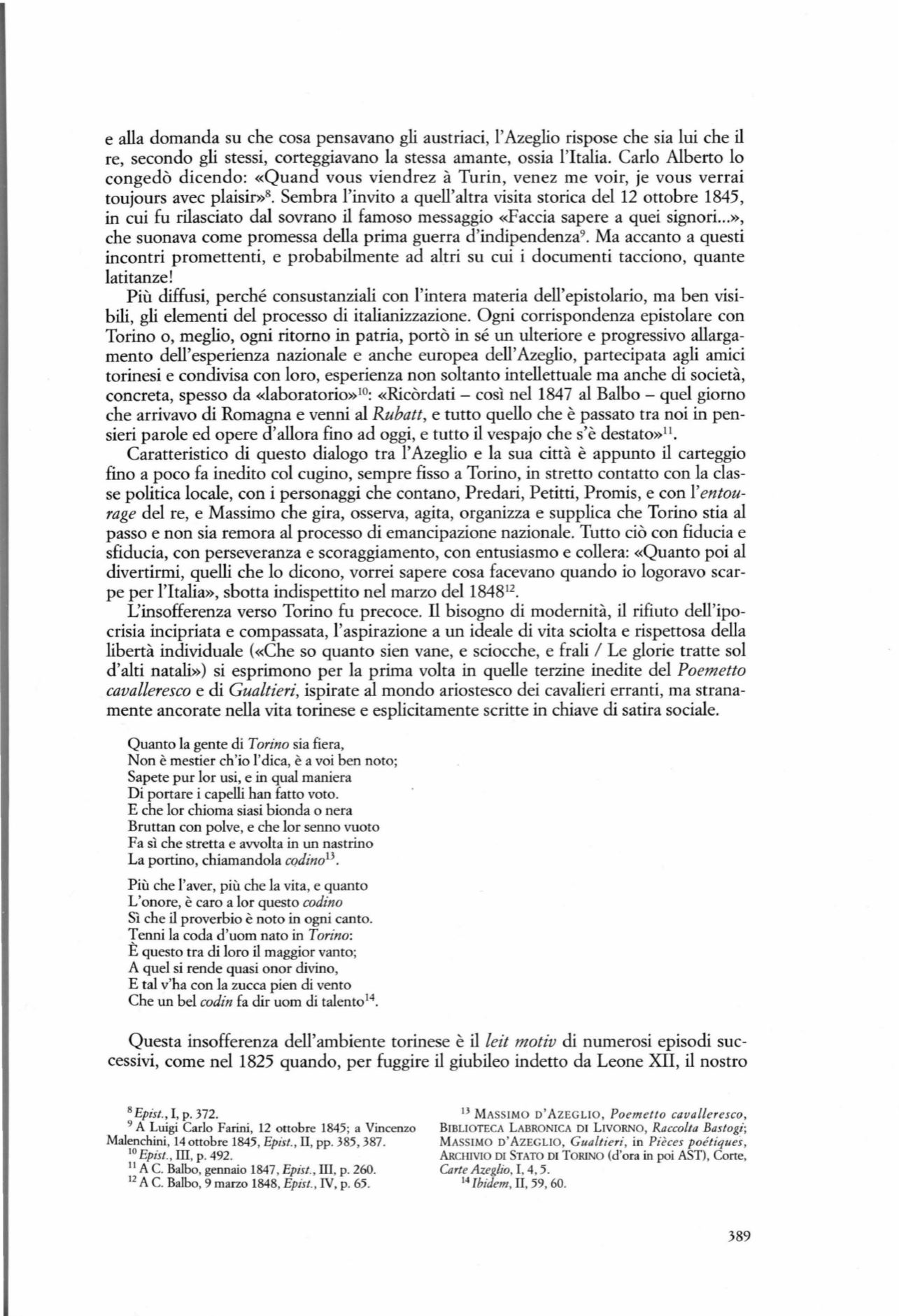
e alla domanda su che cosa pensavano gli austriaci, l'Azeglio rispose che sia lui che il
re, secondo gli stessi, corteggiavano la stessa amante, ossia l'Italia. Carlo Alberto lo
congedò dicendo: «Quand vous viendrez à Turin, venez me voir, je vous verrai
toujours avec plaisir»8. Sembra l'invito a quell'altra visita storica del
12
ottobre
1845,
in cui fu rilasciato dal sovrano il famoso messaggio «Faccia sapere a quei signori...»,
che suonava come promessa della prima guerra d'indipendenza
9 •
Ma accanto a questi
incontri promettenti, e probabilmente ad altri su cui i documenti tacciono, quante
latitanze!
Più diffusi, perché consustanziali con l'intera materia dell'epistolario, ma ben visi–
bili, gli elementi del processo di italianizzazione. Ogni corrispondenza epistolare con
Torino o, meglio, ogni ritorno in patria, portò in sé un ulteriore e progressivo allarga–
mento dell'esperienza nazionale e anche europea dell'Azeglio, partecipata agli amici
torinesi e condivisa con loro, esperienza non soltanto intellettuale ma anche di società,
concreta, spesso da «laboratorio»lO: «Ricòrdati - così nel
1847
al Balbo - quel giorno
che arrivavo di Romagna e venni al
Rubatt,
e tutto quello che è passato tra noi in pen–
sieri parole ed opere d'allora fino ad oggi, e tutto il vespajo che s'è destato»ll .
Caratteristico di questo dialogo tra l'Azeglio e la sua città è appunto il carteggio
fino a poco fa inedito col cugino, sempre fisso a Torino, in stretto contatto con la clas–
se politica locale, con i personaggi che contano, Predari, Petitti, Promis, e con
l'entou–
rage
del re, e Massimo che gira, osserva, agita, organizza e supplica che Torino stia al
passo e non sia remora al processo di emancipazione nazionale. Tutto ciò con fiducia e
sfiducia, con perseveranza e scoraggiamento, con entusiasmo e collera: «Quanto poi al
divertirmi, quelli che lo dicono, vorrei sapere cosa facevano quando io logoravo scar–
pe per l'Italia», sbotta indispettito nel marzo del
1848
12 .
L'insofferenza verso Torino fu precoce.
li
bisogno di modernità, il rifiuto dell'ipo–
crisia incipriata e compassata, l'aspirazione a un ideale di vita sciolta e rispettosa della
libertà individuale (<<Che so quanto sien vane, e sciocche, e frali / Le glorie tratte sol
d'alti natali») si esprimono per la prima volta in quelle terzine inedite del
Poemetto
cavalleresco
e di
Gualtieri,
ispirate al mondo ariostesco dei cavalieri erranti, ma strana–
mente ancorate nella vita torinese e esplicitamente scritte in chiave di satira sociale.
Quanto la gente di
Torino
sia fiera ,
Non è mestier ch'io l'dica, è a voi ben noto;
Sapete pur lor usi, e in qual maniera
Di portare i capelli han fatto voto.
E che lor chioma siasi bionda o nera
Bruttan con polve, e che lor senno vuoto
Fa sì che stretta e avvolta in un nastrino
La portino, chiamandola
cQdino
13 .
Più che l'aver, più che la vita, e quanto
L'onore,
è
caro a lor questo
codino
Sì che
il
proverbio è noto in ogni canto.
Tenni la coda d'uom nato in
Torino:
È
questo tra
di
loro
il
maggior vanto;
A quel si rende quasi onor divino,
E tal v'ha con la zucca pien di vento
Che un bel
codin
fa dir uom di talento
14 .
Questa insofferenza dell' ambiente torinese è il
leit motiv
di numerosi episodi suc–
cessivi, come nel
1825
quando, per fuggire il giubileo indetto da Leone XII, il nostro
8
Epist.,
I,
p.
372.
9
A Luigi Carlo Farini, 12 ottobre 1845; a Vincenzo
Malenchini, 14 ottobre 1845,
Epist.,
II,
pp. 385 , 387 .
lO
Epist.,
ID, p . 492.
11
A
C.
Balbo, gennaio 1847,
Epist.,
ID, p. 260.
12
A
C.
Balbo, 9 marzo 1848,
Epist.,
IV, p. 65.
13
MASS IMO D' AzEGLIO,
Poemett o cavalleresco,
BIBLIOTECA LABRONICA DI LIVORNO,
Raccolta Bastagi;
MASSIMO D'AZEGLIO,
Gualtieri,
in
Pièces poétique"s,
ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi ASTl, Corte,
Carte Azeglio,
I, 4, 5.
14
Ibidem,
II,
59, 60.
389


















