
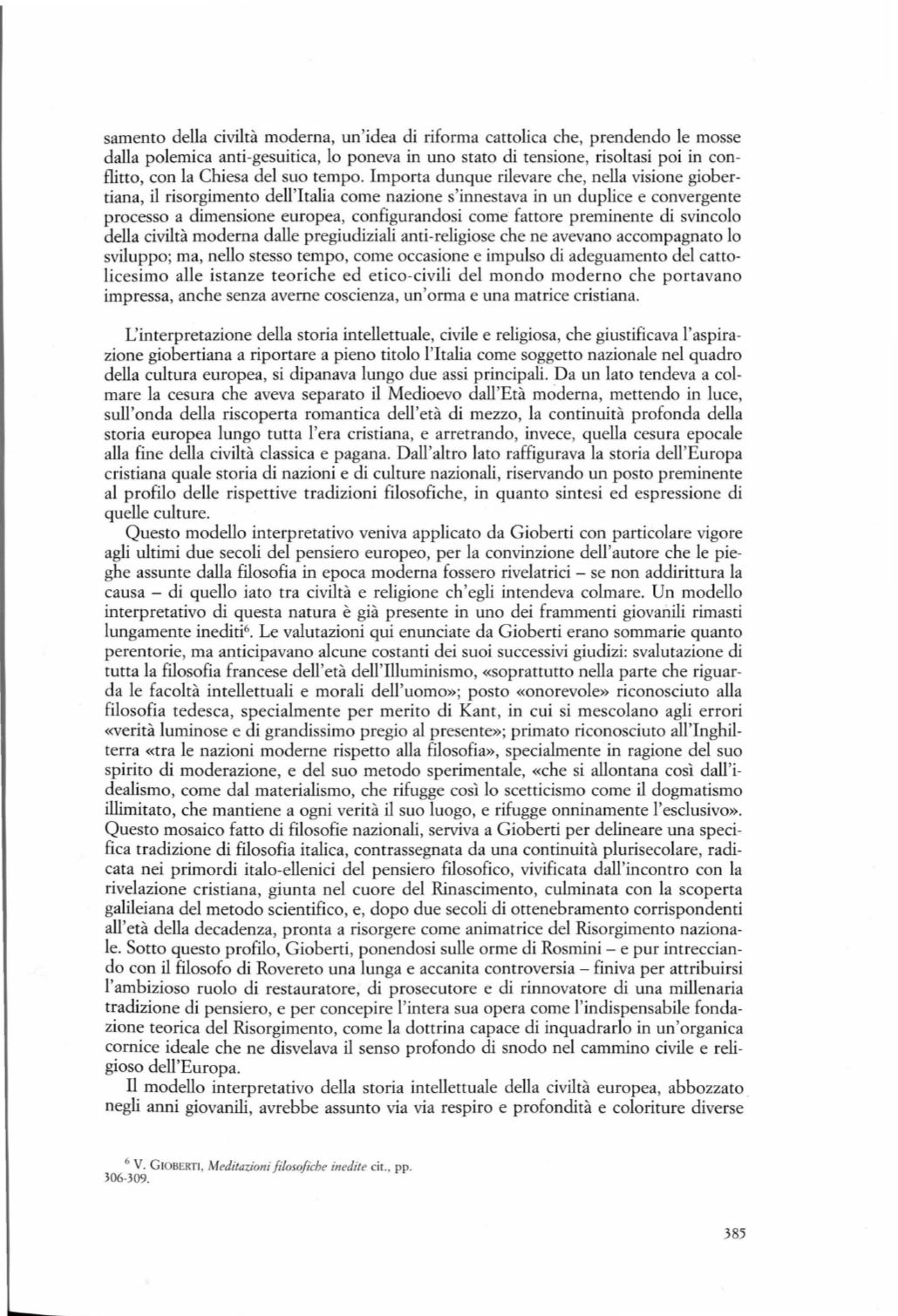
samento della civiltà moderna, un'idea di riforma cattolica che, prendendo le mosse
dalla polemica anti-gesuitica, lo poneva in uno stato di tensione, risoltasi poi in con–
flitto, con la Chiesa del suo tempo. Importa dunque rilevare che, nella visione giober–
tiana, il risorgimento dell'Italia come nazione s'innestava in un duplice e convergente
processo a dimensione europea, configurandosi come fattore preminente di svincolo
della civiltà moderna dalle pregiudiziali anti-religiose che ne avevano accompagnato lo
sviluppo; ma, nello stesso tempo, come occasione e impulso di adeguamento del catto–
licesimo alle istanze teoriche ed etico-civili del mondo moderno che portavano
impressa, anche senza averne coscienza, un' orma e una matrice cristiana.
L'interpretazione della storia intellettuale, civile e religiosa, che giustificava l'aspira–
zione giobertiana a riportare a pieno titolo l'Italia come soggetto nazionale nel quadro
della cultura europea, si dipanava lungo due assi principali. Da un lato tendeva a col–
mare la cesura che aveva separato il Medioevo dall'Età moderna, mettendo in luce,
sull'onda della riscoperta romantica dell' età di mezzo, la continuità profonda della
storia europea lungo tutta l'era cristiana, e arretrando, invece, quella cesura epocale
alla fine della civiltà classica e pagana. Dall'altro lato raffigurava la storia dell'Europa
cristiana quale storia di nazioni e di culture nazionali, riservando un posto preminente
al profilo delle rispettive tradizioni filosofiche, in quanto sintesi ed espressione di
quelle culture.
Questo modello interpretativo veniva applicato da Gioberti con particolare vigore
agli ultimi due secoli del pensiero europeo, per la convinzione dell' autore che le pie–
ghe assunte dalla filosofia in epoca moderna fossero rivelatrici - se non addirittura la
causa - di quello iato tra civiltà e religione ch'egli intendeva colmare. Un modello
interpretativo di questa natura
è
già presente in uno dei frammenti giovanili rimasti
lungamente inediti
6 •
Le valutazioni qui enunciate da Gioberti erano sommarie quanto
perentorie, ma anticipavano alcune costanti dei suoi successivi giudizi: svalutazione di
tutta la filosofia francese dell'età dell'Illuminismo, «soprattutto nella parte che riguar–
da le facoltà intellettuali e morali dell'uomo»; posto «onorevole» riconosciuto alla
filosofia tedesca, specialmente per merito di Kant, in cui si mescolano agli errori
«verità luminose e di grandissimo pregio al presente»; primato riconosciuto all'Inghil–
terra «tra le nazioni moderne rispetto alla filosofia», specialmente in ragione del suo
spirito di moderazione, e del suo metodo sperimentale, «che si allontana così dall'i–
dealismo, come dal materialismo, che rifugge così lo scetticismo come il dogmatismo
illimitato, che mantiene a ogni verità il suo luogo, e rifugge onninamente l'esclusivo».
Questo mosaico fatto di filosofie nazionali, serviva a Gioberti per delineare una speci–
fica tradizione di filosofia italica, contrassegnata da una continuità plurisecolare, radi–
cata nei primordi italo-ellenici del pensiero filosofico, vivificata dall'incontro con la
rivelazione cristiana, giunta nel cuore del Rinascimento, culminata con la scoperta
galileiana del metodo scientifico, e, dopo due secoli di ottenebramento corrispondenti
all'età della decadenza, pronta a risorgere come animatrice del Risorgimento naziona–
le. Sotto questo profilo, Gioberti, ponendosi sulle orme di Rosmini - e pur intreccian–
do con il filosofo di Rovereto una lunga e accanita controversia - finiva per attribuirsi
l'ambizioso ruolo di restauratore, di prosecutore e di rinnovatore di una millenaria
tradizione di pensiero, e per concepire l'intera sua opera come l'indispensabile fonda–
zione teorica del Risorgimento, come la dottrina capace di inquadrarlo in un'organica
cornice ideale che ne disvelava il senso profondo di snodo nel cammino civile e reli–
gioso dell'Europa.
Il modello interpretativo della storia intellettuale della civiltà europea, abbozzato .
negli anni giovanili, avrebbe assunto via via respiro e profondità e coloriture diverse
6
V.
GIOBERTI,
Meditazioni filosof iche inedite
cit. ,
pp.
306-309.
385


















