
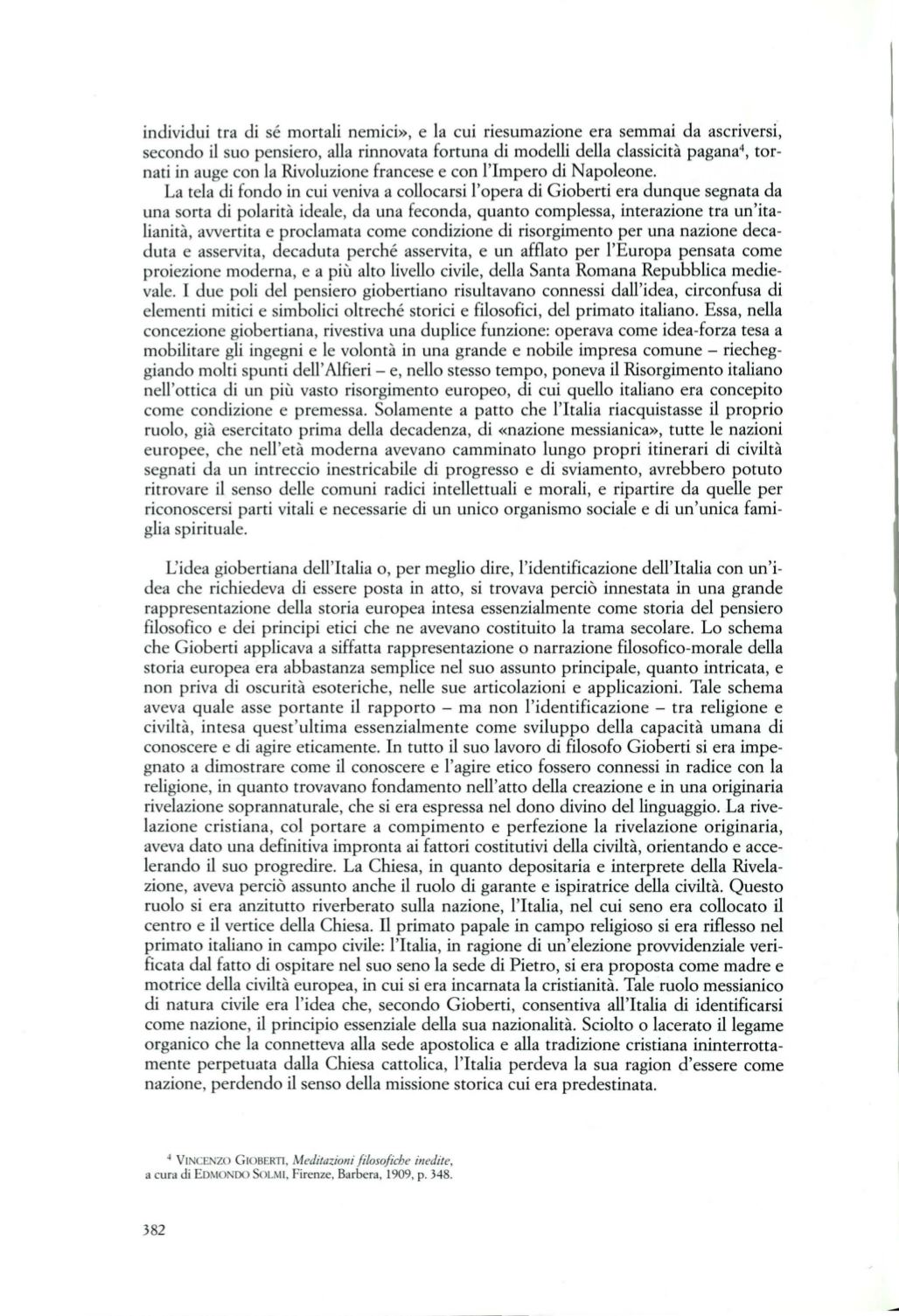
individui tra di sé mortali nemici», e la cui riesumazione era semmai da ascriversi,
secondo il suo pensiero, alla rinnovata fortuna di modelli della classicità pagana
4 ,
tor–
nati in auge con la Rivoluzione francese e con l'Impero di Napoleone.
La tela di fondo in cui veniva a collocarsi l'opera di Gioberti era dunque segnata da
una sorta di polarità ideale, da una feconda, quanto complessa, interazione tra un'ita–
lianità, avvertita e proclamata come condizione di risorgimento per una nazione deca–
duta e asservita, decaduta perché asservita, e un afflato per l'Europa pensata come
proiezione moderna, e a più alto livello civile, della Santa Romana Repubblica medie–
vale. I due poli del pensiero giobertiano risultavano connessi dall'idea, circonfusa di
elementi mitici e simbolici oltreché storici e filosofici, del primato italiano. Essa, nella
concezione giobertiana, rivestiva una duplice funzione: operava come idea-forza tesa a
mobilitare gli ingegni e le volontà in una grande e nobile impresa comune - riecheg–
giando molti spunti dell'Alfieri - e, nello stesso tempo, poneva il Risorgimento italiano
nell' ottica di un più vasto risorgimento europeo, di cui quello italiano era concepito
come condizione e premessa. Solamente a patto che l'Italia riacquistasse il proprio
ruolo, già esercitato prima della decadenza, di «nazione messianica», tutte le nazioni
europee, che nell' età moderna avevano camminato lungo propri itinerari di civiltà
segnati da un intreccio inestricabile di progresso e di sviamento, avrebbero potuto
ritrovare il senso delle comuni radici intellettuali e morali, e ripartire da quelle per
riconoscersi parti vitali e necessarie di un unico organismo sociale e di un'unica fami–
glia spirituale.
L'idea giobertiana dell'Italia o, per meglio dire , l'identificazione dell'Italia con un'i–
dea che richiedeva di essere posta in atto, si trovava perciò innestata in una grande
rappresentazione della storia europea intesa essenzialmente come storia del pensiero
filosofico e dei principi etici che ne avevano costituito la trama secolare. Lo schema
che Gioberti applicava a siffatta rappresentazione o narrazione filosofico-morale della
storia europea era abbastanza semplice nel suo assunto principale, quanto intricata, e
non priva di oscurità esoteriche, nelle sue articolazioni e applicazioni. Tale schema
aveva quale asse portante il rapporto - ma non l'identificazione - tra religione e
civiltà , intesa quest'ultima essenzialmente come sviluppo della capacità umana di
conoscere e di agire eticamente. In tutto il suo lavoro di filosofo Gioberti si era impe–
gnato a dimostrare come il conoscere e l'agire etico fossero connessi in radice con la
religione, in quanto trovavano fondamento nell' atto della creazione e in una originaria
rivelazione soprannaturale, che si era espressa nel dono divino del linguaggio. La rive–
lazione cristiana, col portare a compimento e perfezione la rivelazione originaria,
aveva dato una definitiva impronta ai fattori costitutivi della civiltà, orientando e acce–
lerando il suo progredire. La Chiesa, in quanto depositaria e interprete della Rivela–
zione, aveva perciò assunto anche il ruolo di garante e ispiratrice della civiltà. Questo
ruolo si era anzitutto riverberato sulla nazione, l'Italia, nel cui seno era collocato il
centro e il vertice della Chiesa.
il
primato papale in campo religioso si era riflesso nel
primato italiano in campo civile: l'Italia, in ragione di un'elezione provvidenziale veri–
ficata dal fatto di ospitare nel suo seno la sede di Pietro, si era proposta come madre e
motrice della civiltà europea, in cui si era incarnata la cristianità. Tale ruolo messianico
di natura civile era l'idea che, secondo Gioberti, consentiva all'Italia di identificarsi
come nazione, il principio essenziale della sua nazionalità. Sciolto o lacerato il legame
organico che la connetteva alla sede apostolica e alla tradizione cristiana ininterrotta–
mente perpetuata dalla Chiesa cattolica, l'Italia perdeva la sua ragion d'essere come
nazione, perdendo il senso della missione storica cui era predestinata.
4
VI NCENZO GIOBERTI,
Meditazioni filosofiche inedite,
a cura di
EDMONDO SOlM I,
Firenze, Barbera,
1909,
p.
348.
382


















