
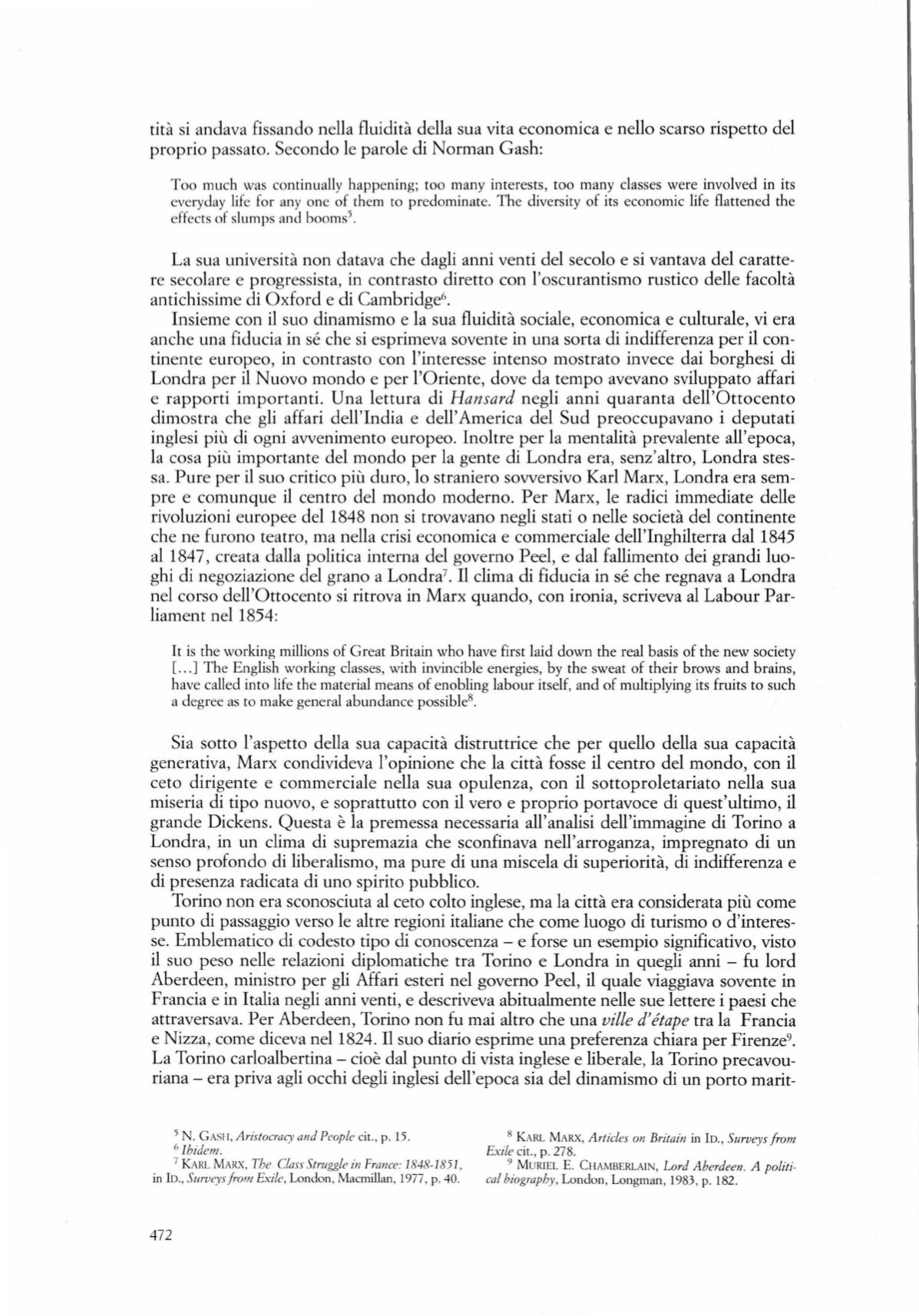
tità si andava fissando nella fluidità della sua vita economica e nello scarso rispetto del
proprio passato. Secondo le parole di Norman Gash:
Too mueh was eontinually happening; too many interests, too many classes were involved in its
everyday life for any one of them to predominate. The diversity of its economie life flattened the
effeets of slumps and booms
5 .
La sua università non datava che dagli anni venti del secolo e si vantava del caratte–
re secolare e progressista, in contrasto diretto con l'oscurantismo rustico delle facoltà
antichissime di Oxford e di Cambridgé.
Insieme con il suo dinamismo e la sua fluidità sociale, economica e culturale, vi era
anche una fiducia in sé che si esprimeva sovente in una sorta di indifferenza per il con–
tinente europeo, in contrasto con l'interesse intenso mostrato invece dai borghesi di
Londra per il Nuovo mondo e per l'Oriente, dove da tempo avevano sviluppato affari
e rapporti importanti. Una lettura di
Hansard
negli anni quaranta dell'Ottocento
dimostra che gli affari dell'India e dell'America del Sud preoccupavano i deputati
inglesi più di ogni avvenimento europeo. Inoltre per la mentalità prevalente all'epoca,
la cosa più importante del mondo per la gente di Londra era, senz'altro, Londra stes–
sa. Pure per il suo critico più duro, lo straniero sovversivo Karl Marx, Londra era sem–
pre e comunque il centro del mondo moderno. Per Marx, le radici immediate delle
rivoluzioni europee del 1848 non si trovavano negli stati o nelle società del continente
che ne furono teatro, ma nella crisi economica e commerciale dell'Inghilterra dal 1845
al 1847, creata dalla politica interna del governo Peel, e dal fallimento dei grandi luo–
ghi di negoziazione del grano a Londra
7 .
Il clima di fiducia in sé che regnava a Londra
nel corso dell'Ottocento si ritrova in Marx quando, con ironia, scriveva al Labour Par–
liament nel 1854:
It is the working millions of Great Britain who have first Iaid down the real basis of the new soeiety
[. ..] The EngIish working classes, with invincible energies, by the sweat of their brows and brains,
have ealled into life the materia! means of enobling Iabour itself, and of multipIying its fruits to sueh
a degree as to make generaI abundanee possibIé.
Sia sotto l'aspetto della sua capacità distruttrice che per quello della sua capacità
generativa, Marx condivideva l'opinione che la città fosse il centro del mondo, con il
ceto dirigente e commerciale nella sua opulenza, con
il
sottoproletariato nella sua
miseria di tipo nuovo, e soprattutto con il vero e proprio portavoce di quest'ultimo, il
grande Dickens. Questa è la premessa necessaria all'analisi dell'immagine di Torino a
Londra, in un clima di supremazia che sconfinava nell' arroganza, impregnato di un
senso profondo di liberalismo, ma pure di una miscela di superiorità, di indifferenza e
di presenza radicata di uno spirito pubblico.
Torino non era sconosciuta al ceto colto inglese, ma la città era considerata più come
punto di passaggio verso le altre regioni italiane che come luogo di turismo o d'interes–
se. Emblematico di codesto tipo di conoscenza - e forse un esempio significativo, visto
il
suo peso nelle relazioni diplomatiche tra Torino e Londra in quegli anni - fu lord
Aberdeen, ministro per gli Mfari esteri nel governo Peel, il quale viaggiava sovente in
Francia e in Italia negli anni venti, e descriveva abitualmente nelle sue lettere i paesi che
attraversava. Per Aberdeen, Torino non fu mai altro che una
ville d
J
étape
tra la Francia
e Nizza, come diceva nel 1824. Il suo diario esprime una preferenza chiara per Firenze
9 .
La Torino carloalbertina - cioè dal punto di vista inglese e liberale, la Torino precavou–
riana - era priva agli occhi degli inglesi dell'epoca sia del dinamismo di un porto marit-
5
N.
G ASH,
Aristocracy and People
cit.,
p.
15.
6
Ibidem.
7 KARL MARX,
The Class Struggle i/1 France.'
/848- 1851,
in
lo.,
Surveysfrom Exile,
London , Macmillan, 1977, p. 40.
8 KARL MARX,
Articles 0/1 Britain
in
lo.,
Surveys from
Exile
cit., p.
278.
9
M URJEL
E.
CHAMBERLAIN,
Lord Aberdeen. A politi–
col biography,
London, Longman, 1983, p. 182.
472


















