
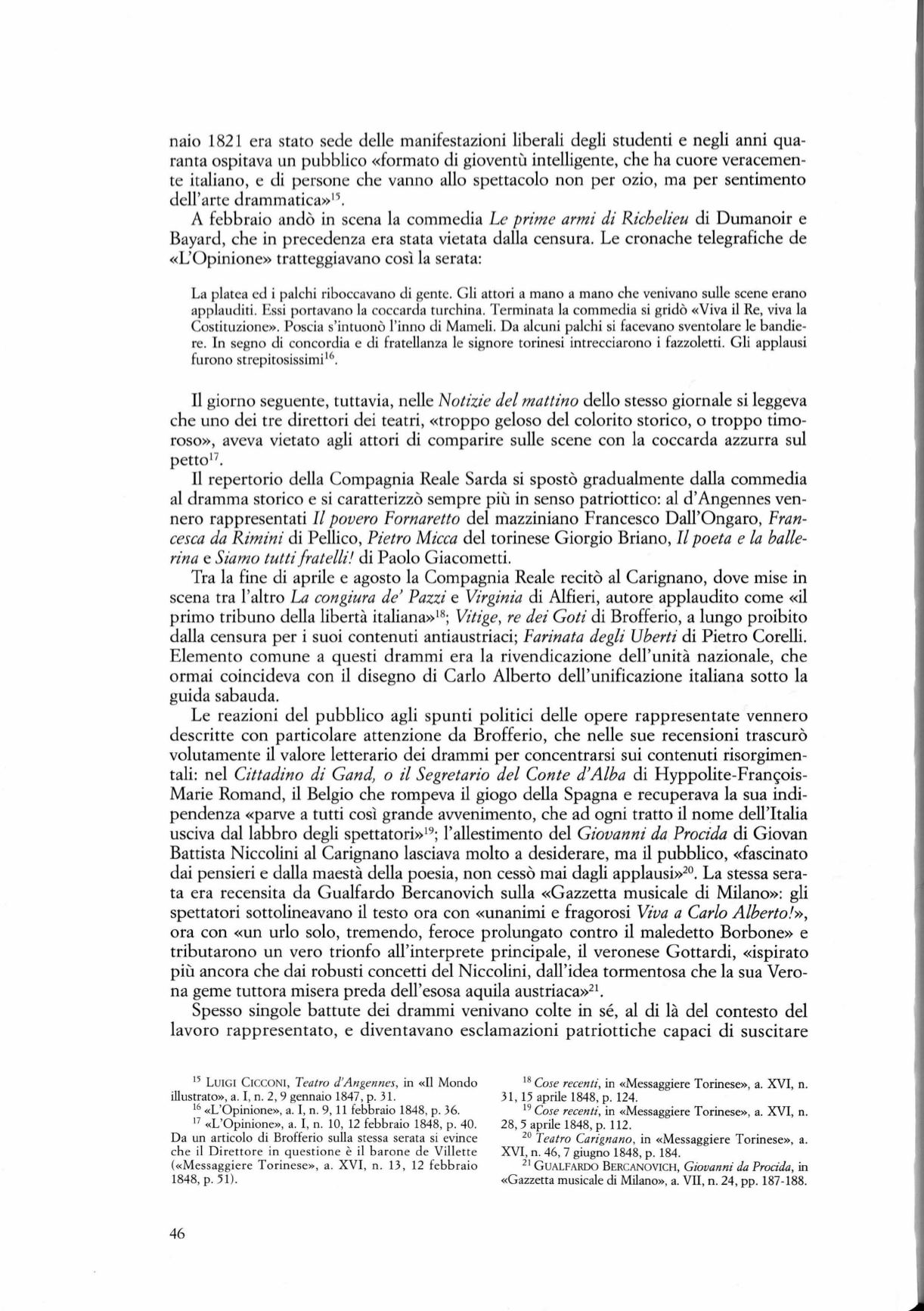
naio 1821 era stato sede delle manifestazioni liberali degli studenti e negli anni qua–
ranta ospitava un pubblico «formato di gioventù intelligente, che ha cuore veracemen–
te italiano, e di persone che vanno allo spettacolo non per ozio, ma per sentimento
dell' arte drammatica»
15.
A febbraio andò in scena la commedia
Le prime armi di Richelieu
di Dumanoir e
Bayard, che in precedenza era stata vietata dalla censura. Le cronache telegrafiche de
«L'Opinione» tratteggiavano così la serata:
La platea ed i palchi riboccavano di gente. Gli attori a mano a mano che venivano sulle scene erano
applauditi. Essi portavano la coccarda turchina. Terminata la commedia si gridò «Viva
il
Re, viva la
Costituzione». Poscia s'intuonò l'inno di Mameli. Da alcuni palchi si facevano sventolare le bandie–
re. In segno di concordia e di fratellanza le signore torinesi intrecciarono i fazzoletti. Gli applausi
furono strepitosissimi
16.
Il giorno seguente, tuttavia, nelle
Notizie del mattino
dello stesso giornale si leggeva
che uno dei tre direttori dei teatri, «troppo geloso del colorito storico, o troppo timo–
roso», aveva vietato agli attori di comparire sulle scene con la coccarda azzurra sul
petto
I7 .
Il repertorio della Compagnia Reale Sarda si spostò gradualmente dalla commedia
al dramma storico e si caratterizzò sempre più in senso patriottico: al d'Angennes ven–
nero rappresentati
Il povero Fornaretto
del mazziniano Francesco Dall'Ongaro,
Fran–
cesca da Rimini
di Pellico,
Pietro Micca
del torinese Giorgio Briano,
Il poeta e la balle–
rina
e
Siamo tutti/ratelli.'
di Paolo Giacometti.
Tra la fine di aprile e agosto la Compagnia Reale recitò al Carignano, dove mise in
scena tra l'altro
La congiura de' Pazzi
e
Virginia
di Alfieri, autore applaudito come «il
primo tribuno della libertà italiana»18;
Vitige, re dei Goti
di Brofferio, a lungo proibito
dalla censura per i suoi contenuti antiaustriaci;
Farinata degli Uberti
di Pietro Corelli.
Elemento comune a questi drammi era la rivendicazione dell 'unità nazionale, che
ormai coincideva con il disegno di Carlo Alberto dell'unificazione italiana sotto la
guida sabauda.
Le reazioni del pubblico agli spunti politici delle opere rappresentate vennero
descritte con particolare attenzione da Brofferio, che nelle sue recensioni trascurò
volutamente il valore letterario dei drammi per concentrarsi sui contenuti risorgimen–
tali: nel
Cittadino di Gand, o il Segretario del Conte d'Alba
di Hyppolite-François–
Marie Romand, il Belgio che rompeva il giogo della Spagna e recuperava la sua indi–
pendenza «parve a tutti così grande avvenimento, che ad ogni tratto il nome dell'Italia
usciva dal labbro degli spettatori»19; l'allestimento del
Giovanni da Procida
di
Giovan
Battista Niccolini al Carignano lasciava molto a desiderare, ma il pubblico, «fascinato
dai pensieri e dalla maestà della poesia, non cessò mai dagli applausi»20. La stessa sera–
ta era recensita da Gualfardo Bercanovich sulla «Gazzetta musicale di Milano»: gli
spettatori sottolineavano il testo ora con «unanimi e fragorosi
Viva a Carlo Alberto.'»,
ora con «un urlo solo, tremendo, feroce prolungato contro il maledetto Borbone» e
tributarono un vero trionfo all'interprete principale, il veronese Gottardi, «ispirato
più ancora che dai robusti concetti del Niccolini, dall'idea tormentosa che la sua Vero–
na geme tuttora misera preda dell'esosa aquila austriaca»21.
Spesso singole battute dei drammi venivano colte in sé, al di là del contesto del
lavoro rappresentato , e diventavano esclamazioni patriottiche capaci di suscitare
15
LUIGI O CCONI,
Teatro d'Angennes,
in «li Mondo
illustrato», a. I, n. 2, 9 gennaio 1847, p. 3l.
16
«L'Opinione», a. I, n. 9, l1 febbraio 1848, p. 36.
17
«L'Opinione», a. I, n. 10, 12 febbraio 1848, p. 40.
Da un articolo di Brofferio sulla stessa serata si evince
che il Direttore in qu estione
è
il
b arone de Villette
«<Messaggie re Torinese» , a. XVI , n. 13 , 12 febbraio
1848, p. 51).
46
18
Cose recenti,
in «Messaggiere Torinese» , a. XVI, n.
31, 15 aprile 1848, p. 124.
19
Cose recenti,
in «Messaggiere Torinese» , a. XVI, n.
28,5 aprile 1848, p. 112.
20
Teatro Carignano ,
in «Messaggiere Torinese», a.
XVI, n. 46, 7 giugno 1848, p. 184.
21
G UALFARDO BERCANOVICH,
Giovanni da Procida,
in
«Gazzetta musicale di Milano» , a. VII, n. 24, pp. 187-188.


















