
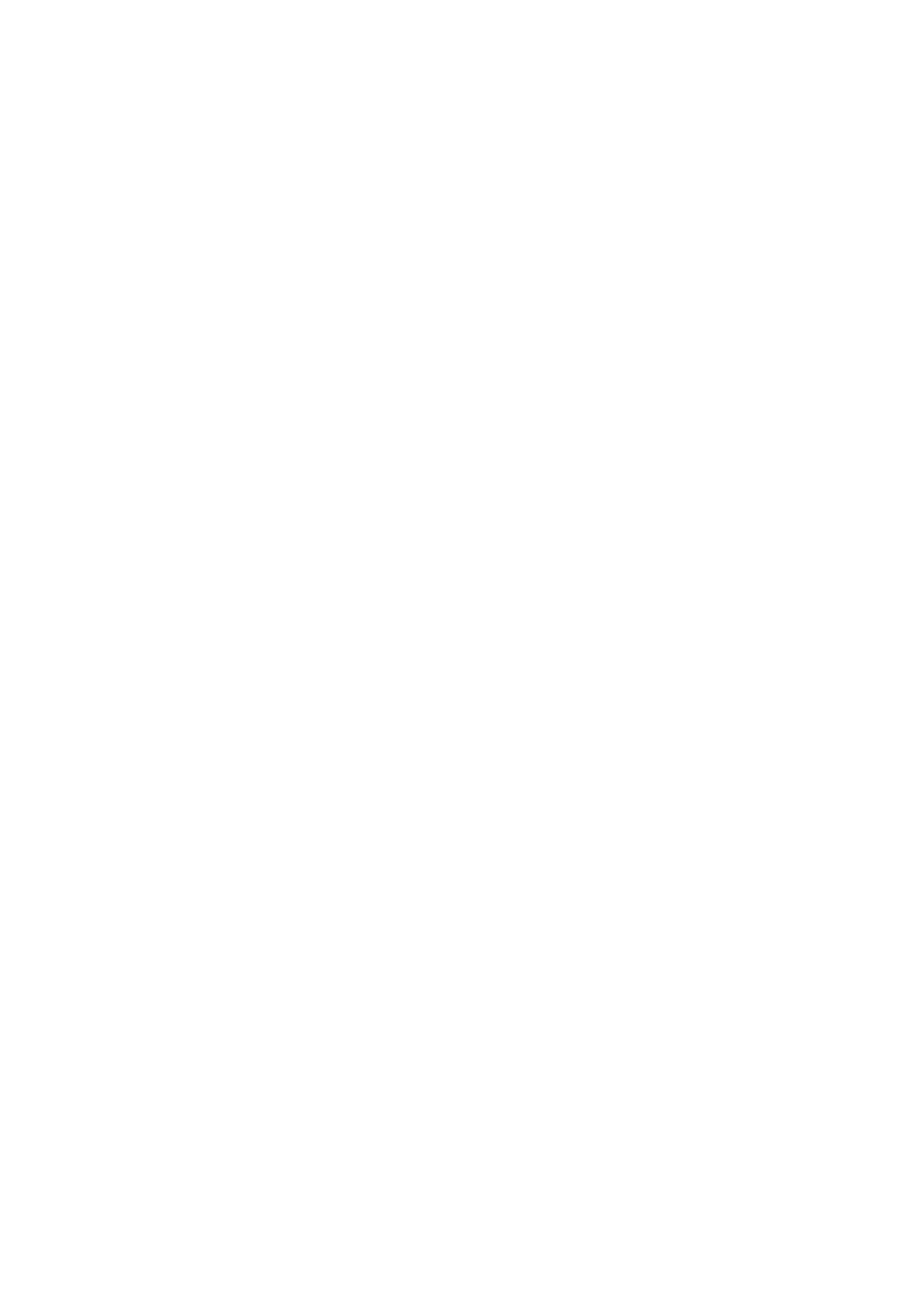
due soltanto – Mondovì e Vercelli – erano anche sedi episcopali. Que-
ste due città, che per tutto il Quattrocento superarono Torino per po-
polazione e vitalità economica, erano però troppo lontane rispetto al
cuore dei dominî sabaudi, come troppo periferica era la grossa
villa
di
Cuneo. La concorrenza avvenne dunque di fatto con le maggiori loca-
lità dell’antico principato d’Acaia: Pinerolo, Moncalieri e Savigliano, a
cui si aggiunse, sporadicamente, la non lontana Chieri.
Fu necessario circa un ventennio perché la città affermasse la pro-
pria preminenza politico-amministrativa sulle altre comunità piemonte-
si, risolvendo a suo favore quella sorta di bipolarità che con Pinerolo,
ancora attiva come residenza principesca, si era sviluppata alla morte di
Ludovico d’Acaia. Alla base dell’affermazione di Torino c’era un du-
plice, importante, risultato: pur dopo molte esitazioni e accollandosi
oneri finanziari gravosi per superare una concorrenza aspra, dai risulta-
ti spesso incerti e contraddittori, con le altre comunità, la città aveva
ottenuto che vi risiedessero per sempre sia lo Studio, sia il Consiglio ci-
smontano, nato nel 1419 con funzioni di corte d’appello per tutti i do-
minî sabaudi al di qua delle Alpi. Si delineò per la prima volta in quegli
anni – evidenzia bene Alessandro Barbero in un saggio-chiave di que-
sto volume – anche un altro motivo che avrebbe affermato la centralità
politica di Torino nel ducato dei Savoia: la sua collocazione ideale non
soltanto
sugli assi stradali che collegavano i dominî cismontani a quelli oltremontani, ma an-
che e soprattutto rispetto a una politica di espansione orientata verso la pianura lom-
barda, a un teatro di operazioni militari incentrato sulla linea della Sesia e ad una
prassi diplomatica che prevedeva frequenti colloqui con gli oratori milanesi e vene-
ziani, più propensi evidentemente a fermarsi a Torino anziché affrontare la tappa
in più necessaria per raggiungere Pinerolo
6
.
Pinerolo cercò allora una compensazione a questo stato di cose, che
la indeboliva demograficamente e commercialmente («populo merci-
moniisque»), ottenendo da Ludovico di Savoia il riconoscimento di va-
rie esenzioni fiscali per tutti coloro che vi erano attivi nella manifattu-
ra della lana, puntando in altre parole esplicitamente, in analogia ma con
maggiore decisione rispetto a quanto era avvenuto nella Torino trecen-
tesca, a rafforzare almeno la propria centralità economica nella produ-
zione di pannilana
7
.
xx
Rinaldo Comba
6
a. barbero
,
Il mutamento dei rapporti fra Torino e le altre comunità del Piemonte nel nuovo as-
setto del ducato sabaudo
, in questo stesso volume, p. 385.
7
Edizione delle patenti in
a. caffaro
,
L’arte del lanificio in Pinerolo e gli statuti di essa
, estrat-
to da «Miscellanea di storia italiana»,
xxx
(1893), pp. 30 sgg.


















