
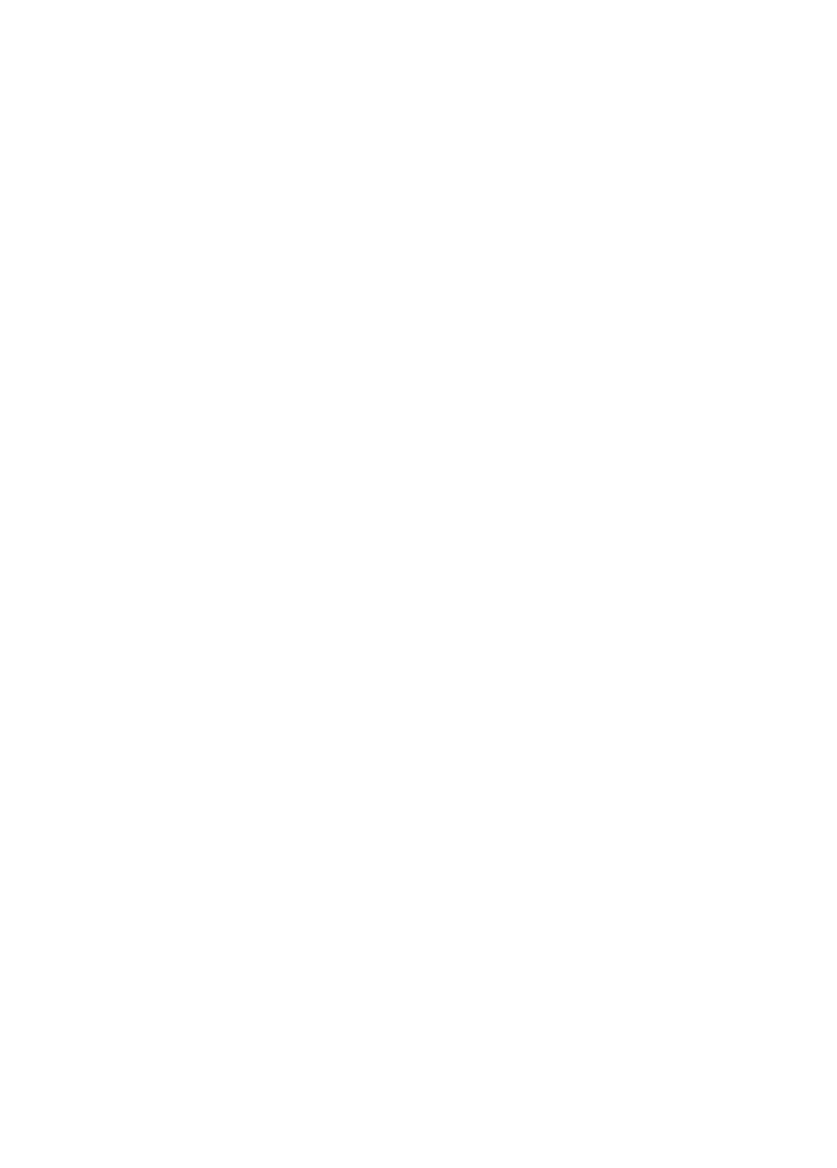
Il passo successivo, dopo decenni di consolidamento della centralità
politica e amministrativa acquisita nel Piemonte sabaudo, fu, già alla fi-
ne del Quattrocento, la trasformazione di fatto, grazie alla prevalenza
strategica tutta recente dei dominî cismontani su quelli savoiardi, in ca-
pitale dell’intero ducato: una capitale finalmente abituata a essere per
lunghi periodi anche la residenza di quei duchi sabaudi e della loro cor-
te, che sino a quel momento, in quanto appunto residenza, l’avevano
assai poco apprezzata. Nei primi decenni del Cinquecento avvenne poi
un passo ulteriore: il primato di Torino si consolidò grazie alle esigenze
di stabilità della burocrazia ducale e all’insediamento in città del «Con-
silium cum domino residens», da sempre itinerante, mentre la Camera
dei Conti continuava a risiedere, come ormai avveniva da secoli, a
Chambéry. Ormai capitale amministrativa di fatto di tutto il ducato,
Torino divenne, nel secondo decennio di quel secolo, anche sede me-
tropolitana acquisendo funzioni centrali più rilevanti in campo eccle-
siastico, ma la costituzione dell’arcidiocesi non fu il risultato di un na-
turale processo di crescita di importanza della diocesi torinese: fu una
sorta di compensazione della costituzione, nel 1511, della nuova dioce-
si di Saluzzo che aveva mutilato gravemente l’antico distretto diocesa-
no torinese. Essa ebbe tuttavia il vantaggio di mettere la città in una po-
sizione di prestigio, non soltanto nei confronti delle due diocesi suffra-
ganee di Ivrea e di Mondovì, ma anche rispetto ad altre sedi episcopali
della regione piemontese che eventualmente fossero state inglobate nel
ducato sabaudo.
Tali metamorfosi che, fra
xiv
e
xvi
secolo, videro Torino concretiz-
zare in modo tutt’altro che lineare modelli diversi di città e forme
altrettanto diverse di centralità, furono alla base di una crescita demo-
grafica ed economica che, già abbastanza robusta alla metà del Quat-
trocento, divenne tumultuosa nei decenni successivi. Essa fu caratte-
rizzata da un’immigrazione massiccia di manodopera specializzata e di
personale a vocazione burocratica e intellettuale: se nel 1415 erano at-
tivi a Torino 5 dottori in legge e un solo dottore in medicina, nel 1523
i dottori in legge o i loro eredi erano almeno 47 e quelli in medicina 9,
senza contare una cinquantina di causidici, procuratori, segretari e com-
missari ducali. Rilevante anche il folto numero di
mercatores
, piccoli e
grandi, provenienti da gran parte del Piemonte e dalle regioni vicine, ri-
cevuti, ancora nei primi anni del Cinquecento, come
habitatores
. Si ag-
giunse, contemporaneamente, una robusta immigrazione nobiliare che
drenò aristocratici e risorse da gran parte del Piemonte e fece di Tori-
no un centro di consumo soprattutto di prodotti di qualità dalle di-
mensioni insospettate: un centro capace di dar lavoro, nei primi decen-
Torino 1280-1418 / 1418-1536: due modelli di città
xxi


















