
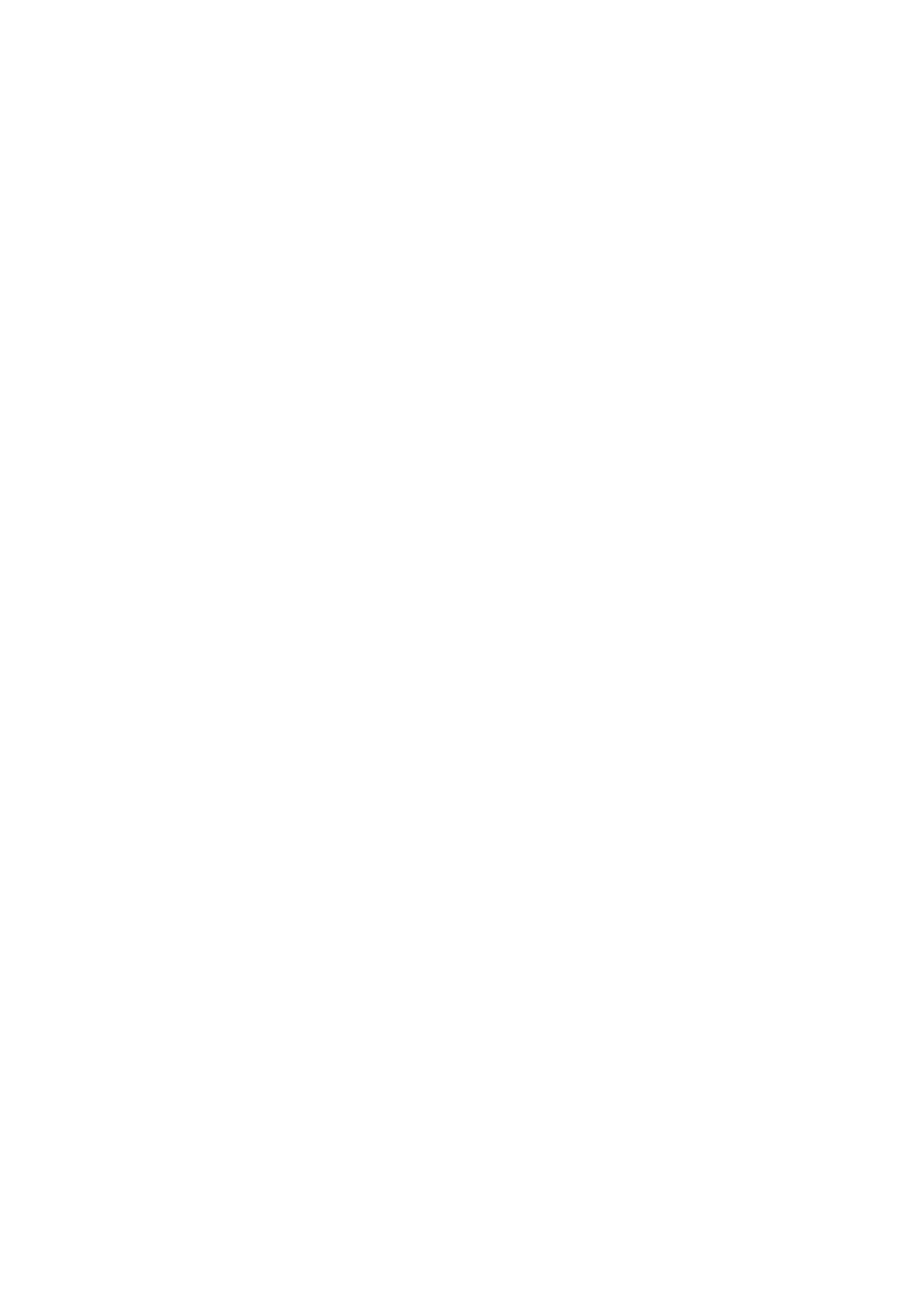
ni del Cinquecento, ad almeno sette pittori, fra cui il celebre Martino
Spanzotti, mentre poco più di un secolo prima, a fine Trecento, vi ri-
siedeva un solo pittore, mastro Giovanni Jaquerio, il padre del più fa-
moso Giacomo.
Tale crescita economica, che si nutrì di più intensi rapporti commer-
ciali con Milano, Genova e Savona, e soprattutto di una più fitta immi-
grazione di piccoli mercanti e di manodopera specializzata, in parte pro-
veniente proprio dalla metropoli lombarda, fu comunque una conseguen-
za, più volte sottolineata nel volume, della centralità via via acquisita dalla
città in sede amministrativa. A caratterizzarla fu una spiccata articola-
zione produttiva che chiuse definitivamente con quell’orientamento a pri-
vilegiare nettamente la manifattura laniera che aveva caratterizzato gli
sviluppi del secondario torinese nel Trecento. Anche se la produzione di
pannilana si riprese, essa fu tutt’altro che dominante perché, accanto ad
essa, acquisirono un forte rilievo le lavorazioni della seta, delle armi, e per
un certo periodo della carta. A Torino guardavano ormai con attenzione,
investendovi cifre cospicue, società e uomini d’affari appartenenti a fa-
miglie di rilievo nel panorama economico-finanziario milanese e genove-
se. Tutto ciò mentre l’espansione urbanistica e la riplasmazione di case e
palazzi cittadini in sintonia con nuovi criteri estetici e con una coscienza
nuovissima del «decoro» del paesaggio urbano, sempre più radicata in un
gruppo dirigente fortemente rinnovato, favorivano lo sviluppo dell’edili-
zia e offrivano ulteriori possibilità di lavoro e di occupazione.
Anche nel campo più propriamente culturale e artistico l’acquisizio-
ne di nuove funzioni centrali fu di stimolo e si videro, evidenti, i segni
di una robusta ripresa connessa soprattutto a quei settori, come la cul-
tura giuridica, che più ricevevano alimento dalla presenza dell’Univer-
sità. Se, tuttavia, nel panorama della cultura giuridica dell’Umanesimo
maturo si individuano personalità di grande levatura, non altrettanto si
può dire degli altri intellettuali piemontesi, spesso indecisi fra atteggia-
menti cortigiani e una produzione letteraria d’ispirazione essenzialmente
libresca, attinta a modelli non sempre aggiornati o duraturi.
Assai più che nel Trecento, Torino e il Torinese si confermano dun-
que come un crocevia di esperienze culturali e di scambi di artisti, feli-
cemente documentati in questo volume da Andreina Griseri, intreccia-
ti dapprima, forse preferenzialmente, con la Savoia, la Borgogna, la Fran-
cia, le Fiandre, poi, fra Quattro e Cinquecento, più intensamente con
Roma
8
. Ne nasce, certo, un aggiornamento evidente di temi e tendenze
xxii
Rinaldo Comba
8
Cfr.
a. griseri
,
Le arti alla corte di Amedeo VIII
, e
Le svolte della cultura artistica
, in questo
stesso volume, pp. 659 sgg.


















