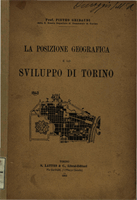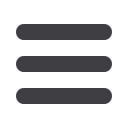
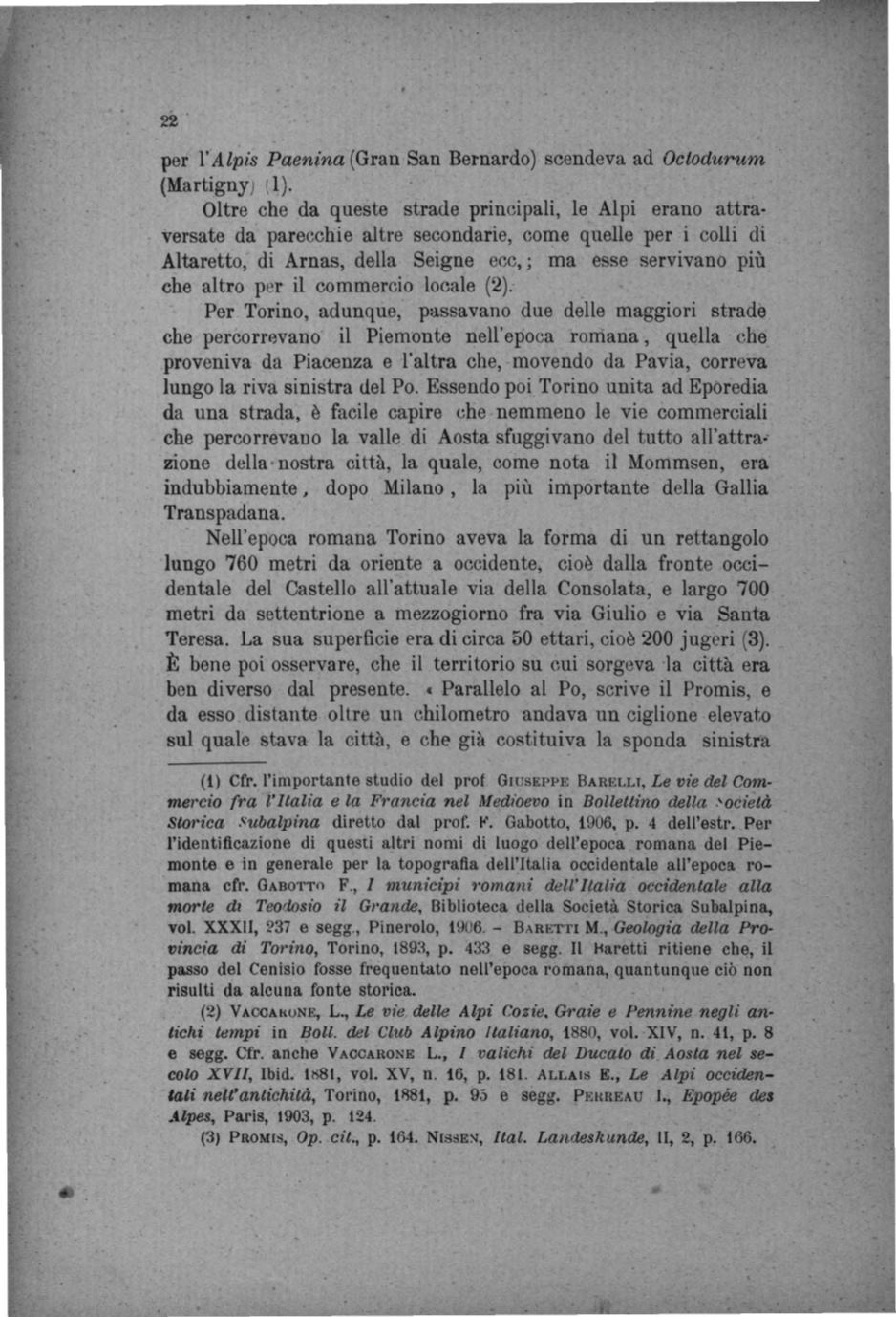
22
per
l'Alpis Paenina
(Gran San Bernardo) scendeva ad
Octodurum
{Martigny! (l ).
Oltre che da queste strade principali, le Alpi erano attra–
versate da parecchie altre secondari e, come quelle per i colli di
Altaretto, di Arnas, della Seigne ecc, ; ma esse servivano più
che altro per il commercio locale (2).
Per Torino, adunque, passavano due delle maggiori strade
che percorrevano il Piemonte nell'epoca romana , quella che
proveniva da Piacenza e l'altra che, movendo da Pavia, correva
lungo la riva sinistra del Po. Essendo poi Torino unita ad Eporedia
da una strada, è facile capire che nemmeno le vie commerciali
che percorrevano la valle di Aosta sfuggivano del tutto
all'attra–
zione della ' nostra città, la quale, come nota il Mommsen, era
indubbiamente, dopo Milano, la più importante della Gallia
Transpadana.
Nell'epoca romana Torino aveva la forma di un rettangolo
lungo 760 metri da oriente a occidente, cioè dalla front e occi–
dentale del Castello all'attuale via della Consolata, e largo 700
metri da settentrione a mezzogiorno fra via Giulio e via Santa
Teresa. La sua superficie era di circa 50 ettari, cioè 200 jugeri (3).
È
bene poi osservare, che il territorio su cui sorgeva
-la
città era
ben diverso dal presente. • Parallelo al Po, scrive il Promis, e
da esso distante oltre un chilometro andava un ciglione elevato
sul quale stava la città, e che già
costitui~a
la sponda sinistra
(t)
Cfr. l'importante studio del prot
GIUSEPPE BARELLI,
Le vie del Com–
mel'cio {l'a l'Italia e la Francia nel Medioevo
in
Bollettino della
società
Storica subalpina
diretto dal prof.
J<'.
Gabotto, t906, p. 4 dell'estro Per
l'identificazione di questi
altri
nomi di luogo dell'epoca romana del Pie–
monte e in generale per la topografia dell'Italia occidentale all'epoca ro–
mana cfr.
OABOTTO
F.,
l
municipi
romani
dell'Italia occidentale alla
morte dI
Teodosio
il Gl'ande,
Biblioteca della Società Storica Subalpina,
voI.
XXXII, 1?37
e segg.,
Pinerolo,
1906.
-
BARETTI
M.,
Geologia della Pro–
vincia di
Torino,
Torino,
I
89;{, p.
433
e
segg.
Il Haretti
ritiene che,
il
passo del Cenisio fosse
frequentato
nell'epoca romana, quantunque ciò non
risulti da alcuna fonte storica.
(2)
VACCAI<UNE,
L.,
Le vie. delle Alpi Cozie. Graie e
Pennine
negli an–
tichi tempi
in
Boli. del Club Alpino Italiano,
t880, vol.
XIV,
n.
41,
p.
a
e segg, Cfr. anche
V
ACCARONE
L.,
l
valichi del Ducato di Aosta nel se–
colo
XVII,
Ibid.
Ihal,
vol.
XV,
n. t6, p. t81.
ALLAIS
E.,
Le Alpi
occiden–
tati nell'antichità,
Toi-ino,
tflat,
p.
95 e
segg.
PEHREAU
I.,
Epopée
del
.Upes,
Paris,
1903,
p.
124.
(3)
PROMIS,
Op.
cit.;
p.
t64.
NISSE~,
itat.
Laruieskunde,
II, 2,
p.
166.