
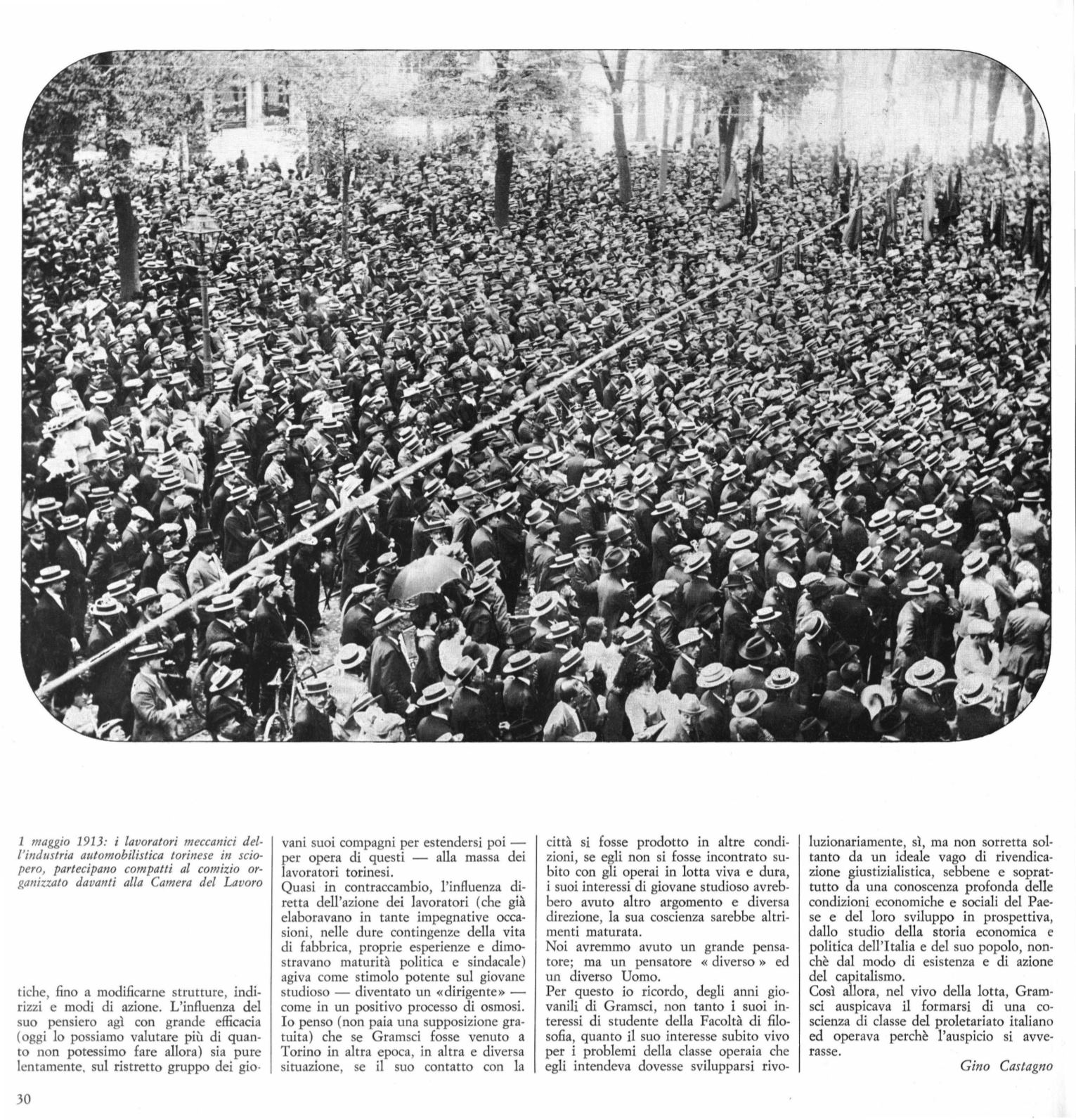
1 maggio
1913:
i lavoratori meccanici del–
l'industria automobilistica torinese in scio–
pero, partecipano compatti al comizio or–
ganizzato davanti alla Camera del Lavoro
tiche, fino a modifìcarne strutture, indi–
rizzi e modi di azione. L'influenza del
suo pensiero agì con grande efficacia
(oggi lo possiamo valutare più di quan–
to non potessimo fare allora) sia pure
lentamente. sul ristretto gruppo dei gioo
30
vani suoi compagni per estendersi poi -
per opera di questi - alla massa dei
lavoratori torinesi.
Quasi in contraccambio, l'influenza di–
retta dell'azione dei lavoratori (che già
elaboravano in tante impegnative occa–
sioni, nelle dure contingenze della vita
di fabbrica, proprie esperienze e dimo–
stravano maturità politica e sindacale)
agiva come stimolo potente sul giovane
studioso - diventato un «dirigente» -
come in un positivo processo di osmosi.
lo penso (non paia una supposizione gra–
tuita) che se Gramsci fosse venuto a
Torino in altra epoca, in altra e diversa
situazione, se il suo contatto con la
città si fosse prodotto in altre condi–
zioni, se egli non si fosse incontrato su–
bito con gli operai in lotta viva e dura,
i suoi interessi di giovane studioso avreb–
bero avuto altro argomento e diversa
direzione, la sua coscienza sarebbe altri–
menti maturata.
Noi avremmo avuto un grande pensa–
tore; ma un pensatore «diverso» ed
un diverso Uomo.
Per questo io ricordo, degli anni gio–
vanili di Gramsci, non tanto i suoi in–
teressi di studente della Facoltà di filo–
sofia, quanto
il
suo interesse subito vivo
per i problemi della classe operaia che
egli intendeva dovesse svilupparsi rivo-
luzionariamente, sì, ma non sorretta sol–
tanto da un ideale vago di rivendica–
zione giustizialistica, sebbene e soprat–
tutto da una conoscenza profonda delle
condizioni economiche e sociali del Pae–
se e del loro sviluppo in prospettiva,
dallo studio della storia economica e
politica dell'Italia e del suo popolo, non–
chè dal modo di esistenza e di azione
del capitalismo.
Così allora, nel vivo della lotta, Gram–
sci auspicava
il
formarsi
di
una co–
scienza di classe del proletariato italiano
ed operava perchè l'auspicio si avve-
rasse.
Gino Castagno


















