
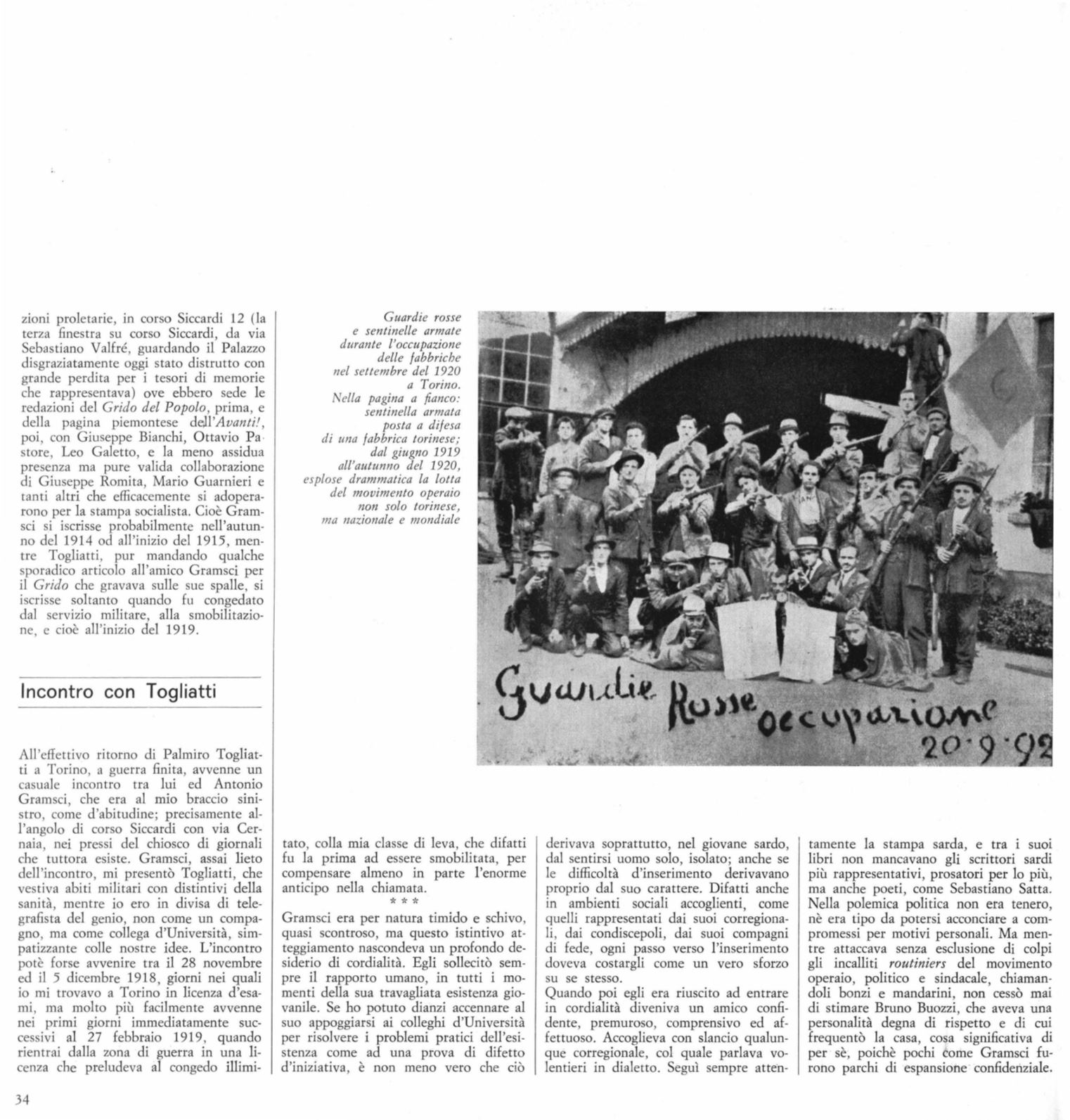
zioni proletarie, in corso Siccardi 12 (la
terza finestra su corso Siccardi, da via
Sebastiano Valfré, guardando il Palazzo
disgraziatamente oggi stato distrutto con
grande perdita per i tesori di memorie
che rappresentava) ove ebbero sede le
redazioni del
Grido del Popolo ,
prima, e
della pagina piemontese
deJl'Avanti!,
poi, con Giuseppe Bianchi, Ottavio Pa
store, Leo GaIetto, e la meno assidua
presenza ma pure valida collaborazione
di Giuseppe Romita, Mario Guarnieri e
tanti altri che efficacemente si adopera–
rono per la stampa socialista. Cioè Gram–
sci si iscrisse probabilmente nell'autun–
no del 1914 od all'inizio del 1915, men–
tre Togliatti, pur mandando qualche
sporadico articolo all'amico Gramsci per
il
Grido
che gravava sulle sue spalle, si
iscrisse soltanto quando fu congedato
dal servizio militare, alla smobilitazio–
ne, e cioè all'inizio del 1919.
Incontro con Togliatti
All 'effettivo ritorno di Palmiro Togliat–
ti a Torino, a guerra finita, avvenne un
casuale incontro tra lui ed Antonio
Gramsci, che era al mio braccio sini–
stro, come d'abitudine; precisamente al–
l'angolo di corso Siccardi con via Cer–
naia , nei pressi del chiosco di giornali
che tuttora esiste. Gramsci, assai lieto
dell'incontro, mi presentò Togliatti, che
vestiva abiti militari con distintivi della
sanità, mentre io ero in divisa di tele–
grafista del genio, non come un compa–
gno, ma come collega d'Università, sim–
patizzante colle nostre idee. L'incontro
potè forse avvenire tra il 28 novembre
ed
il
5 dicembre 1918, giorni nei quali
io mi trovavo a Torino in licenza d'esa–
mi , ma molto più facilmente avvenne
nei primi giorni immediatamente suc–
cessivi al 27 febbraio 1919, quando
rientrai dalla zona di guerra in una li–
cenza che preludeva àl congedo illimi-
34
Guardie rosse
e sentinelle armate
durante l'occupazione
delle fabbriche
nel settembre del 1920
a Torino.
Nella pagina a fianco:
sentinella armata
posta a difesa
di una fabbrica torinese;
dal giugno 1919
all'autunno del 1920,
esplose drammatica la lotta
del movimento operaio
non solo torinese,
ma nazionale e mondiale
tato, colla mia classe di leva, che difatti
fu la prima ad essere smobilitata, per
compensare almeno in parte l'enorme
anticipo nella chiamata.
* ,', .'.
Gramsci era per natura timido e schivo,
quasi scontroso, ma questo istintivo at–
teggiamento nascondeva un profondo de–
siderio di cordialità. Egli sollecitò sem–
pre il rapporto umano , in tutti i mo–
menti della sua travagliata esistenza gio–
vanile. Se ho potuto dianzi accennare al
suo appoggiarsi ai colleghi d 'Università
per risolvere i problemi pratici dell'esi–
stenza come ad una prova di difetto
d'iniziativa , è non meno vero che ciò
derivava soprattutto, nel giovane sardo,
dal sentirsi uomo solo, isolato; anche se
le difficoltà d 'inserimento derivavano
proprio dal suo carattere. Difatti anche
in ambienti sociali accoglienti, come
quelli rappresentati dai suoi corregiona–
li, dai condiscepoli, dai suoi compagni
di fede, ogni passo verso l'inserimento
doveva costargli come un vero sforzo
su se stesso.
Quando poi egli era riuscito ad entrare
in cordialità diveniva un amico confi–
dente, premuroso, comprensivo ed af–
fettuoso. Accoglieva con slancio qualun–
que corregionale, col quale parlava vo–
lentieri in dialetto. Seguì sempre atten-
tamente la stampa sarda, e tra i suoi
libri non mancavano gli scrittori sardi
più rappresentativi, prosatori per lo più,
ma anche poeti, come Sebastiano Satta.
Nella polemica politica non era tenero,
nè era tipo da potersi acconciare a com–
promessi per motivi personali. Ma men–
tre attaccava senza esclusione di colpi
gli incalliti
routiniers
del movimento
operaio, politico e sindacale, chiaman–
doli bonzi e mandarini, non cessò mai
di stimare Bruno Buozzi, che aveva una
personalità degna di rispetto e di cui
frequentò la casa, cosa significativa di
per sè; poichè pochi come Gramsci fu–
roho parchi di espansione confidenziale.


















