
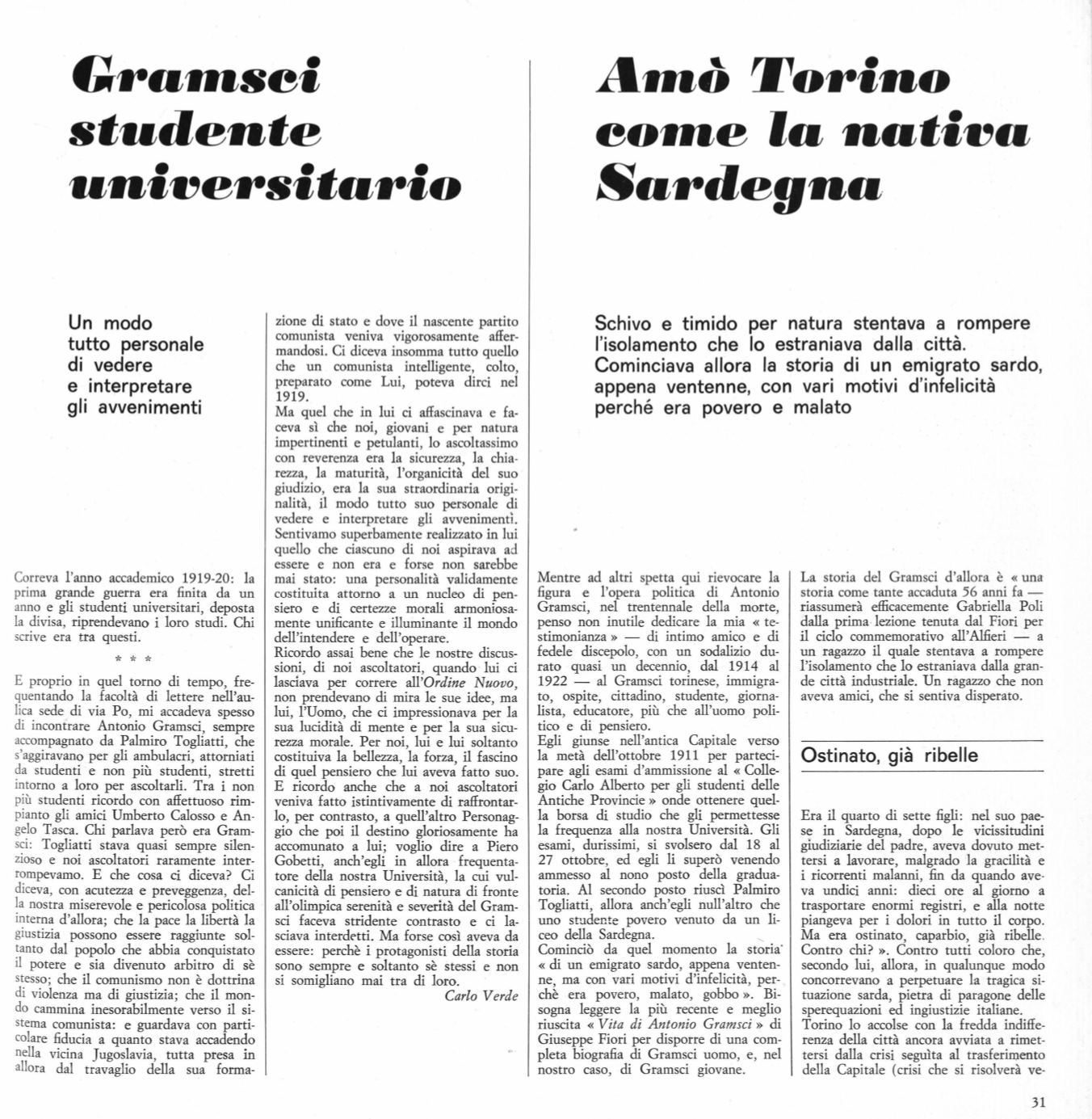
GraDIsci
studente
uni"ersitorio
Un modo
tutto personale
di vedere
e interpretare
gli avvenimenti
Correva l'anno accademico 1919-20: la
prima grande guerra era finita da un
anno e gli studenti universitari, deposta
la divisa, riprendevano i loro studi. Chi
scrive era tra questi.
E
proprio in quel torno di tempo, fre–
quentando
la
facoltà di lettere nell'au–
lica sede di via Po, mi accadeva spesso
di incontrare Antonio Gramsci, sempre
accompagnato da Palmiro Togliatti, che
s'aggiravano per gli ambulacri, attorniati
da studenti e non più studenti, stretti
intorno a loro per ascoltarli. Tra i non
più studenti ricordo con affettuoso rim–
pianto gli amici Umberto Calosso e An–
gelo Tasca. Chi parlava però era Gram–
sci: Togliatti stava quasi sempre silen–
zioso e noi ascoltatori raramente inter–
rompevamo. E che cosa ci diceva?
Ci
diceva, con acutezza e preveggenza, del–
la nostra miserevole e pericolosa politica
interna d'allora; che la pace la libertà la
giustizia possono essere raggiunte sol–
tanto dal popolo che abbia conquistato
il potere e sia divenuto arbitro di sè
stesso; che il comunismo non è dottrina
di violenza ma di giustizia; che il mon–
do cammina inesorabilmente verso il si–
stema comunista: e guardava con parti–
colare fiducia a quanto stava accadendo
nella vicina Jugoslavia, tutta presa in
allora dal travaglio della sua forma-
zione di stato e dove il nascente partito
comunista veniva vigorosamente affer–
mandosi.
Ci
diceva insomma tutto quello
che un comunista intelligente, colto,
preparato come Lui, poteva dirci nel
1919.
Ma quel che in lui ci affascinava e fa–
ceva sì che noi, giovani e per natura
impertinenti e petulanti, lo ascoltassimo
con reverenza era la sicurezza, la chia–
rezza, la maturità, l'organicità del suo
giudizio, era la sua straordinaria origi–
nalità,
il
modo tutto suo personale di
vedere e interpretare gli avvenimentÌ.
Sentivamo superbamente realizzato in lui
quello che ciascuno di noi aspirava ad
essere e non era e forse non sarebbe
mai stato: una personalità validamente
costituita attorno a un nucleo di pen–
siero e di certezze morali armoniosa–
mente unificante e illuminante
il
mondo
dell'intendere e dell'operare.
Ricordo assai bene che le nostre discus–
sioni, di noi ascoltatori, quando ' lui ci
lasciava per correre
all'Ordine Nuovo,
non prendevano di mira le sue idee, ma
lui, l'Uomo, che ci impressionava per la
sua lucidità di mente e per la sua sicu–
rezza morale. Per noi, lui e lui soltanto
costituiva la bellezza, la forza,
il
fascino
di quel pensiero che lui aveva fatto suo.
E ricordo anche che a noi ascoltatori
veniva fatto istintivamente di raffrontar–
lo, per contrasto, a quell'altro Personag–
gio che poi
il
destino gloriosamente ha
accomunato a lui; voglio dire a Piero
Gobetti, anch'egli in allora frequenta–
tore della nostra Università, la cui vul–
canicità di pensiero e di natura di fronte
all'olimpica serenità e severità del Gram–
sci faceva stridente contrasto e ci la–
sciava interdetti. Ma forse cosi aveva da
essere: perchè i protagonisti della storia
sono sempre e soltanto sè stessi e non
si somigliano mai tra di loro.
Carlo Verde
ADlò
Torino
cODle 'o noti"o
Sardegna
Schivo e timido per natura stentava a rompere
!'isolamento che lo estraniava dalla città.
Cominciava allora la storia di un emigrato sardo,
appena ventenne, con vari motivi d'infelicità
perché era povero e malato
Mentre ad altri spetta qui rievocare la
figura e l'opera politica di Antonio
Gramsci, nel trentennale della morte,
penso non inutile dedicare la mia «te–
stimonianza » - di intimo amico e di
fedele discepolo, con un sodalizio du–
rato quasi un decennio, dal 1914 al
1922 - al Gramsci torinese, immigra–
to, ospite, cittadino, studente, giorna–
lista, educatore, più che all'uomo poli–
tico e di pensiero.
Egli giunse nell'antica Capitale verso
la metà dell'ottobre 1911 per parteci–
pare agli esami d'ammissione al « Colle–
gio Carlo Alberto per gli studenti delle
Antiche Provincie» onde ottenere quel–
la borsa di studio che gli permettesse
la frequenza alla nostra Università. Gli
esami, durissimi, si svolsero dal 18 al
27 ottobre, ed egli
li
superò venendo
ammesso al nono posto della gradua–
toria. Al secondo posto riuscì Palmiro
Togliatti, allora anch'egli null'altro che
uno studente povero venuto da un
li-
ceo della Sardegna.
--..
Cominciò da quel momento la storia'
« di un emigrato sardo, appena venten–
ne, ma con vari motivi d'infelicità, per–
chè era povero, malato, gobbo ». Bi–
sogna leggere la più recente e meglio
riuscita
«Vita di Antonio Gramsci»
di
Giuseppe Fiori per disporre di una com–
pleta biografia di Gramsci uomo, e, nel
nostro caso, di Gramsci giovane.
La storia del Gramsci d'allora è «una
storia come tante accaduta 56 anni fa -
riassumerà efficacemente Gabriella Poli
dalla prima· lezione tenuta dal Fiori per
il
ciclo commemorativo all'Alfieri - a
un ragazzo
il
quale stentava a rompere
l'isolamento che lo estraniava dalla gran–
de città industriale. Un ragazzo che non
aveva amici, che si sentiva disperato.
Ostinato, già ribelle
Era
il
quarto di sette figli: nel suo pae–
se in Sardegna, dopo le vicissitudini
giudiziarie del padre, aveva dovuto met–
tersi a lavorare, malgrado la gracilità e
i ricorrenti malanni, fin da quando ave–
va undici anni: dieci ore al giorno a
trasportare enormi registri, e alla notte
piangeva per i dolori in tutto
il
corpo.
Ma era ostinato, caparbio, già ribelle .
Contro chi?
».
Contro tutti coloro che,
secondo lui, allora, in qualunque modo
concorrevano a perpetuare la tragica si–
tuazione sarda, pietra di paragone delle
sperequazioni ed ingiustizie italiane.
Torino lo accolse con la fredda indiffe–
renza della città ancora avviata a rimet–
tersi dalla crisi seguita al trasferimento
della Capitale (crisi che si risolverà ve-
31


















