
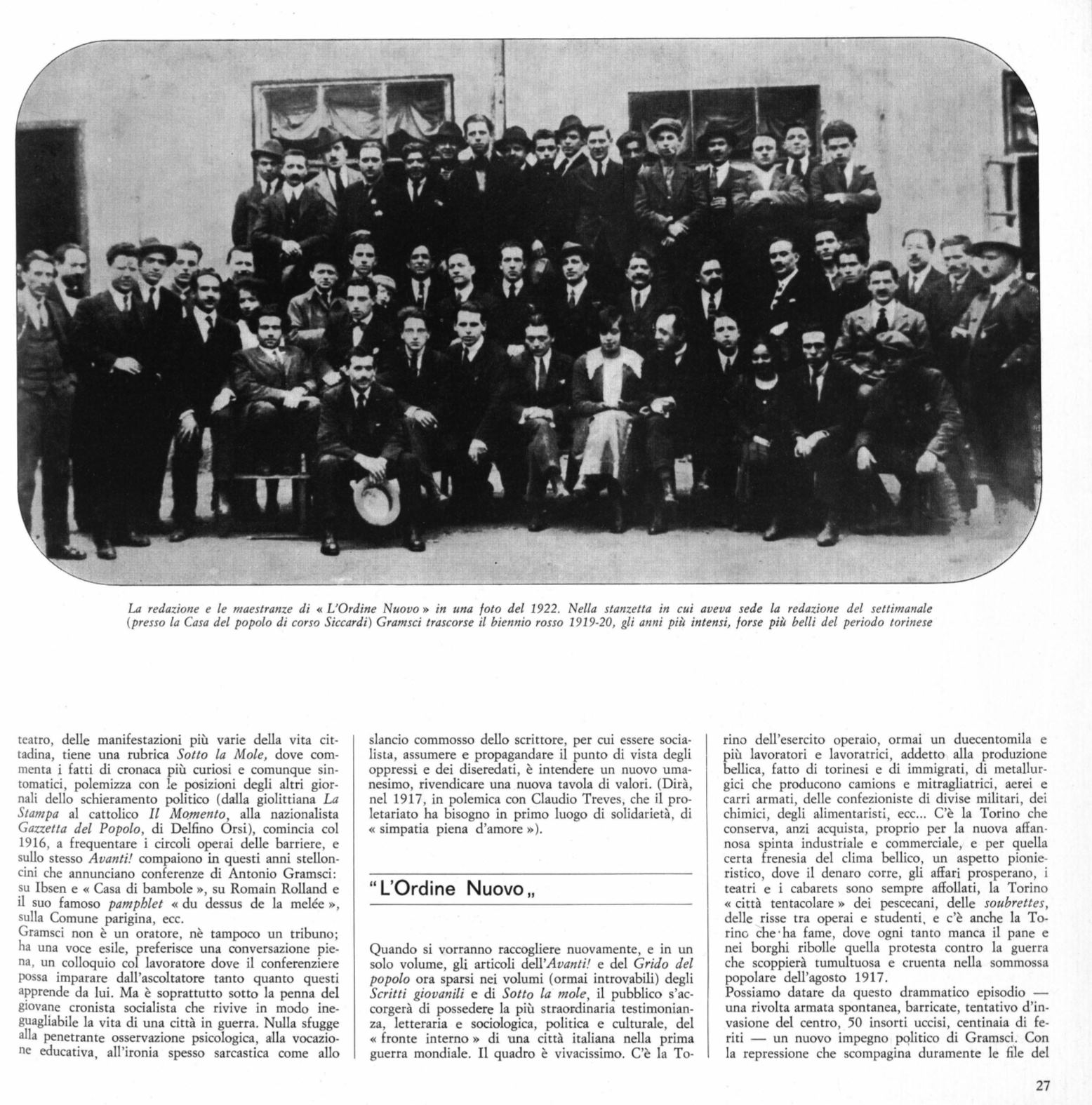
La redazione e le maestranze di «L'Ordine Nuovo» in una foto del
1922.
Nella stanzetta in cui aveva sede la redazione del settimanale
(presso la Casa del popolo di corso Siccardi) Gramsci trascorse il biennio rosso 1919-20, gli anni più intensi, forse più belli del periodo torinese
teatro, delle manifestazioni plU varie della vita cit–
tadina, tiene una rubrica
Sotto la Mole,
dove com–
menta
i
fatti di cronaca più curiosi e comunque sin–
tomatici, polemizza con le posizioni degli altri gior–
nali dello schieramento politico (dalla giolittiana
La
Stampa
al cattolico
Il Mo.mento,
alla nazionalista
Gazzetta del Popolo,
di Delfino Orsi), comincia col
1916, a frequentare i circoli operai delle barriere, e
sullo stesso
Avanti.'
compaiono
in
questi anni stellon–
cini che annunciano conferenze di Antonio Gramsci:
su Ibsen e « Casa di bambole
»,
su Romain Rolland e
il suo famoso
pamphlet
«du dessus de la melée
»,
sulla Comune parigina, ecc.
Gramsci non è un oratore, nè tampoco un tribuno;
ha una VOce esile, preferisce una conversazione pie–
na, un colloquio col lavoratore dove il conferenziere
possa imparare dall'ascoltatore tanto quanto questi
apprende da lui. Ma è soprattutto sotto la penna del
giovane cronista socialista che rivive in modo ine–
guagliabile la vita di una città in guerra. Nulla sfugge
alla penetrante osservazione psicologica, alla vocazio–
ne educativa, all'ironia spesso sarcastica come allo
slancio commosso dello scrittore, per cui essere socia–
lista, assumere e propagandare il punto di vista degli
oppressi e dei diseredati, è intendere un nuovo uma–
nesimo, rivendicare una .nuova tavola di valori. (Dirà,
nel 1917, in polemica con Claudio Treves, che
il
pro–
letariato ha bisogno in primo luogo di solidarietà, di
« simpatia piena d'amore»).
"L'Ordine Nuovo"
Quando si vorranno raccogliere nuovamente, e in un
solo volume, gli articoli
dell'Avanti.'
e del
Grido del
popolo
ora sparsi nei volumi (ormai introvabili) degli
Scritti giovanili
e di
Sotto la mole,
il
pubblico s'ac–
corgerà
di
possedere la più straordinaria testimonian–
za, letteraria e sociologica, politica e culturale, del
«fronte interno» di una città italiana nella prima
guerra mondiale. Il quadro è vivacissimo. C'è la To-
rino dell'esercito operaio, ormai un duecentomila e
più lavoratori e lavoratrici, addetto alla produzione
bellica, fatto di torinesi e di immigrati, di metallur–
gici che producono camions e mitragliatrici, aerei e
carri armati, delle confezioniste di divise militari, dei
chimici, degli alimentaristi, ecc... C'è la Torino che
conserva, anzi acquista, proprio per la nuova affan–
nosa spinta industriale e commerciale, e per quella
certa frenesia del clima bellico, un aspetto pionie–
ristico, dove il denaro corre, gli affari prosperano, i
teatri e i cabarets sono sempre affollati, la Torino
«città tentacolare» dei pescecani, delle
soubrettes,
delle risse tra operai e studenti, e c'è anche la To–
rino Che ' ha fame, dove ogni tanto manca
il
pane e
nei borghi riboHe quella protesta contro la guerra
che scoppierà tumultuosa e cruenta nella sommossa
popolare dell'agosto 1917.
Possiamo datare da questo drammatico episodio -
una rivolta armata spontanea, barricate, tentativo d'in–
vasione del centro, 50 insorti uccisi, centinaia di fe–
riti - un nuovo impegno pqlitico di Gramsci. Con
la repressione che scompagina duramente le file del
27


















