
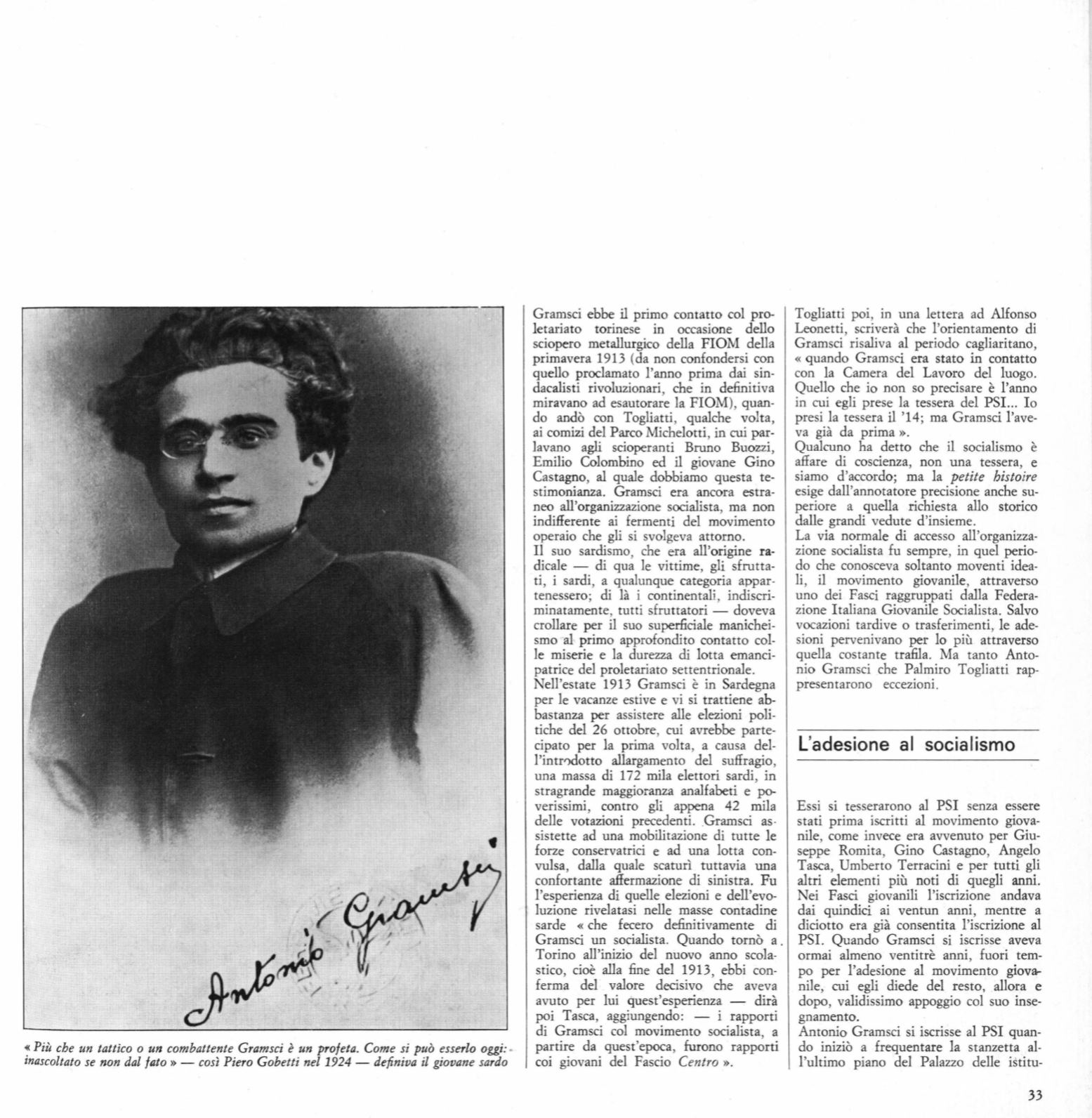
~
Più che un tattico o un combattente Gramsci
è
un profeta. Come si può esserlo oggi: .
inascoltato se non dal fato»
-
così Piero Gobetti nel
1924 -
definiva il giovane sardo
Gramsci ebbe
il
primo contatto col pro–
letariato torinese in occasione dello
sciopero metallurgico della FIOM della
primavera 1913 (da non confondersi con
quello proclamato
l'anno
prima dai sin–
dacalisti rivoluzionari, che in definitiva
miravano ad esautorare la FIOM), quan–
do andò con Togliatti , qualche volta,
ai comizi del Parco Michelotti, in
cui
par–
lavano agli scioperanti Bruno Buozzi,
Emilio Colombino ed
il
giovane Gino
Castagno, al quale dobbiamo questa te–
stimonianza. Gramsci era ancora estra–
neo all'organizzazione socialista, ma non
indifferente ai fermenti del movimento
operaio che gli si svolgeva attorno.
Il suo sardismo, che era all'origine ra–
dicale - di qua le vittime, gli sfrutta–
ti, i sardi, a qualunque categoria apparo
tenessero; di là i continentali , indiscri–
minatamente, tutti sfruttatori - doveva
crollare per il suo superficiale manichei–
smo
'al
primo approfondito contatto col–
le miserie e la durezza di lotta emanci–
patrice del proletariato settentrionale.
Nell'estate 1913 Gramsci è in Sardegna
per le vacanze estive e vi si trattiene ab–
bastanza per assistere alle elezioni poli–
tiche del 26 ottobre, cui avrebbe parte–
cipato per la prima volta, a causa del–
l'intr'Xlotto allargamento del suffragio,
una massa di 172 mila elettori sardi, in
stragrande maggioranza analfabeti e po–
verissimi, contro gli appena 42 mila
delle votazioni precedenti. Gramsci as·
sistette ad una mobilitazione di tutte le
forze conservatrici e ad una lotta con–
vulsa, dalla quale scaturì tuttavia una
confortante affermazione di sinistra. Fu
l'esperienza di quelle elezioni e dell'evo–
luzione rivelatasi nelle masse contadine
sarde «che fecero definitivamente di
Gramsci un socialista . Quando tornò a.
Torino all'inizio del nuovo anno scola,
stico, cioè alla fine del 1913, ebbi con–
ferma del valore decisivo che aveva
avuto per lui quest'esperienza - dirà
poi Tasca, aggiungendo: - i rapporti
di Gramsci col movimento socialista, a
partire da quest'epoca, furono rapporti
coi giovani del Fascio
Centro
».
Togliatti poi, in una lettera ad Alfonso
Leonetti, scriverà che l'orientamento di
Gramsci risaliva al periodo cagliaritano,
« quando Gramsci era stato in contatto
con la Camera del Lavoro del luogo.
Quello che io non so precisare è l'anno
in cui egli prese la tessera del PSI... lo
presi la tessera
il
'14; ma Gramsci l'ave–
va già da prima
».
Qualcuno ha detto che
il
socialismo è
affare di coscienza, non una tessera, e
siamo d'accordo; ma la
petite histoire
esige dall'annotatore precisione anche su–
periore a quella richiesta allo storico
dalle grandi vedute d'insieme.
La via normale di accesso all'organizza–
zione socialista fu sempre, in quel perio–
do che conosceva soltanto moventi idea–
li, il movimento giovanile, attraverso
uno dei Fasci raggruppati dalla Federa–
zione Italiana Giovanile Socialista. Salvo
vocazioni tardive o trasferimenti, le ade–
sioni pervenivano per lo più attraverso
quella costante trafila. Ma tanto Anto–
nio Gramsci che Palmiro Togliatti rap–
presentarono eccezioni.
l 'adesione al socialismo
Essi si tesserarono al PSI senza essere
stati prima iscritti al movimento giova–
nile, come invece era avvenuto per Giu–
seppe Romita, Gino Castagno, Angelo
Tasca, Umberto Terracini e per tutti gli
altri elementi più noti di quegli anni.
Nei Fasci giovanili l'iscrizione andava
dai quindici ai ventun anni, mentre a
diciotto era già consentita l'iscrizione al
PSI. Quando Gramsci si iscrisse aveva
ormai almeno ventitrè anni , fuori tem–
po per l'adesione al movimento giova–
nile, cui egli diede del resto, allora e
dopo, validissimo appoggio col suo inse–
gnamento.
Antonio Gramsci si iscrisse al PSI quan–
do iniziò a frequentare la stanzetta al–
l'ultimo piano del Palazzo delle istitu-
33


















