
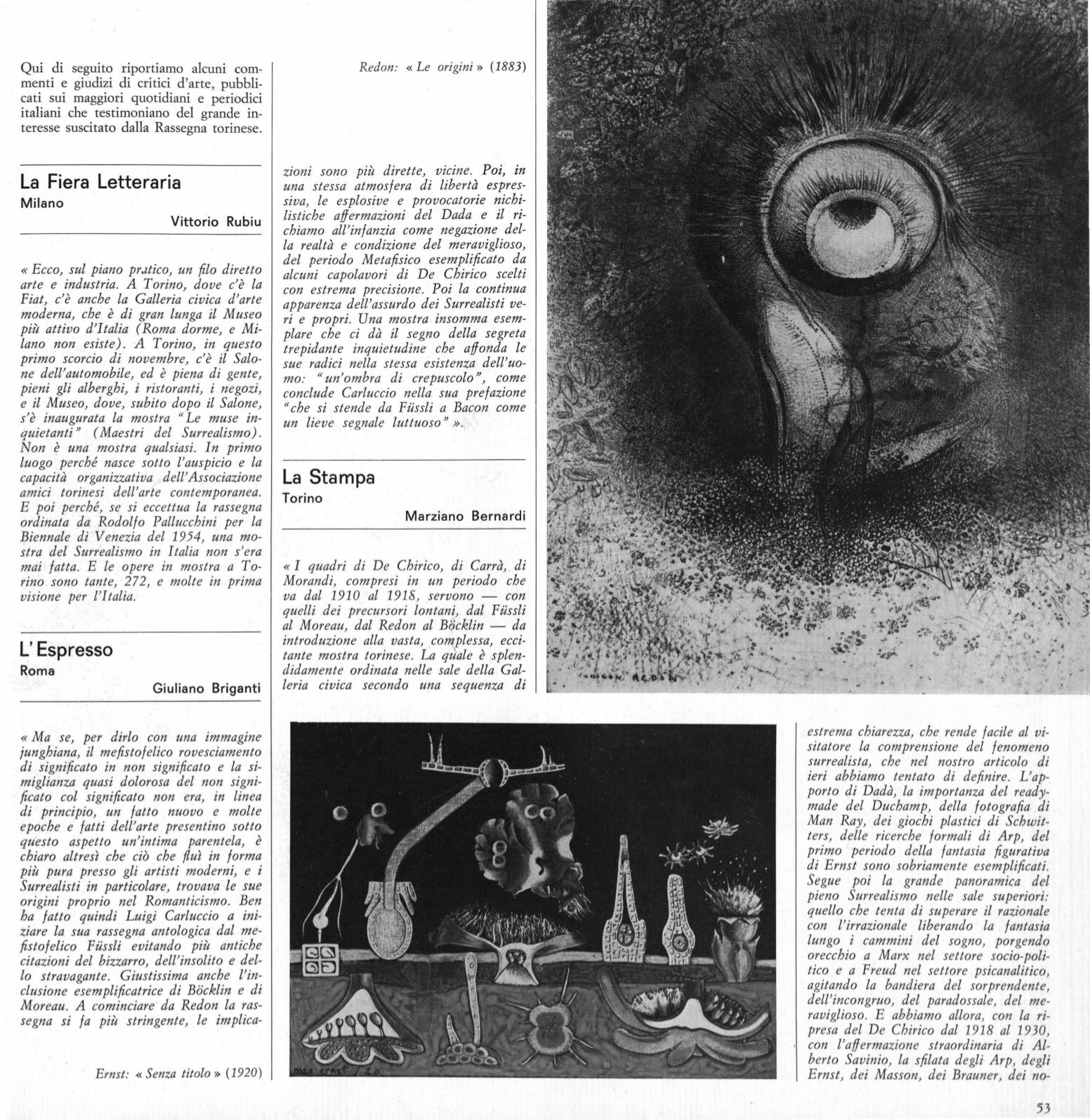
Qui di seguito riportiamo alcuni com–
menti e giudizi di critici d'arte, pubbli–
cati sui maggiori quotidiani e periodici
italiani che testimoniano del grande in–
teresse suscitato dalla Rassegna torinese.
La Fiera Letteraria
Milano
Vittorio Rubiu
«
Ecco, sul piano pr.ltico, un filo diretto
arte e industria. A Torino, dove c'è la
Fiat, c'è anche la Galleria civica d'arte
moderna, che è di gran lunga il Museo
più attivo d'Italia (Roma dorme, e Mi–
lano non esiste). A Torino, in questo
primo scorcio di novembre, c'è il Salo–
ne dell'automobile, ed è piena di gente,
pieni gli alberghi, i ristoranti, i negozi,
e il Museo, dove, subito dopo il Salone,
s'è inaugurata la mostra (( Le muse in–
quietanti " (Maestri del Surrealismo) .
Non è una mostra qualsiasi. In primo
luogo perché nasce sotto l'auspicio e la
capacità organizzativa dell'Associazione
amici torinesi dell'arte contemporanea.
E
poi perché, se si eccettua la rassegna
ordinata da Rodolfo Pallucchini per la
Biennale di Venezia del
1954,
una mo–
stra del Surrealismo in Italia non s'era
mai fatta.
E
le opere in mostra a To–
rino sono tante,
272,
e molte in prima
visione per l'Italia.
L'Espresso
Roma
Giuliano Briganti
« Ma se, per dirlo con una immagine
junghiana, il mefistofelico rovesciamento
di significato in non significato e la si–
miglianza quasi dolorosa del non signi–
ficato col significato non era, in linea
di principio, un fatto nuovo e molte
epoche e fatti dell'arte presentino sotto
quésto aspetto un'intima parentela, è
chiaro altresì che ciò che fluì in forma
più pura presso gli artisti moderni, e i
Surrealisti in particolare, trovav(l le sue
origini proprio nel Romanticismo. Ben
ha fatto quindi Luigi Carluccio a ini–
ziare la sua rassegna antologica dal me–
fistofelico Fiissli evitando più antiche
citazioni del bizzarro, dell'insolito e del–
lo stravagante. Giustissima anche l'in–
clusione esemplificatrice di Bocklin e di
Moreau . A cominciare da Redon la ras–
segna si fa più stringente, le implica-
Ernst: «Senza titolo»
(1920)
Redon: «Le origini»
(1883)
zioni sono più dirette, vzczne. Poi, in
una stessa atmosfera di libertà espres–
siva, le esplosive e provocatorie nichi–
listiche affermazioni del Dada e il ri–
chiamo all'infanzia come negazione del–
la realtà e condizione del meraviglioso,
del periodo Metafisico esemplificato da
alcuni capolavori di De Chirico scelti
con estrema precisione. Poi la continua
apparenza dell'assurdo dei Surrealisti ve–
ri e propri. Una mostra insomma esem–
plare che ci dà il segno della segreta .
trepidante inquietudine che affonda le
sue radici nella stessa esistenza dell'uo–
mo:
((
un'ombra di crepuscolo", come
conclude Carluccio nella sua prefazione
((
che si stende da Fiissli a Bacon come
un lieve segnale luttuoso "
».
La Stampa
Torino
Marziano Bernardi
«I quadri di De Chirico, di Carrà, di
Morandi, compresi in un periodo che
va dal
1910
al
1918,
servono
-
con
quelli dei precursori lontani, dal Fiissli
al Moreau, dal Redon al Bjjcklin
-
da
introduzione alla vasta,
co~plessa,
ecci–
tante mostra torinese. La qdale è splen–
didamente ordinata nelle sale della Gal–
leria civica secondo una sequenza di
estrema chiarezza, che rende facile al vi–
sitatore la comprensione del fenomeno
surrealista, che nel nostro articolo di
ieri abbiamo tentato di definire. L'ap–
porto di Dadà, la importanza del ready–
made del Duchamp, della fotografia di
Man Ray, dei giochi plastici di Schwit–
ters, delle ricerche formali di Arp, del
primo periodo della fantasia figurativa
di Ernst sono sobriamente esemplificati.
Segue poi la grande panoramica del
pieno Surrealismo nelle sale superiori:
quello che tenta di superare il razionale
con l'irrazionale liberando la fantasia
lungo i cammini del sogno, porgendo
orecchio a Marx nel settore socio-poli–
tico e a Freud nel settore psicanalitico,
agitando la bandiera del sorprendente,
dell'incongruo, del paradossale, del me–
raviglioso.
E
abbiamo allora, con la ri–
presa del De Chirico dal
1918
al
1930,
, con l'affermazione straordinaria di Al–
berto Savinio, la sfilata degli Arp, degli
Ernst, dei Masson, dei Brauner, dei no-
53


















