
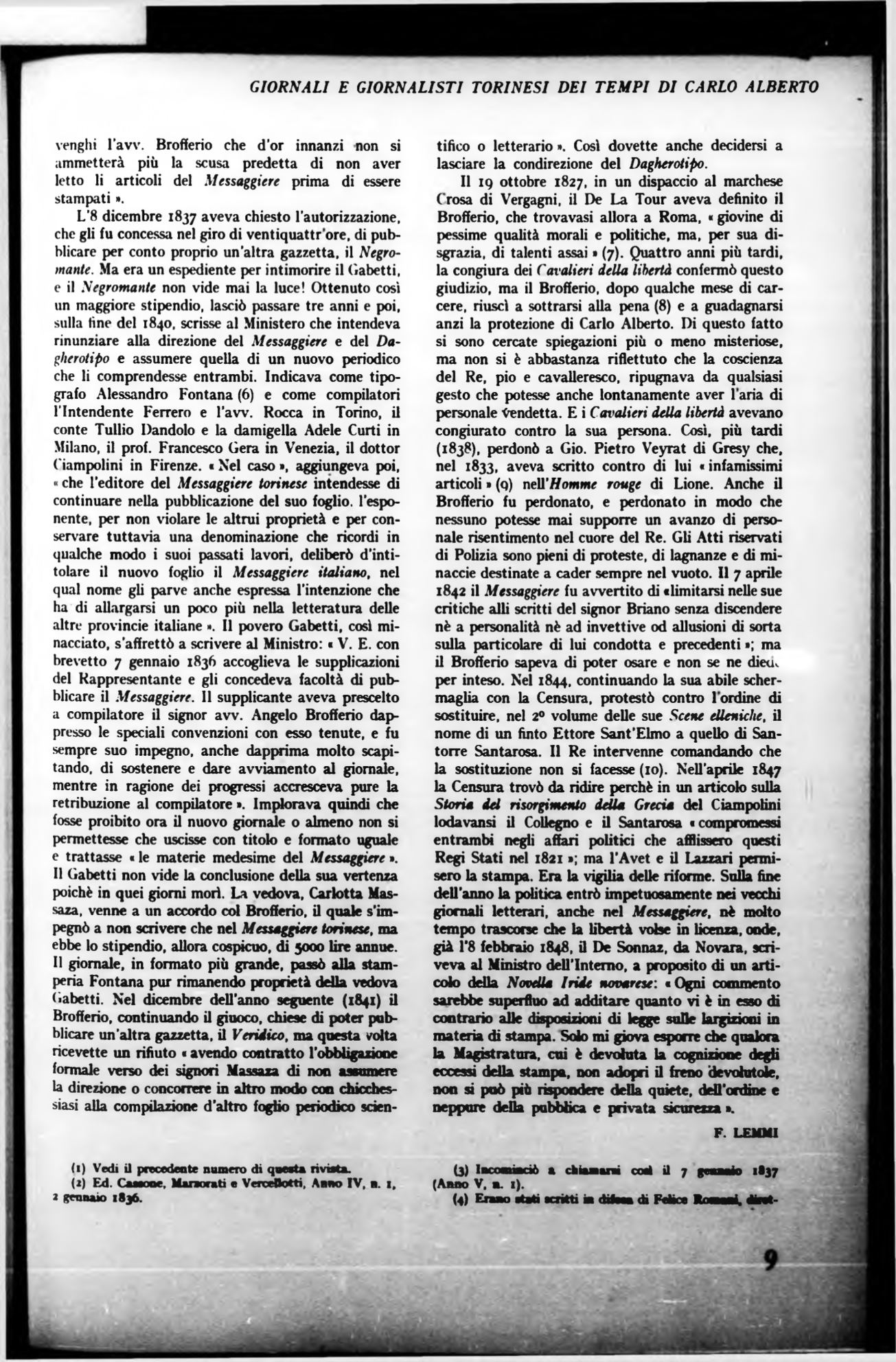
GIORNALI E GIORNAL I ST I TORINES I DE I T EM P I D I CARLO ALBERTO
venghi l'avv. Brofferio che d ’or innanzi non si
ammetterà più la scusa predetta di non aver
letto li articoli del
Messaggiere
prima di essere
stampati ».
L ’8 dicembre 1837 aveva chiesto l’autorizzazione,
che gli fu concessa nel giro di ventiquattrore, di pub
blicare per conto proprio un’altra gazzetta, il
Negro
mante.
Ma era un espediente per intimorire il Gabetti,
e il
Negromante
non vide mai la luce! Ottenuto così
un maggiore stipendio, lasciò passare tre anni e poi,
sulla fine del 1840, scrisse al Ministero che intendeva
rinunziare alla direzione del
Messaggiere
e del
Da-
gherotipo
e assumere quella di un nuovo periodico
che li comprendesse entrambi. Indicava come tipo
grafo Alessandro Fontana (6) e come compilatori
l’intendente Ferrerò e l’aw . Rocca in Torino, il
conte Tullio Dandolo e la damigella Adele Curti in
Milano, il prof. Francesco Gera in Venezia, il dottor
Ciampolini in Firenze. «Nel caso », aggiungeva poi,
«che l’editore del
Messaggiere torinese
intendesse di
continuare nella pubblicazione del suo foglio, l’espo
nente, per non violare le altrui proprietà e per con
servare tuttavia una denominazione che ricordi in
qualche modo i suoi passati lavori, deliberò d’inti
tolare il nuovo foglio il
Messaggiere italiano,
nel
qual nome gli parve anche espressa l’intenzione che
ha di allargarsi un poco più nella letteratura delle
altre provincie italiane ». Il povero Gabetti, così mi
nacciato, s ’affrettò a scrivere al Ministro: «V. E. con
brevetto 7 gennaio 1836 accoglieva le supplicazioni
del Rappresentante e gli concedeva facoltà di pub
blicare il
Messaggiere.
Il supplicante aveva prescelto
a compilatore il signor avv. Angelo Brofferio dap
presso le speciali convenzioni con esso tenute, e fu
sempre suo impegno, anche dapprima molto scapi
tando, di sostenere e dare avviamento al giornale,
mentre in ragione dei progressi accresceva pure la
retribuzione al compilatore ». Implorava quindi che
fosse proibito ora il nuovo giornale o almeno non si
permettesse che uscisse con titolo e formato uguale
e trattasse «le materie medesime del
Messaggiere
».
Il Gabetti non vide la conclusione della sua vertenza
poiché in quei giorni mori. La vedova, Carlotta Mas-
saza, venne a un accordo col Brofferio, il quale s’im
pegnò a non scrivere che nel
Messaggiere torinese,
ma
ebbe lo stipendio, allora cospicuo, di 5000 lire annue.
Il giornale, in formato più grande, passò alla stam
peria Fontana pur rimanendo proprietà della vedova
Gabetti. Nel dicembre dell’anno seguente (1841) il
Brofferio, continuando il giuoco, chiese di poter pub
blicare un’altra gazzetta, il
Veridico,
ma questa volta
ricevette un rifiuto «avendo contratto l’obbligazione
formale verso dei signori Massaza di non assumere
la direzione o concorrere in altro modo con chkches-
siasi alla compilazione d’altro foglio periodico scien
ti) Vedi il precedente numero di questa rivista.
(2) Ed. Cassone, Manorati e VerceOotti, Anno IV, n. 1,
2 gennaio 1836.
tifico o letterario ». Così dovette anche decidersi a
lasciare la condirezione del
Dagherotipo.
Il 19 ottobre 1827, in un dispaccio al marchese
( rosa di Vergagni, il De La Tour aveva definito il
Brofferio, che trovavasi allora a Roma, «giovine di
pessime qualità morali e politiche, ma, per sua di
sgrazia, di talenti assai »(7). Quattro anni più tardi,
la congiura dei
Cavalieri della libertà
confermò questo
giudizio, ma il Brofferio, dopo qualche mese di car
cere, riuscì a sottrarsi alla pena (8) e a guadagnarsi
anzi la protezione di Carlo Alberto. Di questo fatto
si sono cercate spiegazioni più o meno misteriose,
ma non si è abbastanza riflettuto che la coscienza
del Re, pio e cavalleresco, ripugnava da qualsiasi
gesto che potesse anche lontanamente aver 1 aria di
personale Vendetta. E i
Cavalieri della libertà
avevano
congiurato contro la sua persona. Così, più tardi
(1838), perdonò a Gio. Pietro Veyrat di Gresy che,
nel 1833, aveva scritto contro di lui «infamissimi
articoli »(q) nell
’Homme rouge
di Lione. Anche il
Brofferio fu perdonato, e perdonato in modo che
nessuno potesse mai supporre un avanzo di perso
nale risentimento nel cuore del Re. Gli Atti riservati
di Polizia sono pieni di proteste, di lagnanze e di mi-
naccie destinate a cader sempre nel vuoto. Il 7 aprile
1842 il
Messaggiere
fu avvertito di t limitarsi nelle sue
crìtiche alti scritti del signor Briano senza discendere
nè a personalità nè ad invettive od allusioni di sorta
sulla particolare di lui condotta e precedenti »; ma
il Brofferio sapeva di poter osare e non se ne dietu
per inteso. Nel 1844, continuando la sua abile scher
maglia con la Censura, protestò contro lordine di
sostituire, nel 2° volume delle sue
Scene elleniche,
il
nome di un finto Ettore Sant’Elmo a quello di San-
torre Santarosa. Il Re intervenne comandando che
la sostituzione non si facesse (10). Nell’aprile 1847
la Censura trovò da ridire perchè in un articolo sulla
Storia del risorgimento della Grecia
del Ciampolini
lodavansi il Collegno e il Santarosa «compromessi
entrambi negli affari politici che afflissero questi
Regi Stati nel 1821 »; ma l ’Avet e il Lazzari permi
sero la stampa. Era la vigilia delle riforme. Sulla fine
dell’anno la politica entrò impetuosamente nei vecchi
giornali letterari, anche nel
Messaggiere,
nè molto
tempo trascorse che la libertà volse in licenza, onde,
già l’8 febbraio 1848, il De Sonnaz, da Novara, scrì
veva al Ministro delTIntemo, a proposito di un arti
colo della
Novella Iride novarese
: «Ogni commento
sarebbe superfluo ad additare quanto vi è in esso di
contrario alle disposizioni di legge sulle largizioni in
materia di stampa. Solo mi giova esporre che qualora
la Magistratura, cui è devoluta la cognizione degli
eccessi della stampa, non adoprì il freno devolutole,
non si può più rispondere delia quiete, dell’ordine e
neppure della pubblica e privata sicurezza ».
F. LEMMI
(3) Incominciò
a
chiamarsi cosi
il 7 gennaio
1837
(Anno V, n. 1).
(4) Erano stati scritti in difesa di Felice Romani, dirat-


















