
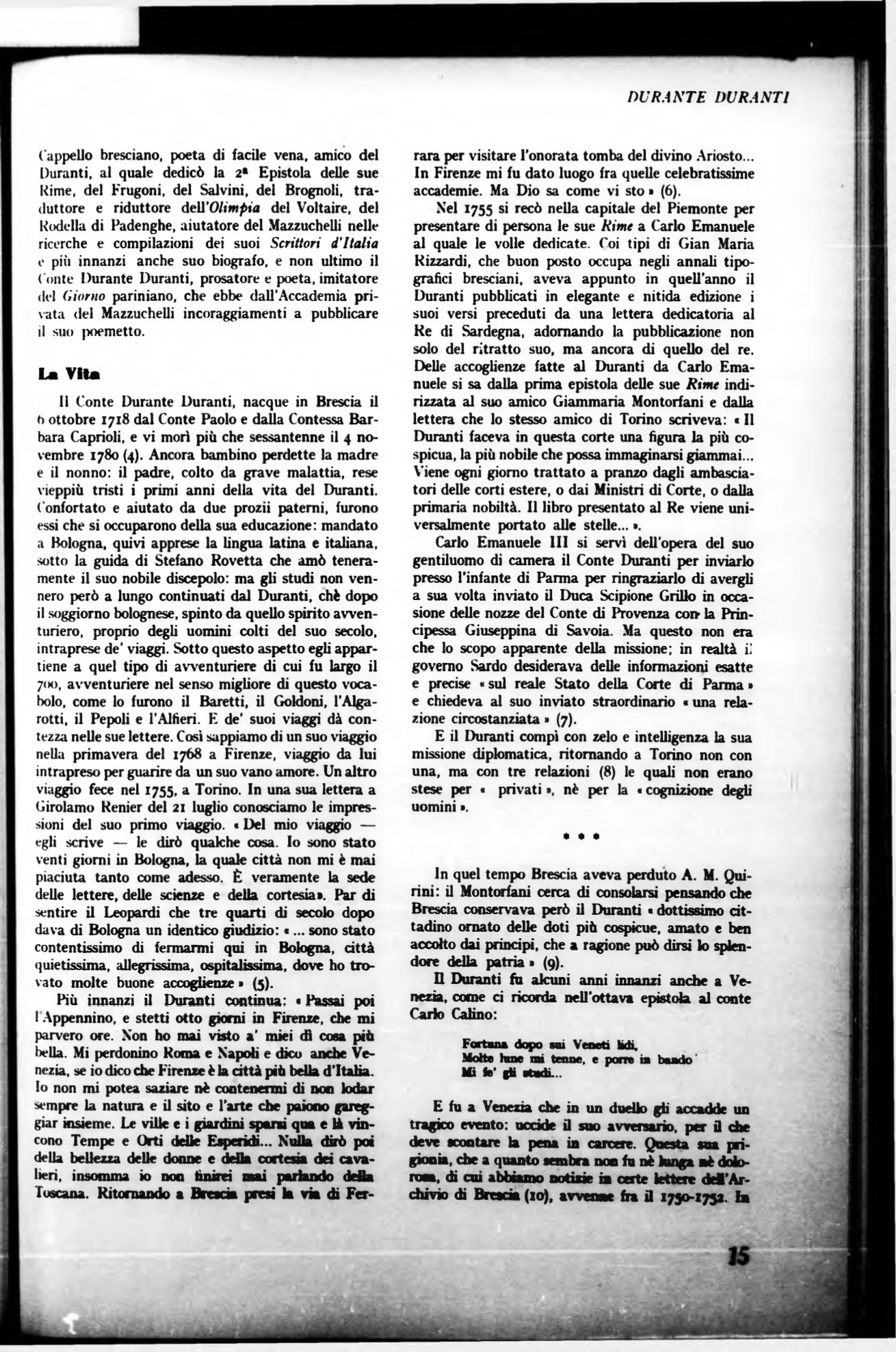
DURANTE DURANT I
Cappello bresciano, poeta di facile vena, amico del
Duranti, al quale dedicò la 2* Epistola delle sue
Rime, del Frugoni, del Salvini, del Brognoli, tra
duttore e riduttore
déU’Olimpia
del Voltaire, del
Kodella di Padenghe, aiutatore del Mazzuchelli nelle
ricerche e
compilazioni dei suoi
Scrittori d'Italia
e
più
innanzi anche suo biografo,
e
non ultimo il
Conte Durante Duranti, prosatore
e
poeta, imitatore
del
Giorno
pariniano, che ebbe dall’Accademia pri
vata
del
Mazzuchelli incoraggiamenti a pubblicare
il
suo poemetto.
L a V i t a
11
Conte Durante Duranti, nacque in Brescia il
b ottobre 1718 dal Conte Paolo e dalla Contessa Bar
bara Caprioli, e vi morì più che sessantenne il 4 no
vembre 1780 (4). Ancora bambino perdette la madre
e il nonno: il padre, colto da grave malattia, rese
vieppiù tristi i primi anni della vita del Duranti.
Confortato e aiutato da due prozìi patemi, furono
essi che si occuparono della sua educazione: mandato
a Bologna, quivi apprese la lingua latina e italiana,
sotto la guida di Stefano Rovetta che amò tenera
mente il suo nobile discepolo: ma gli studi non ven
nero però a lungo continuati dal Duranti, chè dopo
il soggiorno bolognese, spinto da quello spirito avven
turiero, proprio degli uomini colti del suo secolo,
intraprese de’ viaggi. Sotto questo aspetto egli appar
tiene a quel tipo di avventuriere di cui fu largo il
700,
avventuriere nel senso migliore di questo voca
bolo, come lo furono il Baretti, il Goldoni, l’Alga-
rotti, il Pepoli e l’Altìeri. E de’ suoi viaggi dà con
tezza nelle sue lettere. Così sappiamo di un suo viaggio
nella primavera del 1768 a Firenze, viaggio da lui
intrapreso per guarire da un suo vano amore. Un altro
viaggio fece nel 1755, a Torino. In una sua lettera a
Girolamo Kenier del 21 luglio conosciamo le impres
sioni del suo primo viaggio. «Del mio viaggio —
egli scrive — le dirò qualche cosa. Io sono stato
venti giorni in Bologna, la quale città non mi è mai
piaciuta tanto come adesso. È veramente la sede
delle lettere, delle scienze e della cortesia!. Par di
sentire il Leopardi che tre quarti di secolo dopo
dava di Bologna un identico giudizio: t ... sono stato
contentissimo di fermarmi qui in Bologna, città
quietissima, allegrissima, ospitalissima, dove ho tro
vato molte buone accoglienze » (5).
Più innanzi il Duranti continua: • Passai poi
1
Appennino, e stetti otto giorni in Firenze, che mi
parvero ore. Non ho mai visto a ’ miei di cosa più
bella. Mi perdonino Roma e Napoli e dico anche Ve
nezia, se io dico che Firenze è la città più bella d’Italia.
Io non mi potea saziare nè contenermi di non lodar
sempre la natura e il sito e l'arte che paiono gareg
giar insieme. Le ville e i giardini sparsi qua e là vin
cono Tempe e Orti delle Esperidi... Nulla dirò poi
della bellezza delle donne e della cortesia dei cava
lieri, insomma io non finirei mai parlando della
Toscana. Ritornando a Brescia presi la via di Fer
rara per visitare l’onorata tomba del divino Ariosto...
In Firenze mi fu dato luogo fra quelle celebratissime
accademie. Ma Dio sa come vi sto » (6).
Nel 1755 si recò nella capitale del Piemonte per
presentare di persona le sue
Rime
a Carlo Emanuele
al quale le volle dedicate. Coi tipi di Gian Maria
Rizzardi, che buon posto occupa negli annali tipo
grafici bresciani, aveva appunto in quell’anno il
Duranti pubblicati in elegante e nitida edizione i
suoi versi preceduti da una lettera dedicatoria al
Re di Sardegna, adornando la pubblicazione non
solo del ritratto suo, ma ancora di quello del re.
Delle accoglienze fatte al Duranti da Carlo Ema
nuele si sa dalla prima epistola delle sue
Rime
indi
rizzata al suo amico Giammaria Montorfani e dalla
lettera che lo stesso amico di Torino scriveva: «Il
Duranti faceva in questa corte una figura la più co
spicua, la più nobile che possa immaginarsi giammai...
Viene ogni giorno trattato a pranzo dagli ambascia-
tori delle corti estere, o dai Ministri di Corte, o dalla
primaria nobiltà. Il libro presentato al Re viene uni
versalmente portato alle stelle... ».
Carlo Emanuele III si servì dell’opera del suo
gentiluomo di camera il Conte Duranti per inviarlo
presso l’infante di Parma per ringraziarlo di avergli
a sua volta inviato il Duca Scipione Grillo in occa
sione delle nozze del Conte di Provenza con- la Prin
cipessa Giuseppina di Savoia. Ma questo non era
che lo scopo apparente della missione; in realtà
il
governo Sardo desiderava delle informazioni esatte
e precise «sul reale Stato della Corte di Parma »
e chiedeva al suo inviato straordinario «una rela
zione circostanziata » (7).
E il Duranti compì con zelo e intelligenza la sua
missione diplomatica, ritornando a Torino non con
una, ma con tre relazioni (8) le quali non erano
stese per « privati », nè per la «cognizione degli
uomini ».
* • •
In quel tempo Brescia aveva perduto A. M. Qui-
rini: il Montorfani cerca di consolarsi pensando che
Brescia conservava però il Duranti • dottissimo cit
tadino ornato delle doti più cospicue, amato e ben
accolto dai principi, che a ragione può dirsi lo splen
dore della patria » (9).
Il Duranti fa alcuni anni innanzi anche a Ve
nezia, come ci ricorda nell’ottava epistola al conte
Carlo Calino:
Fortuna dopo sui Veneti bdi.
Molte hme mi tenne, e porre in bando'
Mi le' gii stadi..
E fu a Venezia che in un duello gli accadde un
tragico evento: uccide il suo avversario, per il che
deve scontare la pena in carcere. Questa sua pri
gionia, che a quanto sembra non fu nè lunga nè dolo
rosa, di cui abbiamo notizie in certe lettere defl’Ar-
chivio di Brescia (10), avvenne fra fl 1750-1752. In


















