
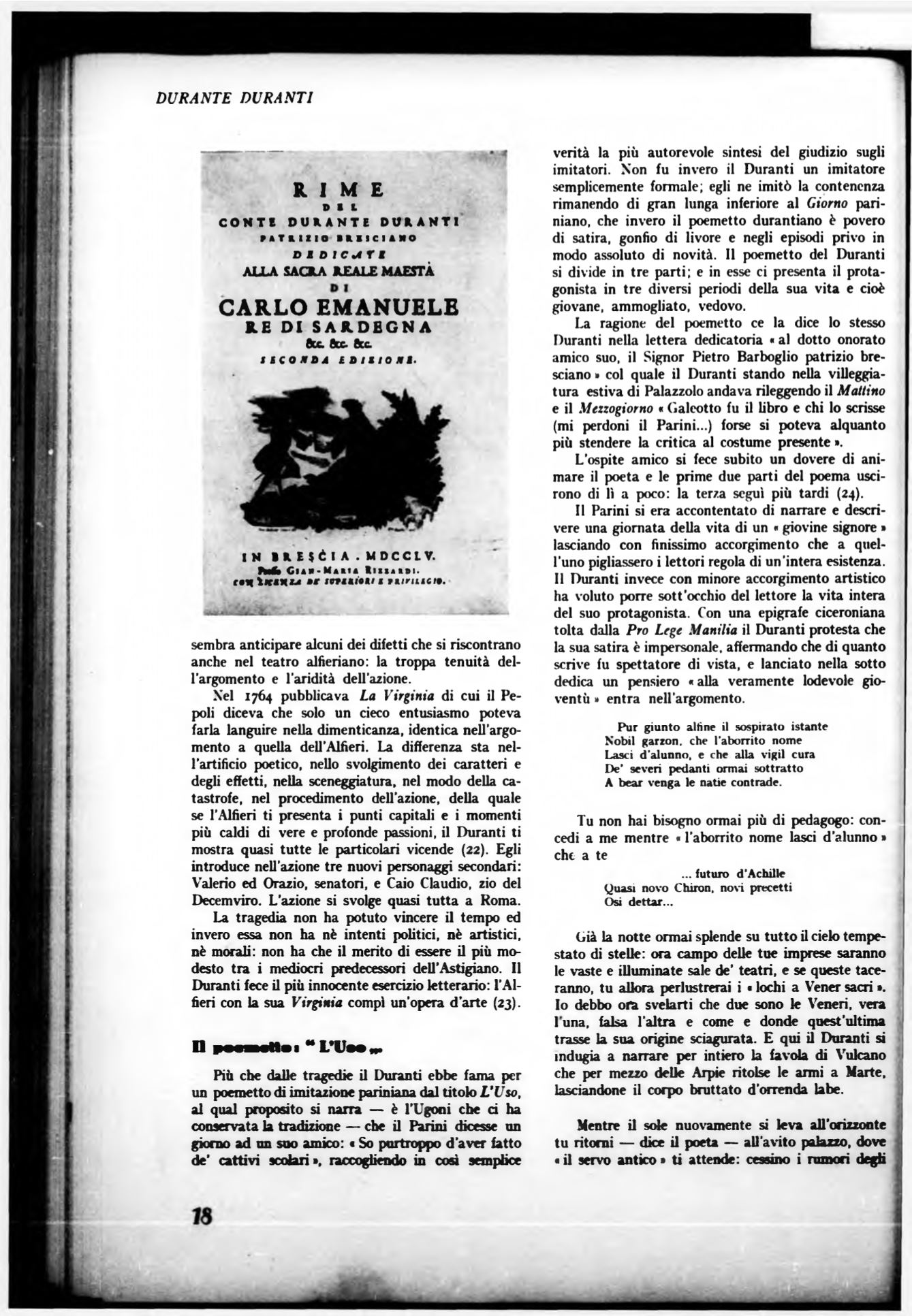
DURANTE DURANT I
R I M E
D I I
C O N T E D U R A N T E D U R A N T I
PATRIZIO I I I IC I ÀNO
D E D I C J t T t
ALLA
SACRA REALE MAESTÀ
C A R L O EM ANU E L E
R E D I S A R D E G N A
0u.0cc.8cc.
S E C O M D A £ D I X I O M I .
IN • R E $ é I A . MDC C L V .
M C iii-M tit< K it iiiii.
roif Ì k i k u
ù
r
miniati t rniruicio.
sembra anticipare alcuni dei difetti che si riscontrano
anche nel teatro alfieriano: la troppa tenuità del
l'argomento e l ’aridità dell’azione.
Xel 1764 pubblicava
La Virginia
di cui il Pe-
poli diceva che solo un cieco entusiasmo poteva
farla languire nella dimenticanza, identica nell’argo
mento a quella dell’Alfieri. La differenza sta nel
l ’artificio poetico, nello svolgimento dei caratteri e
degli effetti, nella sceneggiatura, nel modo della ca
tastrofe, nel procedimento dell’azione, della quale
se l’Alfieri ti presenta i punti capitali e i momenti
più caldi di vere e profonde passioni, il Duranti ti
mostra quasi tutte le particolari vicende (22). Egli
introduce nell’azione tre nuovi personaggi secondari:
Valerio ed Orazio, senatori, e Caio Claudio, zio del
Decemviro. L ’azione si svolge quasi tutta a Roma.
La tragedia non ha potuto vincere il tempo ed
invero essa non ha nè intenti politici, nè artistici,
nè morali: non ha che il merito di essere il più mo
desto tra i mediocri predecessori dell’Astigiano. Il
Duranti fece il più innocente esercizio letterario: l’Al-
fieri con la sua
Virginia
compì un’opera d ’arte (23).
I l p o c a c H o i ML’ II
n n
.
Più che dalle tragedie il Duranti ebbe fama per
un poemetto di imitazione pariniana dal titolo
L ’ Uso,
al qual proposito si narra — è l'Ugoni che d ha
conservata la tradizione — che il Parini dicesse un
giorno ad un suo amico: «So purtroppo d'aver fatto
de’ cattivi scolari », raccogliendo in così semplice
verità la più autorevole sintesi del giudizio sugli
imitatori. Non fu invero il Duranti un imitatore
semplicemente formale; egli ne imitò la contenenza
rimanendo di gran lunga inferiore al
Giorno
pari-
niano, che invero il poemetto durantiano è povero
di satira, gonfio di livore e negli episodi privo in
modo assoluto di novità. Il poemetto del Duranti
si divide in tre parti; e in esse ci presenta il prota
gonista in tre diversi periodi della sua vita e cioè
giovane, ammogliato, vedovo.
La ragione del poemetto ce la dice lo stesso
Duranti nella lettera dedicatoria «al dotto onorato
amico suo, il Signor Pietro Barboglio patrizio bre
sciano » col quale il Duranti stando nella villeggia
tura estiva di Palazzolo andava rileggendo il
Mattino
e il
Mezzogiorno
«Galeotto fu il libro e chi lo scrisse
(mi perdoni il Parini...) forse si poteva alquanto
più stendere la critica al costume presente ».
L’ospite amico si fece subito un dovere di ani
mare il poeta e le prime due parti del poema usci
rono di lì a poco: la terza seguì più tardi (24).
Il Parini si era accontentato di narrare e descri
vere una giornata della vita di un «giovine signore »
lasciando con finissimo accorgimento che a quel
l'uno pigliassero i lettori regola di un’intera esistenza.
Il Duranti invece con minore accorgimento artistico
ha voluto porre sott 'occhio del lettore la vita intera
del suo protagonista. Con una epigrafe ciceroniana
tolta dalla
Pro Lege Manilia
il Duranti protesta che
la sua satira è impersonale, affermando che di quanto
scrive fu spettatore di vista, e lanciato nella sotto
dedica un pensiero «alla veramente lodevole gio
ventù » entra nell'argomento.
Pur giunto aitine il sospirato istante
Nobil garzon. che l’aborrito nome
Lasci d'alunno, e che alla vigil cura
De’ severi pedanti ormai sottratto
A bear venga le natie contrade.
Tu non hai bisogno ormai più di pedagogo: con
cedi a me mentre «l’aborrito nome lasci d ’alunno »
che a te
... futuro d’Achille
Quasi novo Chiron, novi precetti
Osi dettar...
Già la notte ormai splende su tutto il cielo tempe
stato di stelle: ora campo delle tue imprese saranno
le vaste e illuminate sale de’ teatri, e se queste tace
ranno, tu allora perlustrerai i • lochi a Vener sacri ».
Io debbo ora svelarti che due sono le Veneri, vera
l una, falsa l'altra e come e donde quest'ultima
trasse la sua origine sciagurata. E qui il Duranti si
indugia a narrare per intiero la favola di Vulcano
che per mezzo delle Arpie ritolse le armi a Marte,
lasciandone il corpo bruttato d’orrenda labe.
Mentre il sole nuovamente si leva all’orizzonte
tu ritorni — dice il poeta — all’avito palazzo, dove
«il servo antico • ti attende: cessino i rumori degli


















