
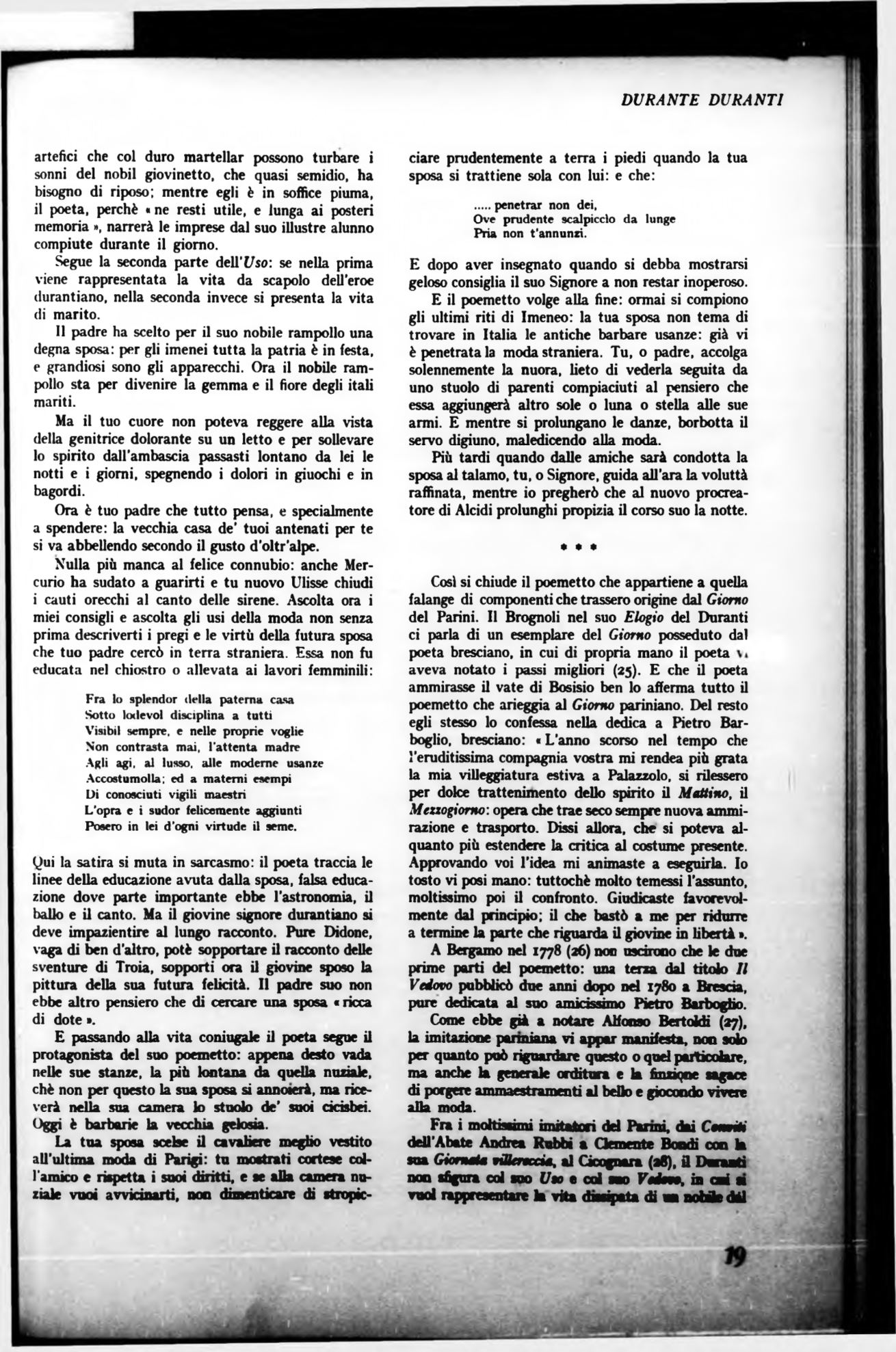
DURANTE DURANT I
artefici che col duro martellar possono turbare i
sonni del nobil giovinetto, che quasi semidio, ha
bisogno di riposo; mentre egli è in soffice piuma,
il poeta, perchè «ne resti utile, e lunga ai posteri
memoria », narrerà le imprese dal suo illustre alunno
compiute durante il giorno.
Segue la seconda parte dell’
Uso:
se nella prima
viene rappresentata la vita da scapolo dell’eroe
durantiano, nella seconda invece si presenta la vita
di marito.
Il padre ha scelto per il suo nobile rampollo una
degna sposa: per gli imenei tutta la patria è in festa,
e grandiosi sono gli apparecchi. Ora il nobile ram
pollo sta per divenire la gemma e il fiore degli itali
mariti.
Ma il tuo cuore non poteva reggere alla vista
della genitrice dolorante su un letto e per sollevare
lo spirito dall’ambascia passasti lontano da lei le
notti e i giorni, spegnendo i dolori in giuochi e in
bagordi.
Ora è tuo padre che tutto pensa, e specialmente
a spendere: la vecchia casa de’ tuoi antenati per te
si va abbellendo secondo il gusto d’oltr’alpe.
Nulla più manca al felice connubio: anche Mer
curio ha sudato a guarirti e tu nuovo Ulisse chiudi
i cauti orecchi al canto delle sirene. Ascolta ora i
miei consigli e ascolta gli usi della moda non senza
prima descriverti i pregi e le virtù della futura sposa
che tuo padre cercò in terra straniera. Essa non fu
educata nel chiostro o allevata ai lavori femminili:
Fra lo splendor della patema casa
Sotto lodevol disciplina a tutti
Visibil sempre, e nelle proprie voglie
Non contrasta mai, l'attenta madre
Agli agi, al lusso, alle moderne usanze
Accostumolla; ed a materni esempi
Di conosciuti vigili maestri
L’opra e i sudor felicemente aggiunti
Posero in lei d’ogni virtude il seme.
(Jui la satira si muta in sarcasmo: il poeta traccia le
linee della educazione avuta dalla sposa, falsa educa
zione dove parte importante ebbe l ’astronomia, il
ballo e il canto. Ma il giovine signore durantiano si
deve impazientire al lungo racconto. Pure Didone,
vaga di ben d’altro, potè sopportare il racconto delle
sventure di Troia, sopporti ora il giovine sposo la
pittura della sua futura felicità. Il padre suo non
ebbe altro pensiero che di cercare una sposa «ricca
di dote ».
E passando alla vita coniugale il poeta segue il
protagonista del suo poemetto: appena desto vada
nelle sue stanze, la più lontana da quella nuziale,
chè non per questo la sua sposa si annoterà, ma rice
verà nella sua camera lo stuolo de' suoi cicisbei.
Oggi è barbarie la vecchia gelosia.
La tua sposa scelse il cavaliere meglio vestito
all’ultima moda di Parigi: tu mostrati cortese col
l’amico e rispetta i suoi diritti, e se alla camera nu
ziale vuoi avvicinarti, non dimenticare di stropic
ciare prudentemente a terra i piedi quando la tua
sposa si trattiene sola con lui: e che:
.... penetrar non dei,
Ove prudente scalpiccio da lunge
Pria non t'annunzi.
E dopo aver insegnato quando si debba mostrarsi
geloso consiglia il suo Signore a non restar inoperoso.
E il poemetto volge alla fine: ormai si compiono
gli ultimi riti di Imeneo: la tua sposa non tema di
trovare in Italia le antiche barbare usanze: già vi
è penetrata la moda straniera. Tu, o padre, accolga
solennemente la nuora, lieto di vederla seguita da
uno stuolo di parenti compiaciuti al pensiero che
essa aggiungerà altro sole o lima o stella alle sue
armi. E mentre si prolungano le danze, borbotta il
servo digiuno, maledicendo alla moda.
Più tardi quando dalle amiche sarà condotta la
sposa al talamo, tu, o Signore, guida all’ara la voluttà
raffinata, mentre io pregherò che al nuovo procrea
tore di Alcidi prolunghi propizia il corso suo la notte.
* * *
Così si chiude il poemetto che appartiene a quella
falange di componenti che trassero origine dal
Giorno
del Parini. Il Brognoli nel suo
Elogio
del Duranti
ci parla di un esemplare del
Giorno
posseduto dal
poeta bresciano, in cui di propria mano il poeta
aveva notato i passi migliori (25). E che il poeta
ammirasse il vate di Bosisio ben lo afferma tutto il
poemetto che arieggia al
Giorno
pariniano. Del resto
egli stesso lo confessa nella dedica a Pietro Bar-
boglio, bresciano: «L ’anno scorso nel tempo che
l’eruditissima compagnia vostra mi rendea più grata
la mia villeggiatura estiva a Palazzolo, si rilessero
per dolce trattenimento dello spirito il
Mattino,
il
Mezzogiorno:
opera che trae seco sempre nuova ammi
razione e trasporto. Dissi allora, che si poteva al
quanto più estendere la critica al costume presente.
Approvando voi l ’idea mi animaste a eseguirla. Io
tosto vi posi mano: tuttoché molto temessi l’assunto,
moltissimo poi il confronto. Giudicaste favorevol
mente dal principio; il che bastò a me per ridurre
a termine la parte che riguarda il giovine in libertà ».
A Bergamo nel 1778 (26) non uscirono che le due
prime parti del poemetto: una terza dal titolo
II
Vedovo
pubblicò due anni dopo nel 1780 a Brescia,
pure dedicata al suo amicissimo Pietro Barbogio.
Come ebbe già a notare Alfonso Bertoldi (27),
la imitazione permiana vi appar manifesta, non solo
per quanto può riguardare questo o quel particolare,
ma anche la generale orditura e la finzione sagace
di porgere ammaestramenti al bello e giocondo vivere
alla moda.
Fra i moltissimi imitatori del Pum i, dai
Conviti
dell’Abate Andrea Rubbi a Clemente Boodi con la
sua
Giornata villereccia.
al Cicogna» (28), fl Duranti
non sfigura col suo
Uso
e col suo
Vaiavo,
in cui «
vuol rappresentare la vita dnsipata di un nobile d ii


















