
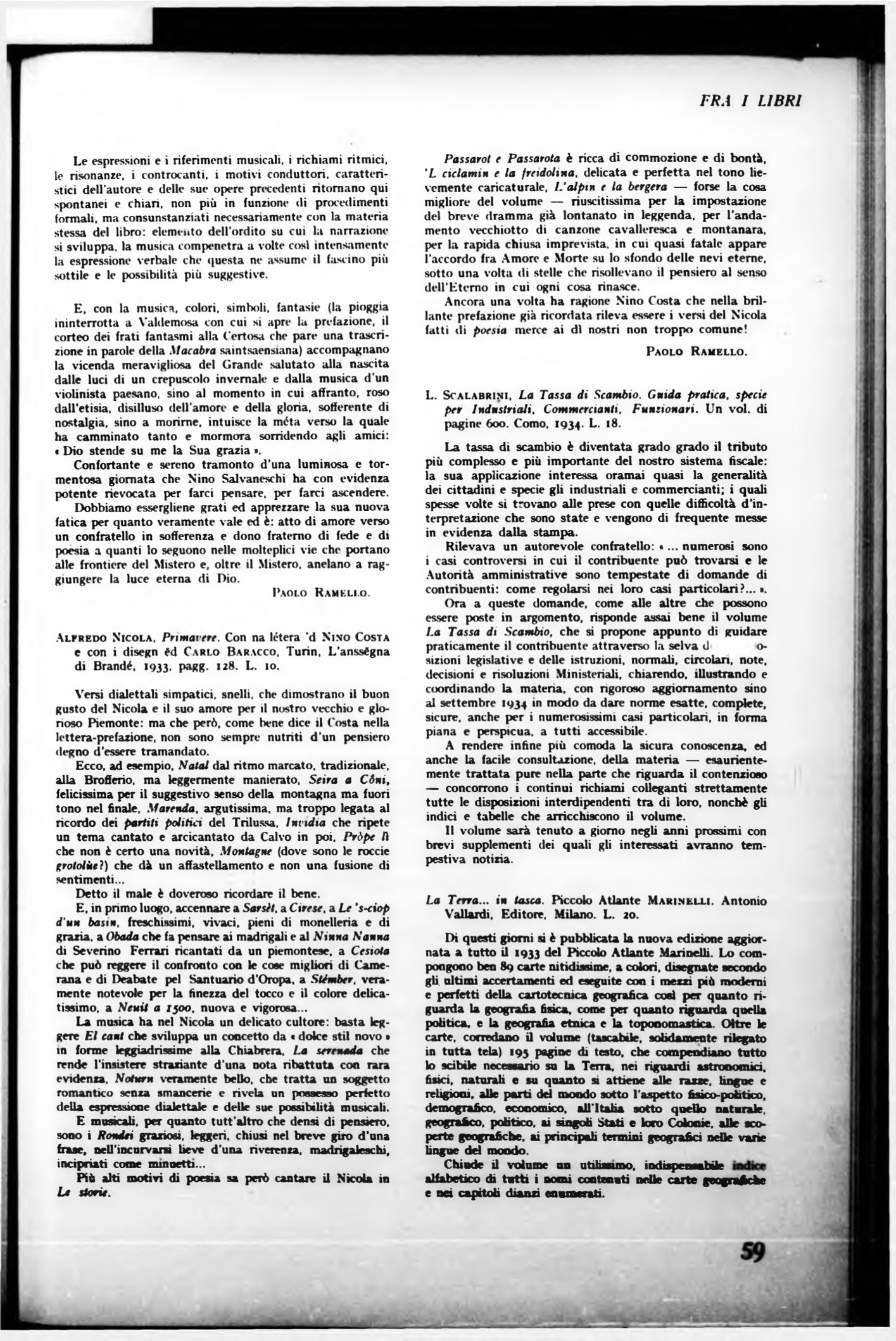
F R A I L I B R I
Le espressioni e i riferimenti musicali, i richiami ritmici,
le risonanze, i controcanti, i motivi conduttori, caratteri
stici dell'autore e delle sue opere precedenti ritornano qui
spontanei e chiari, non più in funzione di procedimenti
(ormali, ma consunstanziati necessariamente con la materia
stessa del libro: elemento dell’ordito su cui la narrazione
si sviluppa, la musica compenetra a volte cosi intensamente
la espressione verbale che questa ne assume il fascino piii
sottile e le possibilità più suggestive.
E , con la musica, colori, simboli, fantasie (la pioggia
ininterrotta a Yaldemosa con cui si apre la prefazione, il
corteo dei frati fantasmi alla Certosa che pare una trascri
zione in parole della
Macabra
saintsaensiana) accompagnano
la vicenda meravigliosa del Grande salutato alla nascita
dalle luci di un crepuscolo invernale e dalla musica d ’un
violinista paesano, sino al momento in cui affranto, roso
dall’etisia, disilluso dell’amore e della gloria, sofferente di
nostalgia, sino a morirne, intuisce la méta verso la quale
ha camminato tanto e mormora sorridendo agli amici:
• Dio stende su me la Sua grazia >.
Confortante e sereno tramonto d’una luminosa e tor
mentosa giornata che Nino Salvaneschi ha con evidenza
potente rievocata per farci pensare, per farci ascendere.
Dobbiamo essergliene grati ed apprezzare la sua nuova
fatica per quanto veramente vale ed è: atto di amore verso
un confratello in sofferenza e dono fraterno di fede e di
poesia a quanti lo seguono nelle molteplici vie che portano
alle frontiere del Mistero e, oltre il Mistero, anelano a rag
giungere la luce eterna di Dio.
P
a o lo
K
a m k l i
.
o
.
A lfr e d o N ic o la .
Primavere.
Con na létera ’d
N in o C o s ta
e con i disegn éd
C a r lo B a ra c c o ,
Turin, L'ansségna
di Brandé, 1933, pagg. 128. L. 10.
Versi dialettali simpatici, snelli, che dimostrano il buon
gusto del Nicola e il suo amore per il nostro vecchio e glo
rioso Piemonte: ma che però, come bene dice il Costa nella
lettera-prefazione, non sono sempre nutriti d ’un pensiero
degno d ’essere tramandato.
Ecco, ad esempio,
Notai
dal ritmo marcato, tradizionale,
alla Brofferio, ma leggermente manierato,
Seira a Còtti,
felicissima per il suggestivo senso della montagna ma fuori
tono nel finale.
Morendo,
argutissima, ma troppo legata al
ricordo dei
portili politici
del Trilussa,
Invidia
che ripete
un tema cantato e arcicantato da Calvo in poi,
Pròpe lì
che non è certo una novità,
Montagne
(dove sono le roccie
grotolùe})
che dà un affastellamento e non una fusione di
sentimenti...
Detto il male è doveroso ricordare il bene.
E, in primo luogo, accennare a
Sarstt,
a
Cirése,
a
Le ’s-ciop
d'uM basi»,
freschissimi, vivaci, pieni di monelleria e di
grazia, a
Oboda
che fa pensare ai madrigali e al
Ninna Nanna
di Severino Ferrari ricantati da un piemontese, a
Cesiota
che può reggere il confronto con le cose migliori di Carne-
rana e di Deabate pel Santuario d ’Oropa, a
Stfmber,
vera
mente notevole per la finezza del tocco e il colore delica
tissimo. a
Neuit a 1500,
nuova e vigorosa...
La musica ha nel Nicola un delicato cultore: basta leg
gere
E l cani
che sviluppa un concetto da «dolce stil novo »
in forme leggiadrissime alla Chiabrera,
Lo serenodo
che
rende l’insistere straziante d'una nota ribattuta con rara
evidenza.
Noturn
veramente bello, che tratta un soggetto
romantico senza smancerie e rivela un possesso perfetto
della espressione dialettale e delle sue possibilità musicali.
E musicali, per quanto tutt'altro che densi di pensiero,
sono i
Rondei
graziosi, leggeri, chiusi nel breve giro d'una
frase, nell'incurvarsi lieve d ’una riverenza, madrigaleschi,
incipriati come minuetti...
Più alti motivi di poesia sa però cantare il Nicola in
L t storie.
Passarot e Passarota
è ricca di commozione e di bontà,
'L ciclamin e la freidolina,
delicata e perfetta nel tono lie
vemente caricaturale,
L ’alpin e la bergera
— forse la cosa
migliore del volume — riuscitissima per la impostazione
del breve dramma già lontanato in leggenda, per l'anda
mento vecchiotto di canzone cavalleresca e montanara,
per la rapida chiusa imprevista, in cui quasi fatale appare
l’accordo fra Amore e Morte su lo sfondo delle nevi eterne,
sotto una volta di stelle che risollevano il pensiero al senso
deU’Etemo in cui ogni cosa rinasce.
Ancora una volta ha ragione Nino Costa che nella bril
lante prefazione già ricordata rileva essere i versi del Nicola
fatti di
poesia
merce ai di nostri non troppo comune!
P
a o lo
R
a m e l l o
.
L.
S c a la b r in i,
La Tassa di Scambio. Guida pratica, specie
per Industriali, Commercianti, Funzionari.
Un voi. di
pagine 600. Como. 1934. L. 18.
L a tassa di scambio è diventata grado grado il tributo
più complesso e più importante del nostro sistema fiscale:
la sua applicazione interessa oramai quasi la generalità
dei cittadini e specie gli industriali e commercianti; i quali
spesse volte si trovano alle prese con quelle difficoltà d'in
terpretazione che sono state e vengono di frequente messe
in evidenza dalla stampa.
Rilevava un autorevole confratello: «... numerosi sono
i casi controversi in cui il contribuente può trovarsi e le
Autorità amministrative sono tempestate di domande di
contribuenti: come regolarsi nei loro casi particolari?... ».
Ora a queste domande, come alle altre che possono
essere poste in argomento, risponde assai bene il volume
La Tassa di Scambio,
che si propone appunto di guidare
praticamente il contribuente attraverso la selva d
o-
sizioni legislative e delle istruzioni, normali, circolari, note,
decisioni e risoluzioni Ministeriali, chiarendo, illustrando e
coordinando la materia, con rigoroso aggiornamento sino
al settembre 1934 ln modo da dare norme esatte, complete,
sicure, anche per i numerosissimi casi particolari, in forma
piana e perspicua, a tutti accessibile.
A rendere infine più comoda la sicura conoscenza, ed
anche la facile consultazione, della materia — esauriente
mente trattata pure nella parte che riguarda il contenzioso
— concorrono i continui richiami colleganti strettamente
tutte le disposizioni interdipendenti tra di loro, nonché gli
indici e tabelle che arricchiscono il volume.
11
volume sarà tenuto a giorno negli anni prossimi con
brevi supplementi dei quali gli interessati avranno tem
pestiva notizia.
La Terrò...
in
tasca.
Piccolo Atlante
M a r in e lli.
Antonio
Vallardi, Editore, Milano. L. 20.
Di questi giorni si è pubblicata la nuova edizione aggior
nata a tutto il 1933 del Piccolo Atlante Marinelli. Lo com
pongono ben 89 carte nitidissime, a colori, disegnate secondo
gli. aitimi accertamenti ed eseguite con i mezzi più moderni
e perfetti della cartotecnica geografica così per quanto ri
guarda la geografia fisica, come per quanto riguarda quella
politica, e la geografia etnica e la toponomastica. Oltre le
carte, corredano il volume (tascabile, solidamente rilegato
in tutta tela) 195 pagine di testo, che compendiano tatto
lo scibile necessario su la Terra, nei riguardi astronomici,
fisici, naturali e su quanto si attiene alle razze, lingue e
religioni, alle parti del mondo sotto l’aspetto fisico-politico,
demografico, economico. all'Italia sotto quello naturale,
geografico, politico, ai singoli Stati e loro Colonie, alle sco
perte geografiche, ai principali termini geografici nelle varie
lingue del mondo.
Chiude il volume un utilissimo, indispensabile
alfabetico di tatti i nomi contenati nelle carte
geograjkbe
e nei capitoti dianzi enumerati.


















